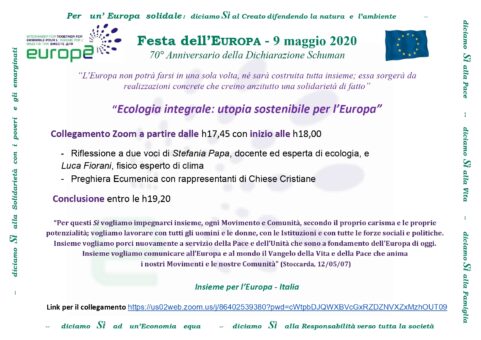15 Lug 2020 | Sociale
I giovani dei Focolari hanno iniziato la nuova campagna #daretocare per prendersi cura delle nostre società e del pianeta Terra ed essere cittadini attivi per cercare di costruire un pezzetto di mondo unito. L’intervista a Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze in Italia.  Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze (Italia), per molti anni si è dedicata come ricercatrice al tema della cura. È intervenuta durante il primo live streaming #daretocare dei giovani del Movimento dei Focolari il 20 giugno scorso. L’esperienza della pandemia che stiamo attraversando che impatto ha avuto sulla sua visione della cura? “Mi sembra soprattutto che sia emersa un’immagine di cura come assistenza – ha spiegato la Pulcini -. Pensiamo a tutto il personale medico e sanitario. Questo ha risvegliato elementi positivi, passioni che sono state in qualche modo dimenticate, come la gratitudine, la compassione, il sentimento della nostra vulnerabilità. E questo è stato molto positivo perché ne abbiamo davvero bisogno ed è necessario risvegliare quelle che chiamo passioni empatiche. Allo stesso tempo, tuttavia, la cura è rimasta un po’ chiusa all’interno di un significato essenzialmente assistenziale, ciò che in inglese è chiamato “cure” e non “care”. La cura deve diventare un modo di vivere”. Ci piace sognare una società in cui la cura sia l’asse portante dei sistemi politici locali e globali. È un’utopia o è realizzabile? “Sicuramente la cura significa rispondere a qualcosa. In questo caso vuole dire rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Dal momento in cui realizzo questo e non sono chiuso nel mio individualismo si produce una capacità che abbiamo dentro di noi che è l’empatia, cioè mettersi nei panni dell’altro. Ma chi è l’altro oggi? Ecco, stanno emergendo nuove figure di ciò che consideriamo l’altro per noi. Quindi l’altro oggi è il diverso, sono anche le generazioni future, è anche la natura, l’ambiente, la Terra che ci ospita. Dunque la cura diventa davvero la risposta complessiva alle grandi sfide del nostro tempo, se la sappiamo ritrovare attraverso la capacità empatica di relazionarci con l’altro. Quindi non so se sia davvero realizzabile ma penso che non possiamo perdere la prospettiva utopica. Non basta la responsabilità, c’è bisogno di coltivare anche la speranza”. Quali suggerimenti ci daresti per agire in tal senso e orientare alla cura le nostre società a partire dalle istituzioni? “Credo che dobbiamo agire in tutti i luoghi in cui noi operiamo per far uscire la cura dall’ambito ristretto della sfera privata. (…) Io mi devo pensare come un soggetto di cura nella mia famiglia, nella mia professione di docente, quando incontro un povero emarginato per strada o quando vado a fare il bagno in spiaggia, devo prendermi cura di tutte le dimensioni. Dobbiamo adottare la cura come stile di vita in grado di spezzare il nostro individualismo illimitato che sta portando non solo l’autodistruzione dell’umanità, ma anche la distruzione del mondo vivente. Pertanto, dobbiamo cercare di rispondere con la cura alle patologie della nostra società, il che vuol dire educare alla democrazia. Io ho molto amato un filosofo dell’ottocento che si chiama Alexis de Tocqueville, il quale diceva che “dobbiamo educare alla democrazia”. È una lezione ancora tutta da imparare e credo che questo significhi coltivare le proprie emozioni empatiche in modo da essere stimolati alla cura con piacere, con gratificazione, non con costrizione”.
Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze (Italia), per molti anni si è dedicata come ricercatrice al tema della cura. È intervenuta durante il primo live streaming #daretocare dei giovani del Movimento dei Focolari il 20 giugno scorso. L’esperienza della pandemia che stiamo attraversando che impatto ha avuto sulla sua visione della cura? “Mi sembra soprattutto che sia emersa un’immagine di cura come assistenza – ha spiegato la Pulcini -. Pensiamo a tutto il personale medico e sanitario. Questo ha risvegliato elementi positivi, passioni che sono state in qualche modo dimenticate, come la gratitudine, la compassione, il sentimento della nostra vulnerabilità. E questo è stato molto positivo perché ne abbiamo davvero bisogno ed è necessario risvegliare quelle che chiamo passioni empatiche. Allo stesso tempo, tuttavia, la cura è rimasta un po’ chiusa all’interno di un significato essenzialmente assistenziale, ciò che in inglese è chiamato “cure” e non “care”. La cura deve diventare un modo di vivere”. Ci piace sognare una società in cui la cura sia l’asse portante dei sistemi politici locali e globali. È un’utopia o è realizzabile? “Sicuramente la cura significa rispondere a qualcosa. In questo caso vuole dire rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Dal momento in cui realizzo questo e non sono chiuso nel mio individualismo si produce una capacità che abbiamo dentro di noi che è l’empatia, cioè mettersi nei panni dell’altro. Ma chi è l’altro oggi? Ecco, stanno emergendo nuove figure di ciò che consideriamo l’altro per noi. Quindi l’altro oggi è il diverso, sono anche le generazioni future, è anche la natura, l’ambiente, la Terra che ci ospita. Dunque la cura diventa davvero la risposta complessiva alle grandi sfide del nostro tempo, se la sappiamo ritrovare attraverso la capacità empatica di relazionarci con l’altro. Quindi non so se sia davvero realizzabile ma penso che non possiamo perdere la prospettiva utopica. Non basta la responsabilità, c’è bisogno di coltivare anche la speranza”. Quali suggerimenti ci daresti per agire in tal senso e orientare alla cura le nostre società a partire dalle istituzioni? “Credo che dobbiamo agire in tutti i luoghi in cui noi operiamo per far uscire la cura dall’ambito ristretto della sfera privata. (…) Io mi devo pensare come un soggetto di cura nella mia famiglia, nella mia professione di docente, quando incontro un povero emarginato per strada o quando vado a fare il bagno in spiaggia, devo prendermi cura di tutte le dimensioni. Dobbiamo adottare la cura come stile di vita in grado di spezzare il nostro individualismo illimitato che sta portando non solo l’autodistruzione dell’umanità, ma anche la distruzione del mondo vivente. Pertanto, dobbiamo cercare di rispondere con la cura alle patologie della nostra società, il che vuol dire educare alla democrazia. Io ho molto amato un filosofo dell’ottocento che si chiama Alexis de Tocqueville, il quale diceva che “dobbiamo educare alla democrazia”. È una lezione ancora tutta da imparare e credo che questo significhi coltivare le proprie emozioni empatiche in modo da essere stimolati alla cura con piacere, con gratificazione, non con costrizione”.
A cura dei giovani dei Focolari
(altro…)
3 Lug 2020 | Sociale
La Presidente della Commissione Europea risponde alla lettera con la quale New Humanity e il Movimento Politico per l’Unità, espressioni civile e politica del Movimento dei Focolari, domandano ai rappresentanti politici europei di stringere un “patto di fraternità” che li impegni a considerarsi membri della patria europea come di quella nazionale, trovando insieme le soluzioni che ancora si frappongono all’unità europea.
“Per raggiungere gli obiettivi dei padri e delle madri che fondarono una vera alleanza in cui la fiducia reciproca diventa forza comune, dobbiamo fare le cose giuste insieme e con un solo grande cuore, non con 27 piccoli cuori”. Così Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, in una lettera a New Humanity, ONG internazionale e al Movimento Politico per l’Unità (MPPU) dei Focolari. I responsabili della ONG New Humanity e della sua sezione politica MPPU, componenti civile e politica del Movimento dei Focolari, avevano infatti scritto alla Presidente della Commissione Europea per incoraggiare il lavoro comune per affrontare l’impatto della pandemia COVID-19 e per garantire il supporto di idee e progettualità anche nella fase della costruzione della Conferenza sul futuro dell’Europa: “L’unità politica, economica, sociale e culturale dell’Unione Europea sarà la risposta storica e geo-politica globale all’altezza della sfida possente della pandemia del 2020”.
Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea dal 1 dicembre 2019, ha sottolineato nella risposta come l’Unione Europea abbia garantito la più grande risposta mai data a una situazione di crisi e di emergenza nell’Unione, con la mobilitazione di 3.4 trilioni.
La Presidente ha anche affermato che “l’attuale cambiamento del contesto geopolitico offre all’Europa l’opportunità di rafforzare il suo ruolo unico di leadership globale responsabile” il cui successo “dipenderà dall’adattarsi in questa epoca di disgregazione rapida e di sfide crescenti, al mutare della situazione, rimanendo però fedele ai valori e agli interessi dell’Europa”.
L’Europa, infatti, sottolinea nella lettera la Presidente, “è il principale erogatore di aiuti pubblici allo sviluppo, con 75,2 miliardi di euro nel 2019. Nella sua risposta globale alla lotta contro la pandemia, l’Unione Europea si è impegnata a garantire anche un sostegno finanziario ai Paesi partner per un importo superiore a euro 15,6 miliardi, a disposizione per l’azione esterna. Ciò include 3,25 miliardi di euro verso l’Africa. L’UE sosterrà anche l’Asia e il Pacifico con 1,22 miliardi di euro, 918 milioni di euro a sostegno di America Latina e Caraibi e 111 milioni di euro a sostegno dei paesi d’oltremare”. Inoltre, prosegue la Presidente della Commissione UE, “l’Unione Europea e i suoi partner hanno lanciato il Coronavirus Global Response, che registra finora impegni per 9.8 miliardi di euro da donatori in tutto il mondo, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il finanziamento per lo sviluppo della ricerca, diagnosi, trattamenti e vaccini contro il Coronavirus”.
La lettera della Presidente Ursula Von der Leyen si conclude con l’invito ad una collaborazione stretta fra i paesi dell’Unione Europea: “Dobbiamo sostenerci in questi tempi difficili e poter contare gli uni sugli altri per far fronte al nostro nemico invisibile”.
Stefania Tanesini
(altro…)
16 Giu 2020 | Sociale
C’è anche Maria Voce tra i firmatari dell’appello promosso dalla Comunità di Sant’Egidio per riumanizzare le nostre società. L’invito a diffonderlo e a firmare per richiamare l’attenzione sulla grave condizione degli anziani in seguito alle “stragi” operate dalla pandemia. No ad una sanità selettiva, no alla “cultura dello scarto”, no a qualsiasi espropriazione dei diritti dell’individuo; sì, invece, alla parità di trattamento e al diritto universale alle cure. “Il valore della vita rimanga uguale per tutti. Chi deprezza quella fragile debole dei più anziani, s prepara a svalutarle tutte”. E’ una cultura della vita senza sconti che l’appello internazionale “Senza anziani non c’è futuro, per ‘riumanizzare’ le nostre società – Contro una ‘sanità selettiva’” sostiene e ha rilanciato pochi giorni fa, il 15 giugno scorso, in occasione della Giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che Sant’Egidio ha celebrato in tutti i Paesi in cui è presente. Tra le molte adesioni eccellenti ci sono l’economista statunitense Jeffrey Sachs, la scrittrice italo-britannica Simonetta Agnello Hornby, il filosofo tedesco Jurgen Habermas, il sociologo spagnolo Manuel Castells e poi Stefania Giannini, direttore generale aggiunto UNESCO, oltre al fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, che è anche il primo firmatario. Anche la presidente dei Focolari ha aderito e firmato, invitando le comunità del movimento nel mondo a fare lo stesso, per richiamare l’attenzione, soprattutto dell’Europa, sulla condizione degli anziani. “Condivido quanto denunciato dall’appello e cioè l’emergere, di fronte alle drammatiche condizioni sanitarie che il Covid-19 ha portato allo scoperto, di un pericoloso modello che promuove una sanità selettiva che di fatto giustificherebbe la scelta di curare i più giovani, sacrificando gli anziani. Una società senza anziani non può dirsi tale; una società che non può beneficiare dell’indispensabile rapporto intergenerazionale è una società povera, monca, incapace di progettare e realizzare un futuro migliore per tutti, inclusivo, perché frutto di diversità che si incontrano”. “L’appello – si legge in una nota diffusa dalla Comunità di Sant’Egidio – nasce dall’amara constatazione del numero altissimo di vittime del Covid-19 tra la popolazione anziana, in particolare tra le persone presenti negli istituti e nelle case di riposo, e propone un radicale cambiamento di mentalità che porti a nuove iniziative sociali e sanitarie”. Un rapporto dell’Oms rilevava, già nel 2018, che proprio “nelle istituzioni i tassi di abuso sono molto più alti rispetto agli ambienti comunitari” e includono maltrattamenti vari tra cui “restrizioni fisiche, privazione della dignità, imposizione di esecuzione di faccende quotidiane, fornitura intenzionale di assistenza insufficiente, trascuratezza e abuso emotivo”. La situazione si è aggravata durante la pandemia da Covid-19 determinando, com’è noto, un altissimo tasso di vittime all’interno degli istituti, circa il doppio rispetto agli anziani che vivono in casa, secondo i dati in possesso dell’Istituto superiore di sanità. Per questo, nella Giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, il Movimento dei Focolari si è unito alla Comunità di Sant’Egidio, nel sostegno all’appello internazionale e alla promozione di una “rivolta morale perché si cambi direzione nella cura degli anziani”, riproponendo anche alle amministrazioni statali e locali la messa in atto di un sistema che privilegi la domiciliarità delle cure e dell’assistenza per la popolazione anziana.
Stefania Tanesini
Firma l’appello qui (altro…)

16 Giu 2020 | Sociale
Partirà il 20 giugno prossimo, in diretta mondiale YouTube, #daretocare, la campagna dei giovani dei Focolari per “farsi carico” delle nostre società e del pianeta. Jesùs Morán, co-presidente dei Focolari: “Occorre una nuova agenda etica; la cura ha una spiccata vocazione politica e una forte dimensione planetaria”.  “#daretocare”, ovvero “osare prendersi cura”. I giovani del Movimento dei Focolari hanno preso sul serio le parole di Papa Francesco e di molti altri leader religiosi e civili di collaborare concretamente alla cura della Casa Comune. Attraverso questo nuovo percorso vogliono quindi essere cittadini attivi e interessarsi a tutto quello che accade nel mondo per cercare di costruire un pezzetto di mondo unito. “In questo tempo di profonda crisi umanitaria, a causa del Coronavirus, sta emergendo una nuova visione – sostiene Jesús Morán, co-presiedente del Movimento dei Focolari – cioè la necessità di un nuovo modo di comportarsi, di vivere, una sorta di nuova agenda etica, come dicono alcuni esperti. E in questo contesto una categoria sta diventando centrale, ed è quella della cura, il farsi carico, l’occuparsi degli altri, della società, del pianeta”. Osare prendersi cura vuol dire quindi essere protagonisti nella vita di tutti i giorni per risolvere problemi, avviare dialoghi per una società migliore, essere attenti all’ambiente e alle persone di qualsiasi colore, religione, cultura. Soprattutto oggi dove il razzismo torna a riemergere, dove la libertà degli uomini torna ad essere minata da regimi totalitaristici, dove le armi e le guerre vogliono imporre il proprio dominio sulla pace e l’unità fra i popoli. “La cura è una categoria molto ampia, bella, poliedrica – continua Morán -. L’etica della cura ha a che fare con la dignità della persona, questo è fondamentale, è proprio il cuore della cura; non è una cosa intimistica, privata. Anzi, la cura ha una spiccata vocazione politica e una forte dimensione planetaria, anche se non dimentica il locale perché dopo, è localmente che ci prendiamo cura degli altri, è proprio nei rapporti personali, nella società, nel locale. Però questa dimensione planetaria è importante”. Papa Francesco ne ha parlato il 24 maggio scorso durante il quinto anniversario della Laudato sii, promuovendo un anno speciale di riflessione – fino al 24 maggio 2021 – per riportare all’attenzione di tutti il tema della cura del creato. E per creato si intende non solo l’ambiente che ci circonda, ma anche le persone, l’economia, la politica, il sociale… Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolari, definiva la politica come “l’amore degli amori”. Il politico è colui che sta al servizio della propria gente, e, conclude Morán, “oggi c’è bisogno più che mai di questo tipo di amore, e la categoria della cura lo esprime bene, è proprio un concentrato di questo amore di cui stiamo parlando. Allora la proposta dei giovani dei Focolari è questa: mettere la cura al centro della politica e della nostra vita di cittadini”. Quindi, dopo un anno dedicato ad azioni e progetti su pace, diritti umani e legalità, il prossimo 20 giugno con la campagna #daretocare i giovani dei Focolari aggiungono un altro tassello, quello della “cura”, sviluppata e approfondita attorno a cinque tematiche principali: ascolto, dialogo e comunicazione, uguaglianza, fraternità e bene comune, partecipazione e cura del pianeta. E come farlo? Seguendo la metodologia tipica dei “pathways”, i percorsi che per il terzo anno stanno percorrendo: imparare, agire e condividere. Allora: coraggio e osare. Appuntamento al prossimo 20 giugno, ore 14 (Cest + 2), con un evento online mondiale su Youtube per lanciare questa grande idea #daretocare. Per maggiori informazioni visitate il sito dello United World Project
“#daretocare”, ovvero “osare prendersi cura”. I giovani del Movimento dei Focolari hanno preso sul serio le parole di Papa Francesco e di molti altri leader religiosi e civili di collaborare concretamente alla cura della Casa Comune. Attraverso questo nuovo percorso vogliono quindi essere cittadini attivi e interessarsi a tutto quello che accade nel mondo per cercare di costruire un pezzetto di mondo unito. “In questo tempo di profonda crisi umanitaria, a causa del Coronavirus, sta emergendo una nuova visione – sostiene Jesús Morán, co-presiedente del Movimento dei Focolari – cioè la necessità di un nuovo modo di comportarsi, di vivere, una sorta di nuova agenda etica, come dicono alcuni esperti. E in questo contesto una categoria sta diventando centrale, ed è quella della cura, il farsi carico, l’occuparsi degli altri, della società, del pianeta”. Osare prendersi cura vuol dire quindi essere protagonisti nella vita di tutti i giorni per risolvere problemi, avviare dialoghi per una società migliore, essere attenti all’ambiente e alle persone di qualsiasi colore, religione, cultura. Soprattutto oggi dove il razzismo torna a riemergere, dove la libertà degli uomini torna ad essere minata da regimi totalitaristici, dove le armi e le guerre vogliono imporre il proprio dominio sulla pace e l’unità fra i popoli. “La cura è una categoria molto ampia, bella, poliedrica – continua Morán -. L’etica della cura ha a che fare con la dignità della persona, questo è fondamentale, è proprio il cuore della cura; non è una cosa intimistica, privata. Anzi, la cura ha una spiccata vocazione politica e una forte dimensione planetaria, anche se non dimentica il locale perché dopo, è localmente che ci prendiamo cura degli altri, è proprio nei rapporti personali, nella società, nel locale. Però questa dimensione planetaria è importante”. Papa Francesco ne ha parlato il 24 maggio scorso durante il quinto anniversario della Laudato sii, promuovendo un anno speciale di riflessione – fino al 24 maggio 2021 – per riportare all’attenzione di tutti il tema della cura del creato. E per creato si intende non solo l’ambiente che ci circonda, ma anche le persone, l’economia, la politica, il sociale… Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolari, definiva la politica come “l’amore degli amori”. Il politico è colui che sta al servizio della propria gente, e, conclude Morán, “oggi c’è bisogno più che mai di questo tipo di amore, e la categoria della cura lo esprime bene, è proprio un concentrato di questo amore di cui stiamo parlando. Allora la proposta dei giovani dei Focolari è questa: mettere la cura al centro della politica e della nostra vita di cittadini”. Quindi, dopo un anno dedicato ad azioni e progetti su pace, diritti umani e legalità, il prossimo 20 giugno con la campagna #daretocare i giovani dei Focolari aggiungono un altro tassello, quello della “cura”, sviluppata e approfondita attorno a cinque tematiche principali: ascolto, dialogo e comunicazione, uguaglianza, fraternità e bene comune, partecipazione e cura del pianeta. E come farlo? Seguendo la metodologia tipica dei “pathways”, i percorsi che per il terzo anno stanno percorrendo: imparare, agire e condividere. Allora: coraggio e osare. Appuntamento al prossimo 20 giugno, ore 14 (Cest + 2), con un evento online mondiale su Youtube per lanciare questa grande idea #daretocare. Per maggiori informazioni visitate il sito dello United World Project
Lorenzo Russo
(altro…)

7 Giu 2020 | Sociale
Dopo i fatti di Minneapolis e le manifestazioni nel mondo ci sentiamo impotenti e indignati, eppure continuiamo a credere e lavorare per uno spirito di aperta accoglienza e partecipazione per affrontare i bisogni più profondi del nostro tempo.

Foto: Josh Hild (Pexels)

Foto: Kelly Lacy (Pexels)
Stefania Tanesini
[1] Statement of U.S. Focolare Movement: our commitment to racial justice – https://www.focolare.org/usa/files/2020/06/Focolare-Statement-on-Racial-Justice.pdf [2] Ibid. (altro…)
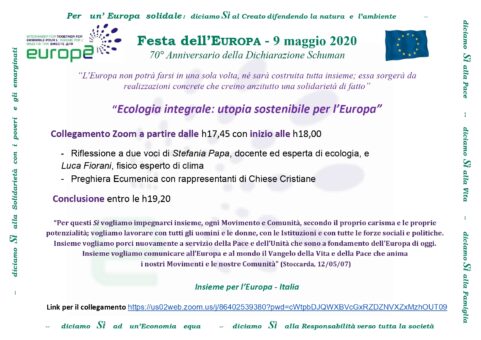
8 Mag 2020 | Sociale
Una giornata di incontro tra Comunità, Movimenti e Paesi per testimoniare la pace e la solidarietà fra i popoli.
Il 9 maggio ricorre la festa del continente europeo che celebra la pace e l’unità fra i popoli. Dalla storica firma del 31 ottobre del 1999 della “Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione” fra i responsabili di diversi Movimenti e Comunità, cattolici ed evangelici, dall’Italia e dalla Germania, è nata la rete together4europe, un cammino insieme per riscoprire i valori di pace e fraternità del vecchio Continente. Quest’anno la pandemia di Covid-19 impedisce di vedersi in chiesa, nelle piazze delle città, in ritrovi conviviali, per conferenze e preghiere. Ciò non significa che le attività di questa giornata siano annullate, al contrario: con molta creatività sono nate conferenze digitali, preghiere, gruppi di discussione e dialoghi online tra Comunità, Movimenti e rappresentanti politici, che partono, ad esempio, da Utrecht, Graz, Roma, Lione o Esslingen. Gli eventi di quest’anno hanno la benedizione papale poiché il 22 aprile scorso è arrivata la lettera di Papa Francesco. Il Papa apprezza il servizio al bene comune che la rete together4europe opera attraverso Comunità e Movimenti molto impegnati, ispirati dai valori di solidarietà, pace e giustizia. 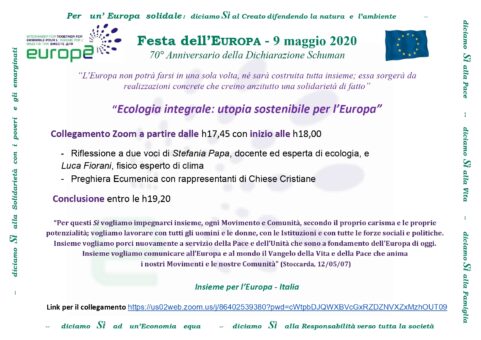 Per la Festa dell’Europa, in comunione con Graz, i Comitati Insieme per l’Europa d’Italia hanno promosso e organizzato per la giornata del 9 maggio un evento online dedicato al Sì al Creato difendendo la natura e l’ambiente, dal titolo “Ecologia integrale: utopia sostenibile per l’Europa”. Attraverso le riflessioni di Stefania Papa, docente ed esperta di ecologia, e Luca Fiorani, fisico esperto di clima, e delle video sintesi dei tre messaggi di Papa Francesco, del Patriarca Bartolomeo I e di Antonio Guterres (ONU) per la 50a Giornata mondiale della Terra, saremo aiutati a prendere consapevolezza di come possiamo insieme operare per un presente e futuro migliori, rispettando la nostra Terra, in una cultura del rispetto, della cooperazione e della reciprocità. Insieme per l’Europa infatti ha come obiettivo una “cultura della reciprocità”. In essa i singoli e i popoli diversi possono accogliersi l’un l’altro, conoscersi, riconciliarsi, imparare a stimarsi e a sostenersi vicendevolmente. Riassume molteplici attività a favore della riconciliazione e della pace, della tutela della vita e del creato, di un’economia equa, della solidarietà con i poveri e con gli emarginati, della famiglia, del bene delle città e della fratellanza nel continente europeo. Le diversità non devono essere motivo di paura o di separazione, piuttosto sono ricchezze che vengono sviluppate e armonizzate per un’Europa unita, viva, fraterna. Per maggiori informazioni visita il sito www.together4europe.org
Per la Festa dell’Europa, in comunione con Graz, i Comitati Insieme per l’Europa d’Italia hanno promosso e organizzato per la giornata del 9 maggio un evento online dedicato al Sì al Creato difendendo la natura e l’ambiente, dal titolo “Ecologia integrale: utopia sostenibile per l’Europa”. Attraverso le riflessioni di Stefania Papa, docente ed esperta di ecologia, e Luca Fiorani, fisico esperto di clima, e delle video sintesi dei tre messaggi di Papa Francesco, del Patriarca Bartolomeo I e di Antonio Guterres (ONU) per la 50a Giornata mondiale della Terra, saremo aiutati a prendere consapevolezza di come possiamo insieme operare per un presente e futuro migliori, rispettando la nostra Terra, in una cultura del rispetto, della cooperazione e della reciprocità. Insieme per l’Europa infatti ha come obiettivo una “cultura della reciprocità”. In essa i singoli e i popoli diversi possono accogliersi l’un l’altro, conoscersi, riconciliarsi, imparare a stimarsi e a sostenersi vicendevolmente. Riassume molteplici attività a favore della riconciliazione e della pace, della tutela della vita e del creato, di un’economia equa, della solidarietà con i poveri e con gli emarginati, della famiglia, del bene delle città e della fratellanza nel continente europeo. Le diversità non devono essere motivo di paura o di separazione, piuttosto sono ricchezze che vengono sviluppate e armonizzate per un’Europa unita, viva, fraterna. Per maggiori informazioni visita il sito www.together4europe.org
Lorenzo Russo
(altro…)

 Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze (Italia), per molti anni si è dedicata come ricercatrice al tema della cura. È intervenuta durante il primo live streaming #daretocare dei giovani del Movimento dei Focolari il 20 giugno scorso. L’esperienza della pandemia che stiamo attraversando che impatto ha avuto sulla sua visione della cura? “Mi sembra soprattutto che sia emersa un’immagine di cura come assistenza – ha spiegato la Pulcini -. Pensiamo a tutto il personale medico e sanitario. Questo ha risvegliato elementi positivi, passioni che sono state in qualche modo dimenticate, come la gratitudine, la compassione, il sentimento della nostra vulnerabilità. E questo è stato molto positivo perché ne abbiamo davvero bisogno ed è necessario risvegliare quelle che chiamo passioni empatiche. Allo stesso tempo, tuttavia, la cura è rimasta un po’ chiusa all’interno di un significato essenzialmente assistenziale, ciò che in inglese è chiamato “cure” e non “care”. La cura deve diventare un modo di vivere”. Ci piace sognare una società in cui la cura sia l’asse portante dei sistemi politici locali e globali. È un’utopia o è realizzabile? “Sicuramente la cura significa rispondere a qualcosa. In questo caso vuole dire rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Dal momento in cui realizzo questo e non sono chiuso nel mio individualismo si produce una capacità che abbiamo dentro di noi che è l’empatia, cioè mettersi nei panni dell’altro. Ma chi è l’altro oggi? Ecco, stanno emergendo nuove figure di ciò che consideriamo l’altro per noi. Quindi l’altro oggi è il diverso, sono anche le generazioni future, è anche la natura, l’ambiente, la Terra che ci ospita. Dunque la cura diventa davvero la risposta complessiva alle grandi sfide del nostro tempo, se la sappiamo ritrovare attraverso la capacità empatica di relazionarci con l’altro. Quindi non so se sia davvero realizzabile ma penso che non possiamo perdere la prospettiva utopica. Non basta la responsabilità, c’è bisogno di coltivare anche la speranza”. Quali suggerimenti ci daresti per agire in tal senso e orientare alla cura le nostre società a partire dalle istituzioni? “Credo che dobbiamo agire in tutti i luoghi in cui noi operiamo per far uscire la cura dall’ambito ristretto della sfera privata. (…) Io mi devo pensare come un soggetto di cura nella mia famiglia, nella mia professione di docente, quando incontro un povero emarginato per strada o quando vado a fare il bagno in spiaggia, devo prendermi cura di tutte le dimensioni. Dobbiamo adottare la cura come stile di vita in grado di spezzare il nostro individualismo illimitato che sta portando non solo l’autodistruzione dell’umanità, ma anche la distruzione del mondo vivente. Pertanto, dobbiamo cercare di rispondere con la cura alle patologie della nostra società, il che vuol dire educare alla democrazia. Io ho molto amato un filosofo dell’ottocento che si chiama Alexis de Tocqueville, il quale diceva che “dobbiamo educare alla democrazia”. È una lezione ancora tutta da imparare e credo che questo significhi coltivare le proprie emozioni empatiche in modo da essere stimolati alla cura con piacere, con gratificazione, non con costrizione”.
Elena Pulcini, docente di filosofia sociale presso l’università di Firenze (Italia), per molti anni si è dedicata come ricercatrice al tema della cura. È intervenuta durante il primo live streaming #daretocare dei giovani del Movimento dei Focolari il 20 giugno scorso. L’esperienza della pandemia che stiamo attraversando che impatto ha avuto sulla sua visione della cura? “Mi sembra soprattutto che sia emersa un’immagine di cura come assistenza – ha spiegato la Pulcini -. Pensiamo a tutto il personale medico e sanitario. Questo ha risvegliato elementi positivi, passioni che sono state in qualche modo dimenticate, come la gratitudine, la compassione, il sentimento della nostra vulnerabilità. E questo è stato molto positivo perché ne abbiamo davvero bisogno ed è necessario risvegliare quelle che chiamo passioni empatiche. Allo stesso tempo, tuttavia, la cura è rimasta un po’ chiusa all’interno di un significato essenzialmente assistenziale, ciò che in inglese è chiamato “cure” e non “care”. La cura deve diventare un modo di vivere”. Ci piace sognare una società in cui la cura sia l’asse portante dei sistemi politici locali e globali. È un’utopia o è realizzabile? “Sicuramente la cura significa rispondere a qualcosa. In questo caso vuole dire rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Dal momento in cui realizzo questo e non sono chiuso nel mio individualismo si produce una capacità che abbiamo dentro di noi che è l’empatia, cioè mettersi nei panni dell’altro. Ma chi è l’altro oggi? Ecco, stanno emergendo nuove figure di ciò che consideriamo l’altro per noi. Quindi l’altro oggi è il diverso, sono anche le generazioni future, è anche la natura, l’ambiente, la Terra che ci ospita. Dunque la cura diventa davvero la risposta complessiva alle grandi sfide del nostro tempo, se la sappiamo ritrovare attraverso la capacità empatica di relazionarci con l’altro. Quindi non so se sia davvero realizzabile ma penso che non possiamo perdere la prospettiva utopica. Non basta la responsabilità, c’è bisogno di coltivare anche la speranza”. Quali suggerimenti ci daresti per agire in tal senso e orientare alla cura le nostre società a partire dalle istituzioni? “Credo che dobbiamo agire in tutti i luoghi in cui noi operiamo per far uscire la cura dall’ambito ristretto della sfera privata. (…) Io mi devo pensare come un soggetto di cura nella mia famiglia, nella mia professione di docente, quando incontro un povero emarginato per strada o quando vado a fare il bagno in spiaggia, devo prendermi cura di tutte le dimensioni. Dobbiamo adottare la cura come stile di vita in grado di spezzare il nostro individualismo illimitato che sta portando non solo l’autodistruzione dell’umanità, ma anche la distruzione del mondo vivente. Pertanto, dobbiamo cercare di rispondere con la cura alle patologie della nostra società, il che vuol dire educare alla democrazia. Io ho molto amato un filosofo dell’ottocento che si chiama Alexis de Tocqueville, il quale diceva che “dobbiamo educare alla democrazia”. È una lezione ancora tutta da imparare e credo che questo significhi coltivare le proprie emozioni empatiche in modo da essere stimolati alla cura con piacere, con gratificazione, non con costrizione”.