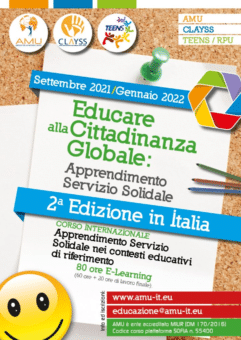
6 Mag 2021 | Sociale
Un corso internazionale di formazione sui temi di diritti umani, sostenibilità e fraternità, con lezioni, attività pratiche, momenti di interazione e condivisione. 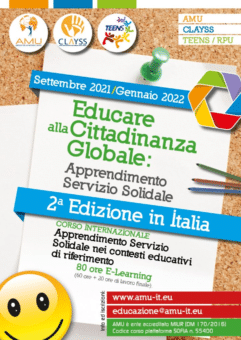 Dopo un primo esordio molto positivo, cui hanno partecipato 91 tra docenti ed educatori, anche quest’anno verrà riproposto il corso “Educare alla Cittadinanza Globale: l’apprendimento servizio solidale” nella sua II edizione. Si tratta di un percorso rivolto a tutti coloro che, coinvolti nell’ambito dell’educazione, vogliono formarsi alla vita civile attraverso un focus particolare: la messa in pratica del servizio solidale. Tra gli obiettivi del corso vi è dunque quello di formare i partecipanti affinché si facciano promotori di percorsi di cittadinanza attiva e globale, favorendo il pensiero critico, il coinvolgimento e il protagonismo giovanile, in un’ottica solidale di apprendimento. Il corso è organizzato dall’AMU, Azione per un Mondo Unito, in partnership con CLAYSS, Centro Latino-Americano per l’apprendimento servizio, in collaborazione il Movimento Ragazzi per l’Unità dei Focolari. Le lezioni si terranno dall’8 settembre 2021 fino a gennaio 2022 per un totale di 80 ore in modalità e-learning su una piattaforma didattica interattiva. 60 ore saranno dedicate all’apprendimento individuale (non lezioni in streaming); le altre 20 ore serviranno alla realizzazione di un lavoro finale. Ogni modulo sarà caratterizzato da video tematici, contenuti testuali e approfondimenti relativi alla tematica trattata. Durante la formazione, ogni partecipante sarà seguito passo dopo passo da un tutor specializzato, a completa disposizione anche tramite colloqui individuali e videochiamate periodiche. Per ogni sessione modulare sono previste attività finalizzate ad imparare come i contenuti acquisiti possano essere applicati all’interno dei propri contesti educativi. La formazione prevede anche dei momenti di scambio e condivisione tra i partecipanti tramite attività e riunioni telematiche periodiche, utili ed interessanti specialmente grazie all’internazionalità del corso. Una volta concluso il percorso, AMU rilascerà un attestato di partecipazione di 80 ore complessive. Tra i partecipanti alla prima edizione molti si sono espressi positivamente riguardo al percorso offerto. Sono stati apprezzati soprattutto: lo stile pedagogico del corso, particolarmente adatto a rendere cittadini attivi sia i docenti che i giovani; la piattaforma ben curata; il sostegno e la vicinanza da parte di tutor professionali; la dedizione e la fantasia dei docenti; l’arricchimento culturale dato dalla partecipazione internazionale. Si tratta dunque di un corso ricco che può permettere a tanti docenti ed educatori di approfondire competenze ed abilità nell’ambito della cittadinanza, per imparare ed insegnare ad essere cittadini attivi. Informazioni
Dopo un primo esordio molto positivo, cui hanno partecipato 91 tra docenti ed educatori, anche quest’anno verrà riproposto il corso “Educare alla Cittadinanza Globale: l’apprendimento servizio solidale” nella sua II edizione. Si tratta di un percorso rivolto a tutti coloro che, coinvolti nell’ambito dell’educazione, vogliono formarsi alla vita civile attraverso un focus particolare: la messa in pratica del servizio solidale. Tra gli obiettivi del corso vi è dunque quello di formare i partecipanti affinché si facciano promotori di percorsi di cittadinanza attiva e globale, favorendo il pensiero critico, il coinvolgimento e il protagonismo giovanile, in un’ottica solidale di apprendimento. Il corso è organizzato dall’AMU, Azione per un Mondo Unito, in partnership con CLAYSS, Centro Latino-Americano per l’apprendimento servizio, in collaborazione il Movimento Ragazzi per l’Unità dei Focolari. Le lezioni si terranno dall’8 settembre 2021 fino a gennaio 2022 per un totale di 80 ore in modalità e-learning su una piattaforma didattica interattiva. 60 ore saranno dedicate all’apprendimento individuale (non lezioni in streaming); le altre 20 ore serviranno alla realizzazione di un lavoro finale. Ogni modulo sarà caratterizzato da video tematici, contenuti testuali e approfondimenti relativi alla tematica trattata. Durante la formazione, ogni partecipante sarà seguito passo dopo passo da un tutor specializzato, a completa disposizione anche tramite colloqui individuali e videochiamate periodiche. Per ogni sessione modulare sono previste attività finalizzate ad imparare come i contenuti acquisiti possano essere applicati all’interno dei propri contesti educativi. La formazione prevede anche dei momenti di scambio e condivisione tra i partecipanti tramite attività e riunioni telematiche periodiche, utili ed interessanti specialmente grazie all’internazionalità del corso. Una volta concluso il percorso, AMU rilascerà un attestato di partecipazione di 80 ore complessive. Tra i partecipanti alla prima edizione molti si sono espressi positivamente riguardo al percorso offerto. Sono stati apprezzati soprattutto: lo stile pedagogico del corso, particolarmente adatto a rendere cittadini attivi sia i docenti che i giovani; la piattaforma ben curata; il sostegno e la vicinanza da parte di tutor professionali; la dedizione e la fantasia dei docenti; l’arricchimento culturale dato dalla partecipazione internazionale. Si tratta dunque di un corso ricco che può permettere a tanti docenti ed educatori di approfondire competenze ed abilità nell’ambito della cittadinanza, per imparare ed insegnare ad essere cittadini attivi. Informazioni
- L’AMU è ente accreditato MIUR Ministero italiano per l’istruzione (DM 170/2016), per la formazione del personale scolastico, pertanto si potrà usufruire della Carta del docente.
- Il corso è già sulla piattaforma SOFIA con il codice identificativo n. 55400 per chi volesse iscriversi anche nella piattaforma, ma vi ricordiamo necessario provvedere anche all’iscrizione tramite il seguente link.
- Sono previsti sconti per chi si iscrive entro il 20 giugno 2021, per gruppi, studenti universitari e vi è la possibilità di richiedere una borsa di studio per cittadini di paesi terzi.
Per saperne di più, visita il sito web di AMU al seguente link.
Laura Salerno
Vedi anche il piccolo video di promozione (altro…)

5 Mag 2021 | Cultura, Sociale
Il 2 maggio nell’ambito della Settimana Mondo Unito 2021 si è tenuto un evento in streaming in occasione 25°anniversario del Movimento Politico per l’Unità (Mppu). Uno stretto legame tra generazioni per imprimere il coefficiente della fraternità universale alle relazioni politiche e alle istituzioni. Lanciato un “Appello per una politica di qualità”. All’Angelus il saluto di Papa Francesco per questo anniversario.  Politici esperti insieme a giovani immersi alle prime esperienze politiche sono stati i promotori di un evento via streaming domenica 2 maggio. L’appuntamento, frutto di mesi di lavoro condiviso ed inserito nel programma della Settimana Mondo Unito 2021, per celebrare i 25 anni dalla fondazione del Movimento Politico per l’Unità (Mppu). Otto lingue in simultanea più di 500 punti di ascolto da tutto il mondo e 4000 visualizzazioni in diretta. Alla ricchezza dei temi al centro della convention, si è aggiunto, inatteso e salutato con grande gioia, anche l’incoraggiamento di Papa Francesco che si è rivolto durante l’Angelus domenicale a tutti gli aderenti al Mppu “fondato da Chiara Lubich”, con l’augurio di “un buon lavoro al servizio di una buona politica”. Il programma della diretta ha rivisto anzitutto alcuni testimoni della nascita del Movimento Politico per l’unità, il momento in cui la fondatrice dei Focolari Chiara Lubich lo costituì il 2 maggio del 1996, incontrando a Napoli (Italia) un gruppo di politici di diverse appartenenze. Sono seguite alcune tappe del percorso del Mppu nel mondo fino all’iniziativa che è giunta al traguardo proprio in questa occasione: l’Appello per una politica di qualità. Per la stesura di questo testo hanno cooperato cittadini, amministratori, legislatori, funzionari e diplomatici, studiosi e membri di organizzazioni civili in 25 Paesi del mondo: con un interessante processo deliberativo internazionale si è giunti a comporre una “call for action”, un appello ad agire rivolto ai politici delle città, dei Parlamenti, delle organizzazioni internazionali, a quanti sono impegnati nell’azione politica, per sostenere il cammino irreversibile dei popoli verso l’unità e la pace. Una “politica di qualità” – per i redattori dell’Appello – è una politica “migliore ogni giorno”, una politica “mite” e “forte” allo stesso tempo affidata a donne e uomini che sanno guardare ai valori più profondi e condivisi dell’umanità, politici competenti che sanno progettare a lungo termine e che rendono conto del loro mandato, che non usano le persone per calcoli elettorali, che attivano processi riconoscendo la capacità di auto-organizzazione delle comunità, che stanno dalla parte delle vittime ma non abbandonano i colpevoli. “Certo, sono mille e mille le emergenze da affrontare – ha affermato Adelard Kananira, burundese, anche a nome dei giovani politici intervistati nel programma – ma sappiamo che oggi l’emergenza che tutti ci interpella è quella del vaccino come bene comune”. Non si è perso tempo, dunque, e con la regia del team Mppu e dei giovani promotori della Settimana Mondo Unito, nei giorni immediatamente precedenti ha preso avvio una forte iniziativa internazionale: per l’universalità dell’accesso ai vaccini e per la loro produzione diffusa, anche in vista della riunione del WTO e del G20 sulla salute globale. “È questa la risposta che vogliamo proporre andando a toccare sistemi consolidati con un’azione-segno per chi nel mondo non ha accesso all’assistenza sanitaria, perché crediamo che il bene dell’altro, anche di chi non conosciamo, sia il nostro stesso bene” sostiene Klara Costa, brasiliana, del Movimento Giovani per un Mondo Unito dei Focolari. “Prenderci cura gli uni degli altri: è questo il segno concreto di una politica di qualità. Abbiamo cercato dove testimoniarlo proprio là dove la pandemia è più grave – ha raccontato Mario Bruno, presidente del Centro internazionale del Mppu – e per alcune circostanze abbiamo incontrato gli operatori di una nave-ospedale, il “barco papa Francisco”, che sta portando assistenza sanitaria a quelle popolazioni nel Parà, in Brasile. È loro che vogliamo raggiungere al più presto con il vaccino”. A chiudere l’Appello – e lo streaming – è stato, dunque, il disegno di una politica alta, ancorata alla realtà e carica di forza ideale allo stesso tempo, una politica che sa agire “per amare e guarire il mondo”. Si riparte da qui.
Politici esperti insieme a giovani immersi alle prime esperienze politiche sono stati i promotori di un evento via streaming domenica 2 maggio. L’appuntamento, frutto di mesi di lavoro condiviso ed inserito nel programma della Settimana Mondo Unito 2021, per celebrare i 25 anni dalla fondazione del Movimento Politico per l’Unità (Mppu). Otto lingue in simultanea più di 500 punti di ascolto da tutto il mondo e 4000 visualizzazioni in diretta. Alla ricchezza dei temi al centro della convention, si è aggiunto, inatteso e salutato con grande gioia, anche l’incoraggiamento di Papa Francesco che si è rivolto durante l’Angelus domenicale a tutti gli aderenti al Mppu “fondato da Chiara Lubich”, con l’augurio di “un buon lavoro al servizio di una buona politica”. Il programma della diretta ha rivisto anzitutto alcuni testimoni della nascita del Movimento Politico per l’unità, il momento in cui la fondatrice dei Focolari Chiara Lubich lo costituì il 2 maggio del 1996, incontrando a Napoli (Italia) un gruppo di politici di diverse appartenenze. Sono seguite alcune tappe del percorso del Mppu nel mondo fino all’iniziativa che è giunta al traguardo proprio in questa occasione: l’Appello per una politica di qualità. Per la stesura di questo testo hanno cooperato cittadini, amministratori, legislatori, funzionari e diplomatici, studiosi e membri di organizzazioni civili in 25 Paesi del mondo: con un interessante processo deliberativo internazionale si è giunti a comporre una “call for action”, un appello ad agire rivolto ai politici delle città, dei Parlamenti, delle organizzazioni internazionali, a quanti sono impegnati nell’azione politica, per sostenere il cammino irreversibile dei popoli verso l’unità e la pace. Una “politica di qualità” – per i redattori dell’Appello – è una politica “migliore ogni giorno”, una politica “mite” e “forte” allo stesso tempo affidata a donne e uomini che sanno guardare ai valori più profondi e condivisi dell’umanità, politici competenti che sanno progettare a lungo termine e che rendono conto del loro mandato, che non usano le persone per calcoli elettorali, che attivano processi riconoscendo la capacità di auto-organizzazione delle comunità, che stanno dalla parte delle vittime ma non abbandonano i colpevoli. “Certo, sono mille e mille le emergenze da affrontare – ha affermato Adelard Kananira, burundese, anche a nome dei giovani politici intervistati nel programma – ma sappiamo che oggi l’emergenza che tutti ci interpella è quella del vaccino come bene comune”. Non si è perso tempo, dunque, e con la regia del team Mppu e dei giovani promotori della Settimana Mondo Unito, nei giorni immediatamente precedenti ha preso avvio una forte iniziativa internazionale: per l’universalità dell’accesso ai vaccini e per la loro produzione diffusa, anche in vista della riunione del WTO e del G20 sulla salute globale. “È questa la risposta che vogliamo proporre andando a toccare sistemi consolidati con un’azione-segno per chi nel mondo non ha accesso all’assistenza sanitaria, perché crediamo che il bene dell’altro, anche di chi non conosciamo, sia il nostro stesso bene” sostiene Klara Costa, brasiliana, del Movimento Giovani per un Mondo Unito dei Focolari. “Prenderci cura gli uni degli altri: è questo il segno concreto di una politica di qualità. Abbiamo cercato dove testimoniarlo proprio là dove la pandemia è più grave – ha raccontato Mario Bruno, presidente del Centro internazionale del Mppu – e per alcune circostanze abbiamo incontrato gli operatori di una nave-ospedale, il “barco papa Francisco”, che sta portando assistenza sanitaria a quelle popolazioni nel Parà, in Brasile. È loro che vogliamo raggiungere al più presto con il vaccino”. A chiudere l’Appello – e lo streaming – è stato, dunque, il disegno di una politica alta, ancorata alla realtà e carica di forza ideale allo stesso tempo, una politica che sa agire “per amare e guarire il mondo”. Si riparte da qui.
A cura del centro Internazionale del Mppu
Per rivedere l’evento nelle varie lingue clicca qui (altro…)

28 Apr 2021 | Cultura, Sociale
La prima offerta accademica della sede latinoamericana dell’Istituto Universitario Sophia è un corso di diploma dedicato alla leadership partecipativa, inclusiva, attenta al gruppo e all’ambiente: una leadership comunitaria. Quali gli argomenti e le esigenze a cui si vuole rispondere? L’intervista a Lucas Cerviño, docente di teologia e a Candela Fraccaro, studentessa argentina Nel mondo di oggi, segnato da grandi sfide economiche e sociali acuite dalla pandemia, l’Istituto Universitario Sophia in America Latina e Caraibi risponde a queste esigenze con un nuovo corso di Diploma in Leadership Comunitaria. Ne abbiamo parlato con Lucas Cerviño, docente di teologia e co-responsabile della scuola dei giovani nella cittadella dei Focolari El Diamante (Messico), membro del team che coordina il corso. “Viviamo un cambiamento d’epoca, nel quale Papa Francesco (come si legge nell’Evangelii Gaudium) ravvisa una “crisi dell’impegno comunitario” – afferma Cerviño -. Abbiamo pensato che per superare questa condizione in modo positivo è necessario promuovere una leadership nuova, non più personalista, che centralizza la gestione e la decisione. D’altro canto abbiamo visto che in tanti luoghi, in America Latina, ci sono ricerche, esperienze e proposte d’impegno comunitario. Il corso nasce allora per mettere insieme l’esigenza di una leadership rinnovata con questi germogli di vita nuova”. Il mondo di oggi è alle prese con la sfida pandemica. In questo contesto, a quali esigenze si vuole rispondere? Lucas Cerviño: “Crediamo che per superare la pandemia serva lavorare insieme al di là delle diversità, promuovere la consapevolezza che abbiamo un’origine comune, un’interdipendenza nel presente e un orizzonte comune. Il nostro corso vuole offrire un contributo in questa direzione”.  Quali sono gli argomenti e gli obiettivi di formazione del corso? Lucas Cerviño: “Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno, o si candidano ad avere, un ruolo di leadership in ambito economico, politico, religioso e nel terzo settore, e offre loro la possibilità di ripensare o strutturare nel concreto la propria leadership. A questo scopo offriamo conoscenze, risorse, strategie e abilità per costruire una leadership che sappia generare, custodire e valorizzare i beni relazionali; facilitare pratiche e strumenti sinergici, relazionali e cooperativi per generare processi più sostenibili in diversi ambiti sociali. Rispetto ai contenuti, si indaga il rapporto tra persona e comunità e si parla di sviluppo sostenibile, fraternità e cittadinanza, coesione sociale nella diversità, apprendimento comunitario, gestione economica e comunione, sinodalità ed esperienza religiosa”. Anche la metodica di insegnamento è innovativa… Lucas Cerviño: “Sarebbe una contraddizione offrire un corso sulla leadership comunitaria e poi gestirlo in maniera unilaterale. Bisogna andare oltre il concetto tradizionale di insegnamento per aprirsi ad un apprendimento comunitario e creativo che metta al centro i rapporti interpersonali. Il corso è dunque teorico e insieme pratico. Si articola secondo delle comunità di apprendimento: oltre a seguire le lezioni, i partecipanti si uniscono in gruppi di sei o sette persone e accompagnati da un tutor danno vita ad uno spazio di riflessione e conoscenza comunitaria. Ogni partecipante è poi seguito da un tutor per sviluppare un progetto d’intervento concreto che applichi i contenuti del corso. Le caratteristiche del corso fanno si che tra i partecipanti, che vengono da nove città, ci siano giovani ventenni e persone quasi in pensione; studenti e professionisti. Tutti motivati ad imparare insieme”. Candela Fraccaro è fra gli studenti più giovani. Le abbiamo chiesto: cosa ti ha spinto a seguire un corso sulla leadership comunitaria? Candela Fraccaro: “Mi motiva l’impegno che porto avanti da alcuni anni insieme ad altri ragazzi presso il sobborgo di Piedras Blancas, nella città di Godoy Cruz, vicino Mendoza (Argentina). Qui gestiamo una ludoteca per fare formazione con i bambini attraverso il gioco, teniamo laboratori per gli adolescenti, aiutiamo a fornire pasti ai bambini bisognosi e insieme ai Giovani per un Mondo Unito del Movimento dei Focolari, diamo sostegno ad una scuola. Io guido alcune di queste attività e allora sento che il corso può darmi strumenti per costruire un progetto che ci aiuti ad indirizzare i nostri sforzi”. Il metodo del confronto dialogico è parte integrante del corso. Quali elementi positivi cogli? Candela Fraccaro: “Questo metodo ci invita a valorizzare la diversità, a trasformarla in ricchezza e propone il dialogo come strumento di costruzione comune. È basato sul rispetto, l’ascolto e l’apertura, e offre la possibilità di esprimersi liberamente senza imporre la propria idea. In questo modo il processo di insegnamento-apprendimento è più arricchente e ciascuno si sente parte attiva di questo processo”.
Quali sono gli argomenti e gli obiettivi di formazione del corso? Lucas Cerviño: “Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno, o si candidano ad avere, un ruolo di leadership in ambito economico, politico, religioso e nel terzo settore, e offre loro la possibilità di ripensare o strutturare nel concreto la propria leadership. A questo scopo offriamo conoscenze, risorse, strategie e abilità per costruire una leadership che sappia generare, custodire e valorizzare i beni relazionali; facilitare pratiche e strumenti sinergici, relazionali e cooperativi per generare processi più sostenibili in diversi ambiti sociali. Rispetto ai contenuti, si indaga il rapporto tra persona e comunità e si parla di sviluppo sostenibile, fraternità e cittadinanza, coesione sociale nella diversità, apprendimento comunitario, gestione economica e comunione, sinodalità ed esperienza religiosa”. Anche la metodica di insegnamento è innovativa… Lucas Cerviño: “Sarebbe una contraddizione offrire un corso sulla leadership comunitaria e poi gestirlo in maniera unilaterale. Bisogna andare oltre il concetto tradizionale di insegnamento per aprirsi ad un apprendimento comunitario e creativo che metta al centro i rapporti interpersonali. Il corso è dunque teorico e insieme pratico. Si articola secondo delle comunità di apprendimento: oltre a seguire le lezioni, i partecipanti si uniscono in gruppi di sei o sette persone e accompagnati da un tutor danno vita ad uno spazio di riflessione e conoscenza comunitaria. Ogni partecipante è poi seguito da un tutor per sviluppare un progetto d’intervento concreto che applichi i contenuti del corso. Le caratteristiche del corso fanno si che tra i partecipanti, che vengono da nove città, ci siano giovani ventenni e persone quasi in pensione; studenti e professionisti. Tutti motivati ad imparare insieme”. Candela Fraccaro è fra gli studenti più giovani. Le abbiamo chiesto: cosa ti ha spinto a seguire un corso sulla leadership comunitaria? Candela Fraccaro: “Mi motiva l’impegno che porto avanti da alcuni anni insieme ad altri ragazzi presso il sobborgo di Piedras Blancas, nella città di Godoy Cruz, vicino Mendoza (Argentina). Qui gestiamo una ludoteca per fare formazione con i bambini attraverso il gioco, teniamo laboratori per gli adolescenti, aiutiamo a fornire pasti ai bambini bisognosi e insieme ai Giovani per un Mondo Unito del Movimento dei Focolari, diamo sostegno ad una scuola. Io guido alcune di queste attività e allora sento che il corso può darmi strumenti per costruire un progetto che ci aiuti ad indirizzare i nostri sforzi”. Il metodo del confronto dialogico è parte integrante del corso. Quali elementi positivi cogli? Candela Fraccaro: “Questo metodo ci invita a valorizzare la diversità, a trasformarla in ricchezza e propone il dialogo come strumento di costruzione comune. È basato sul rispetto, l’ascolto e l’apertura, e offre la possibilità di esprimersi liberamente senza imporre la propria idea. In questo modo il processo di insegnamento-apprendimento è più arricchente e ciascuno si sente parte attiva di questo processo”.
Claudia Di Lorenzi
(altro…)

23 Mar 2021 | Focolari nel Mondo, Sociale
Nonostante i violenti scontri in Myanmar continua l’aiuto della comunità dei Focolari attraverso l’associazione “Goccia dopo Goccia” per testimoniare la fratellanza universale tra pandemia e rivoluzione. Ecco il viaggio di inizio marzo dei focolarini presenti in zona (le azioni si sono svolte seguendo le regole Covid previste dal Paese) Il Myanmar ancora oggi vive una rivoluzione iniziata lo scorso 22 febbraio dal nome ‘22222’. Questo Paese, formato da etnie diverse e ricco di bellezze naturali e di materie prime, dal 1947 al 2010 ha vissuto la più lunga guerra civile nella storia dell’umanità. Tra le varie rivoluzioni tentate: quella dell’8 agosto 1988 denominata ‘8888’ (con migliaia di morti) e quella del 2007, la rivoluzione ‘color zafferano’ per il grande numero di monaci buddhisti che iniziarono la protesta e che persero la vita. Negli scontri del 1988 migliaia di persone iniziarono a migrare verso il confine con la Thailandia, precisamente nella provincia di Tak, nella cittadina di Mae Sot, poi a Mae Hong Song, ed anche pìu a sud, verso Kanchanaburi. Oggi, dopo 32 anni, sono attivi ancora nove campi profughi con milioni di birmani che lavorano in Thailandia.  Dal 2011 è nato un ponte di solidarietà fra l’Italia e Mae Sot. La comunità dei Focolari di Latina nel centro Italia, insieme ad alcuni alunni dell’insegnante Maria Grazia Fabietti, hanno iniziato a far qualcosa per aiutare i bambini e le persone che vivono a confine fra la Thailandia e il Myanmar. “Per il 50-esimo compleanno di uno di questi amici italiani, Paolo Magli, vennero raccolti dei soldi per aiutare questi gruppi di etnia Karen (una popolazione fuggita dalla Birmania durante i conflitti e costretti da anni a vivere come profughi al confine tra Myanmar e Thailandia), sia nel campo profughi di Mae La e soprattutto fuori – spiega ancora Luigi -. Era l’inizizo di Goccia dopo Goccia. Oggi, questa realtà aiuta più di 3300 persone in tre paesi del sud est asiatico e collabora anche con l’associazione Charis di Singapore per portare aiuto a chi è stato colpito dalla povertà, dalla solitudine, dalle malattie e anche dalla pandemia. Vietnam, Thailandia e Myanmar rappresentano per noi la ‘possibilità di amare concretamente’: lì ci sono persone che hanno conosciuto lo spirito della fratellanza universale e oggi fanno di tutto per aiutare chi è escluso, emarginato, rifiutato, ammalato e solo”.
Dal 2011 è nato un ponte di solidarietà fra l’Italia e Mae Sot. La comunità dei Focolari di Latina nel centro Italia, insieme ad alcuni alunni dell’insegnante Maria Grazia Fabietti, hanno iniziato a far qualcosa per aiutare i bambini e le persone che vivono a confine fra la Thailandia e il Myanmar. “Per il 50-esimo compleanno di uno di questi amici italiani, Paolo Magli, vennero raccolti dei soldi per aiutare questi gruppi di etnia Karen (una popolazione fuggita dalla Birmania durante i conflitti e costretti da anni a vivere come profughi al confine tra Myanmar e Thailandia), sia nel campo profughi di Mae La e soprattutto fuori – spiega ancora Luigi -. Era l’inizizo di Goccia dopo Goccia. Oggi, questa realtà aiuta più di 3300 persone in tre paesi del sud est asiatico e collabora anche con l’associazione Charis di Singapore per portare aiuto a chi è stato colpito dalla povertà, dalla solitudine, dalle malattie e anche dalla pandemia. Vietnam, Thailandia e Myanmar rappresentano per noi la ‘possibilità di amare concretamente’: lì ci sono persone che hanno conosciuto lo spirito della fratellanza universale e oggi fanno di tutto per aiutare chi è escluso, emarginato, rifiutato, ammalato e solo”.  Goccia dopo Goccia aiuta tutti: persone di etnia Karen, Bama, Kachin, Thai Yai, oppure Xtieng e Hmong in Vietnam ma anche musulmani indigenti che sono in contatto con il focolare di Bangkok. A inizio marzo i focolarini sono andati a Mae Sot con un pulmino carico di generi alimentari, stoffa, giochi e tanto altro, come dimostra il video che vedete di seguito (le azioni si sono svolte seguendo le regole Covid previste dal Paese). Le donazioni sono arrivate da musulmani, buddisti, cristiani e tante persone in contatto con il focolare. “Ognuno è un fratello e una sorella – continua Luigi -. Vogliamo vivere una delle pagine pìu belle scritte da Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolari tanti anni fa: “Signore, dammi tutti i soli: sento il mio cuore battere per tutta la solitudine in cui versa il mondo intero*’’. L’ultimo progetto nato aiuta sei mamme abbandonate a Mae Sot con i loro quindici bambini. “Abbiamo fatto arrivare due macchine da cucire e 15 kg di stoffa di cotone da poter tagliare e cucire, per fabbricare camicie, gonne e pantaloni per coloro che ne avessero bisogno – racconta Luigi -. È una gioia e una festa vedere come le persone si aiutano tra di loro. La fratellanza universale è una realtà che prende piede, giorno dopo giorno, e Goccia dopo Goccia rappresenta proprio questo”.
Goccia dopo Goccia aiuta tutti: persone di etnia Karen, Bama, Kachin, Thai Yai, oppure Xtieng e Hmong in Vietnam ma anche musulmani indigenti che sono in contatto con il focolare di Bangkok. A inizio marzo i focolarini sono andati a Mae Sot con un pulmino carico di generi alimentari, stoffa, giochi e tanto altro, come dimostra il video che vedete di seguito (le azioni si sono svolte seguendo le regole Covid previste dal Paese). Le donazioni sono arrivate da musulmani, buddisti, cristiani e tante persone in contatto con il focolare. “Ognuno è un fratello e una sorella – continua Luigi -. Vogliamo vivere una delle pagine pìu belle scritte da Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolari tanti anni fa: “Signore, dammi tutti i soli: sento il mio cuore battere per tutta la solitudine in cui versa il mondo intero*’’. L’ultimo progetto nato aiuta sei mamme abbandonate a Mae Sot con i loro quindici bambini. “Abbiamo fatto arrivare due macchine da cucire e 15 kg di stoffa di cotone da poter tagliare e cucire, per fabbricare camicie, gonne e pantaloni per coloro che ne avessero bisogno – racconta Luigi -. È una gioia e una festa vedere come le persone si aiutano tra di loro. La fratellanza universale è una realtà che prende piede, giorno dopo giorno, e Goccia dopo Goccia rappresenta proprio questo”.
Lorenzo Russo
https://youtu.be/xv5W3hxZInc * Meditazione “Signore dammi tutti i soli” di Chiara Lubich – settembre 1949 (altro…)

19 Mar 2021 | Focolari nel Mondo, Sociale
Nella periferia orientale di Lima in Perù la comunità dei Focolari assiste ogni giorno la gente che vive in estrema povertà, condividendo cibo, aiuti materiali, alfabetizzazione ed esperienze del Vangelo. Huaycán si trova nella periferia orientale di Lima (Perù). Dei 200.000 abitanti, il 90% sono immigrati dalle Ande, in fuga dalla povertà. Conservano le loro tradizioni e la loro lingua, il quechua, l’antica lingua degli Incas. Nelle parti più alte delle colline, la gente vive in estrema povertà. Le loro case hanno pavimenti in terra battuta e una sola stanza (i letti accanto alla cucina), mancano di acqua potabile, elettricità, fognature…. La maggior parte di loro sono venditori ambulanti. Alcune donne fanno le pulizie in casa e alcuni uomini sono operai edili o raccoglitori di rottami. La comunità di Lima ha guardato e scelto questa “ferita di Cristo” per amarla con predilezione. “Siamo arrivati a Huaycán – ricorda Elsa – nel 1998, quando Tata, Carmen, Maria e Milagros ed io portammo la Parola di Vita ad una comunità vicina alla “Scuola Fe y Alegría” delle Suore Francescane. Poi si sono aggiunti Elba, Mario, Lula, Yeri, Fernando e Eury, Cristina… Siamo andati nelle zone alte delle colline e abbiamo condiviso con i più poveri dei poveri le esperienze del Vangelo. Hanno sofferto di malattie, violenza familiare, promiscuità, disoccupazione, droga, fame”. “Ci sedevamo sulle pietre – dice Elba – poi, man mano che diventavano più sicuri, tiravano fuori le loro sedie. In inverno, ci invitavano nelle loro umili stanze. Lì abbiamo incontrato Olinda, la cuoca della scuola, che ha aperto la sua casa per incontrarci. Una bella persona, il nostro punto di riferimento locale. La morte di suo figlio prima e la sua morte improvvisa poi, ci hanno causato molto dolore”.  Per alleviare i bisogni, la comunità di Lima ha lanciato diverse iniziative: aiuti materiali, sostegno educativo per i bambini, formazione e alfabetizzazione per gli adulti, sostegno psicologico, follow-up e assistenza sanitaria, vendita di vestiti di seconda mano. “Ogni anno festeggiamo insieme il Natale e la festa della mamma, organizziamo gite e alcuni partecipano alla Mariapoli annuale – ricorda Mario -. Una coppia, dopo essersi preparata, si è sposata durante una delle Mariapoli, in presenza dei loro cinque figli e parenti. È stato un evento che ha segnato la loro vita, come la vita di tanti altri che hanno incontrato il Dio dell’Amore”. “Con la pandemia – continua Cristina – molti hanno perso il lavoro e non hanno abbastanza per nutrire i loro figli. Ci siamo organizzati con alcune famiglie per procurare il cibo necessario e distribuirlo ai più bisognosi. Una donna ha installato un forno, che era rimasto inattivo, per produrre pane. Da marzo a giugno, abbiamo distribuito 140 cesti di cibo e 12.720 pani. Abbiamo incontrato la comunità più povera Granja Verde, bisognosa di una sala da pranzo dove preparare il cibo. Ci siamo organizzati: hanno offerto un pezzo di terra e hanno posato il pavimento di cemento. Abbiamo fornito la cucina con gli utensili necessari e un serbatoio di 2.500 litri di acqua potabile. La sala da pranzo è stata inaugurata il 15 novembre 2020 e ha iniziato a funzionare il giorno seguente. Oggi produciamo 100 pasti al giorno. Sappiamo, come ci ricorda Papa Francesco, che se ci dimentichiamo dei poveri, Dio si dimenticherà di noi. Huaycán, il punto dolente di Cristo, è il nostro preferito e la nostra grande opportunità di ottenere la benedizione di Dio”.
Per alleviare i bisogni, la comunità di Lima ha lanciato diverse iniziative: aiuti materiali, sostegno educativo per i bambini, formazione e alfabetizzazione per gli adulti, sostegno psicologico, follow-up e assistenza sanitaria, vendita di vestiti di seconda mano. “Ogni anno festeggiamo insieme il Natale e la festa della mamma, organizziamo gite e alcuni partecipano alla Mariapoli annuale – ricorda Mario -. Una coppia, dopo essersi preparata, si è sposata durante una delle Mariapoli, in presenza dei loro cinque figli e parenti. È stato un evento che ha segnato la loro vita, come la vita di tanti altri che hanno incontrato il Dio dell’Amore”. “Con la pandemia – continua Cristina – molti hanno perso il lavoro e non hanno abbastanza per nutrire i loro figli. Ci siamo organizzati con alcune famiglie per procurare il cibo necessario e distribuirlo ai più bisognosi. Una donna ha installato un forno, che era rimasto inattivo, per produrre pane. Da marzo a giugno, abbiamo distribuito 140 cesti di cibo e 12.720 pani. Abbiamo incontrato la comunità più povera Granja Verde, bisognosa di una sala da pranzo dove preparare il cibo. Ci siamo organizzati: hanno offerto un pezzo di terra e hanno posato il pavimento di cemento. Abbiamo fornito la cucina con gli utensili necessari e un serbatoio di 2.500 litri di acqua potabile. La sala da pranzo è stata inaugurata il 15 novembre 2020 e ha iniziato a funzionare il giorno seguente. Oggi produciamo 100 pasti al giorno. Sappiamo, come ci ricorda Papa Francesco, che se ci dimentichiamo dei poveri, Dio si dimenticherà di noi. Huaycán, il punto dolente di Cristo, è il nostro preferito e la nostra grande opportunità di ottenere la benedizione di Dio”.
Gustavo E. Clariá
(altro…)

17 Mar 2021 | Cultura, Sociale
Dichiarazione congiunta di SIGNIS, Pax Christi International e il Movimento dei Focolari in solidarietà con il popolo di Myanmar SIGNIS, l’Associazione cattolica mondiale per la comunicazione, ascolta il grido del coraggioso popolo birmano nella resistenza non violenta al colpo di stato militare del Myanmar che ribalta un’elezione legittima e democratica.  Siamo accompagnati da Pax Christi International e dai suoi membri nella regione Asia-Pacifico che, nella loro dichiarazione di febbraio sullo “Stato di emergenza” in Myanmar, hanno già espresso gravi preoccupazioni per la situazione nel Paese. Allo stesso modo, il movimento internazionale dei Focolari si unisce a noi in solidarietà con il popolo birmano. Ogni giorno persone coraggiose, tra cui molti giovani, tornano in piazza per protestare pacificamente, nonostante gli spari dei soldati. Come simbolo della loro protesta, segno della giusta rabbia del popolo verso i militari, sentiamo il fragore di pentole e padelle, secondo l’usanza birmana per proteggersi dagli spiriti maligni. Assistiamo alla detenzione arbitraria – con accuse fabbricate – di membri del governo democraticamente eletto, nonché di leader civili e religiosi che hanno preso parte alla lunga lotta per la democrazia. Rifiutiamo la campagna di disinformazione dei militari del Myanmar volta a giustificare le loro azioni, perché un’informazione veritiera è importante in una democrazia. Chiediamo la protezione dei giornalisti arrestati e molestati per aver condiviso con il resto del mondo notizie e informazioni su ciò che sta accadendo sul campo; dovrebbero invece godere della libertà di stampa. Deploriamo l’estremo autoritarismo che ha calpestato la costituzione della nazione, che di fatto – pur mantenendo gran parte del potere nelle forze armate – consentiva una limitata democrazia. Nonostante le sfide, il Myanmar stava muovendo i primi passi verso la democrazia, dando alla gente speranza per un nuovo futuro. Questa speranza dovrebbe essere restituita. Soprattutto ascoltiamo il messaggio del popolo del Myanmar: questo colpo di stato riguarda essenzialmente il loro rovesciamento, della loro volontà. In ultima analisi, non si tratta di rimuovere gli oppositori politici o il presunto ordine pubblico. Esso annulla anni di paziente lavoro per i diritti fondamentali dei cittadini e schiaccia i tenui sogni di un paese libero e democratico. Come organizzazioni cattoliche, ci uniamo a Papa Francesco e ai leader civili e religiosi di tutto il mondo che hanno condannato il colpo di stato e chiedono un “dialogo significativo” per ripristinare la democrazia. Inoltre, ci uniamo ad altre organizzazioni nel chiedere:
Siamo accompagnati da Pax Christi International e dai suoi membri nella regione Asia-Pacifico che, nella loro dichiarazione di febbraio sullo “Stato di emergenza” in Myanmar, hanno già espresso gravi preoccupazioni per la situazione nel Paese. Allo stesso modo, il movimento internazionale dei Focolari si unisce a noi in solidarietà con il popolo birmano. Ogni giorno persone coraggiose, tra cui molti giovani, tornano in piazza per protestare pacificamente, nonostante gli spari dei soldati. Come simbolo della loro protesta, segno della giusta rabbia del popolo verso i militari, sentiamo il fragore di pentole e padelle, secondo l’usanza birmana per proteggersi dagli spiriti maligni. Assistiamo alla detenzione arbitraria – con accuse fabbricate – di membri del governo democraticamente eletto, nonché di leader civili e religiosi che hanno preso parte alla lunga lotta per la democrazia. Rifiutiamo la campagna di disinformazione dei militari del Myanmar volta a giustificare le loro azioni, perché un’informazione veritiera è importante in una democrazia. Chiediamo la protezione dei giornalisti arrestati e molestati per aver condiviso con il resto del mondo notizie e informazioni su ciò che sta accadendo sul campo; dovrebbero invece godere della libertà di stampa. Deploriamo l’estremo autoritarismo che ha calpestato la costituzione della nazione, che di fatto – pur mantenendo gran parte del potere nelle forze armate – consentiva una limitata democrazia. Nonostante le sfide, il Myanmar stava muovendo i primi passi verso la democrazia, dando alla gente speranza per un nuovo futuro. Questa speranza dovrebbe essere restituita. Soprattutto ascoltiamo il messaggio del popolo del Myanmar: questo colpo di stato riguarda essenzialmente il loro rovesciamento, della loro volontà. In ultima analisi, non si tratta di rimuovere gli oppositori politici o il presunto ordine pubblico. Esso annulla anni di paziente lavoro per i diritti fondamentali dei cittadini e schiaccia i tenui sogni di un paese libero e democratico. Come organizzazioni cattoliche, ci uniamo a Papa Francesco e ai leader civili e religiosi di tutto il mondo che hanno condannato il colpo di stato e chiedono un “dialogo significativo” per ripristinare la democrazia. Inoltre, ci uniamo ad altre organizzazioni nel chiedere:
- il rilascio di Aung San Suu Kyi e di altri funzionari e leader detenuti;
- ai militari uno stop alla violenza e alla detenzione arbitraria di manifestanti pacifici e giornalisti;
- giustizia e responsabilità per le atrocità commesse dall’esercito contro il popolo Rohingya e altre minoranze etniche, nonché la prevenzione di tali crimini e abusi in futuro;
- ai membri della comunità internazionale, in particolare nella regione Asia-Pacifico, di fare pressione sul regime affinché si dimetta e ristabilisca la democrazia, e di non sfruttare la situazione per i propri interessi geopolitici.
Chiediamo ai membri di SIGNIS, di Pax Christi International e del Movimento dei Focolari in tutto il mondo di dare voce al grido del popolo birmano contattando i media locali e nazionali per segnalare la situazione e sollecitando i loro governi a intraprendere forti azioni diplomatiche per opporsi al colpo di stato e riportare la democrazia in Myanmar. La nostra missione come organizzazioni è promuovere la pace. Con l’arcivescovo di Yangoon, card. Charles Maung Bo, presidente della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche, sosteniamo: “La pace è possibile. La pace è l’unica via. La democrazia è l’unica luce verso questo percorso”. Scarica la dichiarazione (altro…)
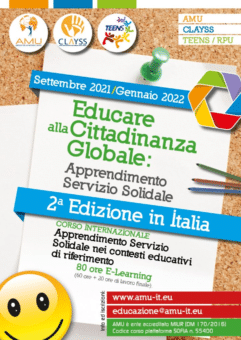
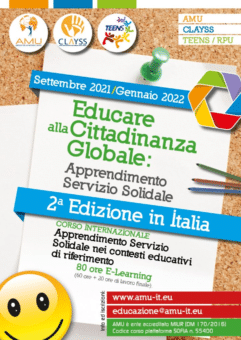 Dopo un primo esordio molto positivo, cui hanno partecipato 91 tra docenti ed educatori, anche quest’anno verrà riproposto il corso “Educare alla Cittadinanza Globale: l’apprendimento servizio solidale” nella sua II edizione. Si tratta di un percorso rivolto a tutti coloro che, coinvolti nell’ambito dell’educazione, vogliono formarsi alla vita civile attraverso un focus particolare: la messa in pratica del servizio solidale. Tra gli obiettivi del corso vi è dunque quello di formare i partecipanti affinché si facciano promotori di percorsi di cittadinanza attiva e globale, favorendo il pensiero critico, il coinvolgimento e il protagonismo giovanile, in un’ottica solidale di apprendimento. Il corso è organizzato dall’AMU, Azione per un Mondo Unito, in partnership con CLAYSS, Centro Latino-Americano per l’apprendimento servizio, in collaborazione il Movimento Ragazzi per l’Unità dei Focolari. Le lezioni si terranno dall’8 settembre 2021 fino a gennaio 2022 per un totale di 80 ore in modalità e-learning su una piattaforma didattica interattiva. 60 ore saranno dedicate all’apprendimento individuale (non lezioni in streaming); le altre 20 ore serviranno alla realizzazione di un lavoro finale. Ogni modulo sarà caratterizzato da video tematici, contenuti testuali e approfondimenti relativi alla tematica trattata. Durante la formazione, ogni partecipante sarà seguito passo dopo passo da un tutor specializzato, a completa disposizione anche tramite colloqui individuali e videochiamate periodiche. Per ogni sessione modulare sono previste attività finalizzate ad imparare come i contenuti acquisiti possano essere applicati all’interno dei propri contesti educativi. La formazione prevede anche dei momenti di scambio e condivisione tra i partecipanti tramite attività e riunioni telematiche periodiche, utili ed interessanti specialmente grazie all’internazionalità del corso. Una volta concluso il percorso, AMU rilascerà un attestato di partecipazione di 80 ore complessive. Tra i partecipanti alla prima edizione molti si sono espressi positivamente riguardo al percorso offerto. Sono stati apprezzati soprattutto: lo stile pedagogico del corso, particolarmente adatto a rendere cittadini attivi sia i docenti che i giovani; la piattaforma ben curata; il sostegno e la vicinanza da parte di tutor professionali; la dedizione e la fantasia dei docenti; l’arricchimento culturale dato dalla partecipazione internazionale. Si tratta dunque di un corso ricco che può permettere a tanti docenti ed educatori di approfondire competenze ed abilità nell’ambito della cittadinanza, per imparare ed insegnare ad essere cittadini attivi. Informazioni
Dopo un primo esordio molto positivo, cui hanno partecipato 91 tra docenti ed educatori, anche quest’anno verrà riproposto il corso “Educare alla Cittadinanza Globale: l’apprendimento servizio solidale” nella sua II edizione. Si tratta di un percorso rivolto a tutti coloro che, coinvolti nell’ambito dell’educazione, vogliono formarsi alla vita civile attraverso un focus particolare: la messa in pratica del servizio solidale. Tra gli obiettivi del corso vi è dunque quello di formare i partecipanti affinché si facciano promotori di percorsi di cittadinanza attiva e globale, favorendo il pensiero critico, il coinvolgimento e il protagonismo giovanile, in un’ottica solidale di apprendimento. Il corso è organizzato dall’AMU, Azione per un Mondo Unito, in partnership con CLAYSS, Centro Latino-Americano per l’apprendimento servizio, in collaborazione il Movimento Ragazzi per l’Unità dei Focolari. Le lezioni si terranno dall’8 settembre 2021 fino a gennaio 2022 per un totale di 80 ore in modalità e-learning su una piattaforma didattica interattiva. 60 ore saranno dedicate all’apprendimento individuale (non lezioni in streaming); le altre 20 ore serviranno alla realizzazione di un lavoro finale. Ogni modulo sarà caratterizzato da video tematici, contenuti testuali e approfondimenti relativi alla tematica trattata. Durante la formazione, ogni partecipante sarà seguito passo dopo passo da un tutor specializzato, a completa disposizione anche tramite colloqui individuali e videochiamate periodiche. Per ogni sessione modulare sono previste attività finalizzate ad imparare come i contenuti acquisiti possano essere applicati all’interno dei propri contesti educativi. La formazione prevede anche dei momenti di scambio e condivisione tra i partecipanti tramite attività e riunioni telematiche periodiche, utili ed interessanti specialmente grazie all’internazionalità del corso. Una volta concluso il percorso, AMU rilascerà un attestato di partecipazione di 80 ore complessive. Tra i partecipanti alla prima edizione molti si sono espressi positivamente riguardo al percorso offerto. Sono stati apprezzati soprattutto: lo stile pedagogico del corso, particolarmente adatto a rendere cittadini attivi sia i docenti che i giovani; la piattaforma ben curata; il sostegno e la vicinanza da parte di tutor professionali; la dedizione e la fantasia dei docenti; l’arricchimento culturale dato dalla partecipazione internazionale. Si tratta dunque di un corso ricco che può permettere a tanti docenti ed educatori di approfondire competenze ed abilità nell’ambito della cittadinanza, per imparare ed insegnare ad essere cittadini attivi. Informazioni 



 Dal 2011 è nato un ponte di solidarietà fra l’Italia e Mae Sot. La comunità dei Focolari di Latina nel centro Italia, insieme ad alcuni alunni dell’insegnante Maria Grazia Fabietti, hanno iniziato a far qualcosa per aiutare i bambini e le persone che vivono a confine fra la Thailandia e il Myanmar. “Per il 50-esimo compleanno di uno di questi amici italiani, Paolo Magli, vennero raccolti dei soldi per aiutare questi gruppi di etnia Karen (una popolazione fuggita dalla Birmania durante i conflitti e costretti da anni a vivere come profughi al confine tra Myanmar e Thailandia), sia nel campo profughi di Mae La e soprattutto fuori – spiega ancora Luigi -. Era l’inizizo di Goccia dopo Goccia. Oggi, questa realtà aiuta più di 3300 persone in tre paesi del sud est asiatico e collabora anche con l’associazione
Dal 2011 è nato un ponte di solidarietà fra l’Italia e Mae Sot. La comunità dei Focolari di Latina nel centro Italia, insieme ad alcuni alunni dell’insegnante Maria Grazia Fabietti, hanno iniziato a far qualcosa per aiutare i bambini e le persone che vivono a confine fra la Thailandia e il Myanmar. “Per il 50-esimo compleanno di uno di questi amici italiani, Paolo Magli, vennero raccolti dei soldi per aiutare questi gruppi di etnia Karen (una popolazione fuggita dalla Birmania durante i conflitti e costretti da anni a vivere come profughi al confine tra Myanmar e Thailandia), sia nel campo profughi di Mae La e soprattutto fuori – spiega ancora Luigi -. Era l’inizizo di Goccia dopo Goccia. Oggi, questa realtà aiuta più di 3300 persone in tre paesi del sud est asiatico e collabora anche con l’associazione 
