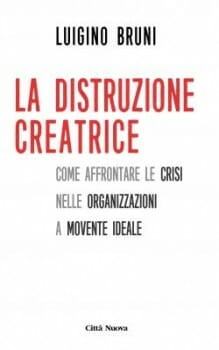Giu 3, 2016 | Centro internazionale
 «Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».
«Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».  Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)
Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)

Mag 22, 2016 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo
 L’inculturazione non è un’azione che si fa mediante un certo accomodamento del Vangelo o dei costumi cristiani, a usanze e culture di un popolo, ma una conseguenza del mistero dell’Incarnazione. Nel tempo moderno vediamo il formarsi di una cultura che non integra più il Vangelo. È la cultura dello sviluppo e del progresso scientifico e tecnico, completamente slegati dai fondamenti cristiani. Una cultura che ha creato un unico spazio mondiale nel quale vive tutta l’umanità. La cultura africana non è una cultura tecnologica, come non lo è la cultura asiatica, anche se africani e asiatici tendono allo stesso sviluppo. Ma hanno valori diversi e idee diverse. Queste diverse culture e tradizioni, se non partecipano allo sviluppo tecnologico non possono sopravvivere, si perdono. Ciò che può creare un’unità mondiale di carattere non tecnico è il Vangelo. Una convivenza di tante culture nell’unico mondo. Il Vangelo può far sì che culture diverse entrino in un dialogo fra loro che le fa sviluppare e cambiare. Ma non in una uguaglianza solamente esteriore, ma in un dialogo nell’unica verità e nell’unico sistema di valori cristiani. Così possiamo salvare l’unità e possiamo anche salvare la pluralità. Questa è la sfida di oggi. Se come cristiani non lo facciamo abbiamo perso una chance, non affrontiamo una sfida storica che ci è data in questo momento. Inculturazione vuol dire prendere sul serio quei valori e quelle tradizioni umane che sono dovunque, non per farne un museo, non per un relativismo in cui ciascuno possa vivere, ma per creare un dialogo nella verità. Verità che non può essere imposta ma offerta liberamente. La nuova evangelizzazione è ‘nuova’ in quanto non esiste più la cultura cristiana. Nello stesso senso dev’essere un’evangelizzazione anche di quelle culture che finora non hanno avuto un serio incontro con il cristianesimo. E con quale forza questo può succedere se non con quel ‘farsi uno’ dell’amore che è il medesimo amore con il quale Cristo ha assunto la nostra carne, la nostra natura umana, ed è diventato uno di noi? L’amore che ha portato Gesù ad incarnarsi ci deve spingere a ‘farci uno’ con tutte le culture, senza perdere l’unicità e l’autenticità del Vangelo. La spiritualità dei Focolari, che essendo vita riesce ad unire al di là delle frontiere e dei limiti delle singole culture, costituisce anche un legame fra le culture. È come un liquido che, proprio perché è una vita, si assimila a tutti i tipi di cultura. Se noi viviamo il Vangelo allo stato puro e, con un amore che si fa vuoto di sé, perdiamo le nostre radici culturali per ‘farci uno’ non solo con il singolo prossimo ma anche con la sua cultura, allora anche lui può essere attivo e dare ciò che ha in sé, e offrire i suoi tesori trasformati e purificati dal vivere il Vangelo, valori che nello stesso tempo illuminano e fanno capire il Vangelo. In questa luce bianca del Vangelo, posso vedere la luce dell’altro e dare a lui la mia luce e la mia cultura. Così non facciamo una strada a senso unico: vivendo nel medesimo mondo, diamo e riceviamo la cultura e il Vangelo dell’altro, e diamo la nostra. E l’altro fa lo stesso, in un dinamismo d’amore che è la Buona Novella del Vangelo, quella che Gesù ha portato sulla terra. Per farci vivere già in questo mondo la cultura del Cielo. (Sintesi a cura del teologo tedesco Wilfried Hagemann, biografo di mons. Klaus Hemmerle). (altro…)
L’inculturazione non è un’azione che si fa mediante un certo accomodamento del Vangelo o dei costumi cristiani, a usanze e culture di un popolo, ma una conseguenza del mistero dell’Incarnazione. Nel tempo moderno vediamo il formarsi di una cultura che non integra più il Vangelo. È la cultura dello sviluppo e del progresso scientifico e tecnico, completamente slegati dai fondamenti cristiani. Una cultura che ha creato un unico spazio mondiale nel quale vive tutta l’umanità. La cultura africana non è una cultura tecnologica, come non lo è la cultura asiatica, anche se africani e asiatici tendono allo stesso sviluppo. Ma hanno valori diversi e idee diverse. Queste diverse culture e tradizioni, se non partecipano allo sviluppo tecnologico non possono sopravvivere, si perdono. Ciò che può creare un’unità mondiale di carattere non tecnico è il Vangelo. Una convivenza di tante culture nell’unico mondo. Il Vangelo può far sì che culture diverse entrino in un dialogo fra loro che le fa sviluppare e cambiare. Ma non in una uguaglianza solamente esteriore, ma in un dialogo nell’unica verità e nell’unico sistema di valori cristiani. Così possiamo salvare l’unità e possiamo anche salvare la pluralità. Questa è la sfida di oggi. Se come cristiani non lo facciamo abbiamo perso una chance, non affrontiamo una sfida storica che ci è data in questo momento. Inculturazione vuol dire prendere sul serio quei valori e quelle tradizioni umane che sono dovunque, non per farne un museo, non per un relativismo in cui ciascuno possa vivere, ma per creare un dialogo nella verità. Verità che non può essere imposta ma offerta liberamente. La nuova evangelizzazione è ‘nuova’ in quanto non esiste più la cultura cristiana. Nello stesso senso dev’essere un’evangelizzazione anche di quelle culture che finora non hanno avuto un serio incontro con il cristianesimo. E con quale forza questo può succedere se non con quel ‘farsi uno’ dell’amore che è il medesimo amore con il quale Cristo ha assunto la nostra carne, la nostra natura umana, ed è diventato uno di noi? L’amore che ha portato Gesù ad incarnarsi ci deve spingere a ‘farci uno’ con tutte le culture, senza perdere l’unicità e l’autenticità del Vangelo. La spiritualità dei Focolari, che essendo vita riesce ad unire al di là delle frontiere e dei limiti delle singole culture, costituisce anche un legame fra le culture. È come un liquido che, proprio perché è una vita, si assimila a tutti i tipi di cultura. Se noi viviamo il Vangelo allo stato puro e, con un amore che si fa vuoto di sé, perdiamo le nostre radici culturali per ‘farci uno’ non solo con il singolo prossimo ma anche con la sua cultura, allora anche lui può essere attivo e dare ciò che ha in sé, e offrire i suoi tesori trasformati e purificati dal vivere il Vangelo, valori che nello stesso tempo illuminano e fanno capire il Vangelo. In questa luce bianca del Vangelo, posso vedere la luce dell’altro e dare a lui la mia luce e la mia cultura. Così non facciamo una strada a senso unico: vivendo nel medesimo mondo, diamo e riceviamo la cultura e il Vangelo dell’altro, e diamo la nostra. E l’altro fa lo stesso, in un dinamismo d’amore che è la Buona Novella del Vangelo, quella che Gesù ha portato sulla terra. Per farci vivere già in questo mondo la cultura del Cielo. (Sintesi a cura del teologo tedesco Wilfried Hagemann, biografo di mons. Klaus Hemmerle). (altro…)

Mar 31, 2016 | Centro internazionale

Foto © CSC Audiovisivi

Mar 5, 2016 | Cultura
 «Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]
«Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]  È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]
È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]  Ci sono molte cose buone nella nostra vita che non sono misurate sull’asse della nostra felicità, e alcune neanche sull’asse della felicità degli altri. Le scelte più importanti sono quasi sempre scelte tragiche: non scegliamo tra un bene e un male, ma tra due o più beni. E ci sono anche decisioni nelle quali usciamo dal registro del calcolo. E altri momenti dove non riusciamo neanche a scegliere, ma, forse, pronunciare docili soltanto un “sì”. La terra è abitata da molte donne e uomini che in certi momenti decisivi non cercano la propria felicità. Anche se Aristotele ci ha insegnato che la felicità (eudaimonia) è il fine ultimo, il sommo bene, nella vita i fini ultimi e i sommi beni sono più di uno, e possono entrare in conflitto tra di loro. Molte delle cose grandi e degne della vita si collocano all’incrocio di questi molti beni, ed è lì dove si fanno le scelte decisive. Felicità, verità, giustizia, fedeltà, sono tutti beni primari, originari, che non possono essere ricondotti a uno solo, fosse anche la felicità. Possiamo avere una chiara idea di quale è la scelta che ci farà più felici, possiamo includere in quella felicità quasi tutte le cose belle vita, anche quelle più alte, ma nonostante ciò possiamo decidere liberamente di non scegliere la nostra felicità se ci sono altri valori in gioco che ci chiamano. E magari alla fine scoprire una parola nuova: la gioia, che a differenza della felicità non può essere cercata, ma solo accolta come dono. Chi ha lasciato il proprio segno buono sulla terra, non ha vissuto la vita inseguendo la propria felicità. L’ha considerata troppo piccola. L’ha vista, qualche volta, ma non si è fermato a raccoglierla; ha preferito continuare a camminare dietro a una voce. Alla fine della corsa non resterà la felicità che abbiamo accumulato, ma se resterà qualcosa saranno cose molto più vere e serie. Siamo molto più grandi della nostra felicità. […] Luigino Bruni La voce dei giorni/1 – Leggi il testo intero in italiano (Fonte: Avvenire) (altro…)
Ci sono molte cose buone nella nostra vita che non sono misurate sull’asse della nostra felicità, e alcune neanche sull’asse della felicità degli altri. Le scelte più importanti sono quasi sempre scelte tragiche: non scegliamo tra un bene e un male, ma tra due o più beni. E ci sono anche decisioni nelle quali usciamo dal registro del calcolo. E altri momenti dove non riusciamo neanche a scegliere, ma, forse, pronunciare docili soltanto un “sì”. La terra è abitata da molte donne e uomini che in certi momenti decisivi non cercano la propria felicità. Anche se Aristotele ci ha insegnato che la felicità (eudaimonia) è il fine ultimo, il sommo bene, nella vita i fini ultimi e i sommi beni sono più di uno, e possono entrare in conflitto tra di loro. Molte delle cose grandi e degne della vita si collocano all’incrocio di questi molti beni, ed è lì dove si fanno le scelte decisive. Felicità, verità, giustizia, fedeltà, sono tutti beni primari, originari, che non possono essere ricondotti a uno solo, fosse anche la felicità. Possiamo avere una chiara idea di quale è la scelta che ci farà più felici, possiamo includere in quella felicità quasi tutte le cose belle vita, anche quelle più alte, ma nonostante ciò possiamo decidere liberamente di non scegliere la nostra felicità se ci sono altri valori in gioco che ci chiamano. E magari alla fine scoprire una parola nuova: la gioia, che a differenza della felicità non può essere cercata, ma solo accolta come dono. Chi ha lasciato il proprio segno buono sulla terra, non ha vissuto la vita inseguendo la propria felicità. L’ha considerata troppo piccola. L’ha vista, qualche volta, ma non si è fermato a raccoglierla; ha preferito continuare a camminare dietro a una voce. Alla fine della corsa non resterà la felicità che abbiamo accumulato, ma se resterà qualcosa saranno cose molto più vere e serie. Siamo molto più grandi della nostra felicità. […] Luigino Bruni La voce dei giorni/1 – Leggi il testo intero in italiano (Fonte: Avvenire) (altro…)
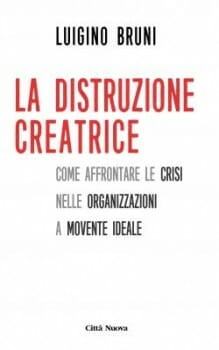
Dic 30, 2015 | Chiesa, Cultura, Focolari nel Mondo
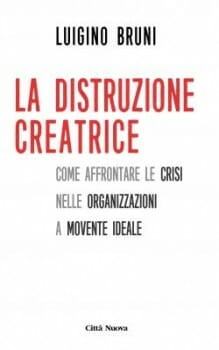 «Bruni aveva ben chiaro dove l’avrebbe condotto a ragionare, al confine tra umano e disumano e purtroppo anche oltre, di organizzazioni complesse a movente (prevalentemente) materiale. Sapeva perfettamente che scrivere di esse, cioè delle organizzazioni della “produzione” e del “mercato” e, dunque, della creatività, delle relazioni e del lavoro, l’avrebbe portato a concentrarsi anche sulle organizzazioni a movente ideale e su altri movimenti dello spirito umano», ponendo ambedue «davanti alla stessa sfida: rinnovarsi senza perdere radici e anima». Così scrive Marco Tarquinio, direttore del quotidiano cattolico Avvenire, nell’introduzione del nuovo lavoro “La distruzione creatrice”, dell’economista e filosofo Luigino Bruni. Si tratta di una volumetto pubblicato dall’Editrice Città Nuova che raccoglie una selezione di articoli pubblicati durante il 2015 su Avvenire e tratti dalle serie “Le levatrici di Egitto” e “Rigenerazioni”. “È nelle periferie che s’impara a risorgere”, è il titolo dell’ultimo capitolo col quale Bruni approda alle conclusioni del suo lavoro e alle sfide della riflessione, durata alcuni mesi. La frase scelta per introdurre le sue proposte è del poeta tedesco Friedrich Hölderlin: “Dio ha creato l’uomo come il mare crea i continenti: ritirandosi”. A mo’ di presentazione, anticipiamo alcuni passaggi: «Un movimento diventato nel tempo organizzazione può conoscere una nuova primavera carismatica, può risorgere, se in qualche zona marginale del “regno” alcune minoranze creative iniziano a ricostituire le condizioni per rivivere lo stesso miracolo della prima fondazione del carisma: lo stesso entusiasmo, la stessa gioia, gli stessi frutti. Il vero processo che porta queste minoranze a diventare maggioranza si chiama riforma […]. Un processo decisivo che andrebbe fatto senza fretta e coinvolgendo e attivando i luoghi vivi della creatività, raggiungendoli “ai confini dell’impero”. Tutto ciò è certamente e prima di tutto dono (charis), ma è anche saggezza organizzativa, intelligenza spirituale e profonda, profetica e trasformatrice. […] Molte nuove “evangelizzazioni” accadono quando nel raccontare agli altri la buona novella riusciamo nuovamente e diversamente a risentirla viva anche in noi. È così che rinasce una nuova-antica storia di amore, un nuovo eros, nuovi desideri, nuova generatività, nuovi bambini. […] Il carisma allora può rifiorire tornando a incontrare le persone lungo le strade, dimenticando le proprie organizzazioni per occuparsi delle ferite e dei dolori degli uomini e delle donne di oggi, soprattutto dei più poveri […] interpretando creativamente la propria missione nel tempo presente». (altro…)
«Bruni aveva ben chiaro dove l’avrebbe condotto a ragionare, al confine tra umano e disumano e purtroppo anche oltre, di organizzazioni complesse a movente (prevalentemente) materiale. Sapeva perfettamente che scrivere di esse, cioè delle organizzazioni della “produzione” e del “mercato” e, dunque, della creatività, delle relazioni e del lavoro, l’avrebbe portato a concentrarsi anche sulle organizzazioni a movente ideale e su altri movimenti dello spirito umano», ponendo ambedue «davanti alla stessa sfida: rinnovarsi senza perdere radici e anima». Così scrive Marco Tarquinio, direttore del quotidiano cattolico Avvenire, nell’introduzione del nuovo lavoro “La distruzione creatrice”, dell’economista e filosofo Luigino Bruni. Si tratta di una volumetto pubblicato dall’Editrice Città Nuova che raccoglie una selezione di articoli pubblicati durante il 2015 su Avvenire e tratti dalle serie “Le levatrici di Egitto” e “Rigenerazioni”. “È nelle periferie che s’impara a risorgere”, è il titolo dell’ultimo capitolo col quale Bruni approda alle conclusioni del suo lavoro e alle sfide della riflessione, durata alcuni mesi. La frase scelta per introdurre le sue proposte è del poeta tedesco Friedrich Hölderlin: “Dio ha creato l’uomo come il mare crea i continenti: ritirandosi”. A mo’ di presentazione, anticipiamo alcuni passaggi: «Un movimento diventato nel tempo organizzazione può conoscere una nuova primavera carismatica, può risorgere, se in qualche zona marginale del “regno” alcune minoranze creative iniziano a ricostituire le condizioni per rivivere lo stesso miracolo della prima fondazione del carisma: lo stesso entusiasmo, la stessa gioia, gli stessi frutti. Il vero processo che porta queste minoranze a diventare maggioranza si chiama riforma […]. Un processo decisivo che andrebbe fatto senza fretta e coinvolgendo e attivando i luoghi vivi della creatività, raggiungendoli “ai confini dell’impero”. Tutto ciò è certamente e prima di tutto dono (charis), ma è anche saggezza organizzativa, intelligenza spirituale e profonda, profetica e trasformatrice. […] Molte nuove “evangelizzazioni” accadono quando nel raccontare agli altri la buona novella riusciamo nuovamente e diversamente a risentirla viva anche in noi. È così che rinasce una nuova-antica storia di amore, un nuovo eros, nuovi desideri, nuova generatività, nuovi bambini. […] Il carisma allora può rifiorire tornando a incontrare le persone lungo le strade, dimenticando le proprie organizzazioni per occuparsi delle ferite e dei dolori degli uomini e delle donne di oggi, soprattutto dei più poveri […] interpretando creativamente la propria missione nel tempo presente». (altro…)

 «Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».
«Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali», affermava il prof. Adam Biela nella Laudatio per il conferimento alla Lubich del dottorato h.c. in Scienze Sociali all’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II nel giugno 1996. Spiegò allora come tale messaggio «costituisce un vivo esempio di come un nuovo paradigma nelle scienze sociali non solo è possibile, ma si deve necessariamente costruire». Lo definì «paradigma dell’unità» attribuendogli un ruolo ispiratore per le scienze sociali paragonato «alla rivoluzione copernicana per le scienze naturali». A quel primo riconoscimento ne seguirono altri 15 da parte di varie università nel mondo. 20 anni dopo l’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II vuole fare il punto e, in partenariato con il Centro per il Dialogo con la Cultura dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia, organizza un convegno di riflessione e di ricerca su “Conflitto, dialogo e cultura dell’unità”. Dalle prospettive disciplinari della psicologia, economia, pedagogia, politologia, sociologia e comunicazione, il presente convegno, dichiara oggi il prof. Adam Biela, «analizzerà quanto la ricerca e la pratica ispirate dal paradigma dell’unità, che è fondato sulla spiritualità dell’unità, possono offrire alle questioni concettuali e applicate riguardanti la costruzione dell’integrazione sociale, economica e politica nell’Europa contemporanea e nel mondo». Sotto particolare osservazione, afferma ancora il prof. Biela, «l’attività sociale di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari nel costruire strutture psicosociali per l’unità in vari ambiti sociali».  Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)
Ad un call for papers hanno risposto oltre 90 ricercatori e studiosi di molte parti del mondo, inviando i propri abstract in relazione alle cinque aree tematiche in cui si articolerà il convegno: dialogo nelle comunità: tra carisma e istituzione; risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo; attori del cambiamento politico e processi di partecipazione; processi individuali, interpersonali e intergruppo nella gestione e nella prevenzione dei conflitti; dialogo tra le discipline e transdisciplinarietà. Relatori principali, oltre al prof. Adam Biela e Jesús Morán, copresidente dei Focolari che offre la relazione iniziale, sono i professori Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia Loppiano, Italia), Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano, Italia), Bogusław Śliwerski (Università di Lodz, Polonia), Marek Rembierz (Università di Slesia, Polonia), Stefano Zamagni, (Università di Bologna, Italia), Krzysztof Wielecki (Università Wyszynski di Varsavia, Polonia), Catherine Belzung (Università di Tours, Francia), John Raven (Università di Manchester, Regno Unito). Il convegno ha inizio il giorno del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università. Lo precederà la Cerimonia ufficiale con cui l’Ateneo celebra questa festa, presieduta dal Magnifico Rettore prof. Antoni Dębiński, con la partecipazione del Nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore e di altre personalità civili e religiose. Info: http://psychointerwencja.wix.com/congress Fonte: Comunicato stampa SIF (altro…)



 «Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]
«Un giorno ti dirò, che ho rinunciato alla mia felicità, per te». Le prime parole della canzone degli Stadio, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è una buona occasione per riflettere sulla felicità nostra e su quella degli altri. La nostra civiltà ha messo la ricerca della felicità individuale al centro del proprio umanesimo, relegando sempre più sullo sfondo altri valori e la felicità degli altri – a meno che non siano un mezzo per aumentare la nostra felicità. E così non abbiamo più le categorie per poter comprendere le scelte (che ancora esistono) di chi rinuncia, consapevolmente, alla propria felicità per quella di un’altra persona. […] La felicità ha una storia molto lunga. L’umanesimo cristiano, innovando molto rispetto alla cultura greca e romana, fin dall’inizio ha proposto una visione della “felicità limitata”, dove la ricerca della nostra felicità non era considerata il fine ultimo della vita, perché veniva subordinata ad altri valori, quali la felicità della comunità, della famiglia, o il paradiso. Per secoli abbiamo pensato che la sola felicità degna di essere raggiunta fosse quella degli altri e quella di tutti. La pietra angolare dell’educazione della generazione dei nostri genitori consisteva nel mettere la felicità dei figli prima della loro. Sono numerose come i granelli della sabbia del mare le donne che hanno rinunciato, a volte liberamente, alla propria felicità per consentire ai loro figli di essere felici, o almeno più felici di loro. […]  È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]
È stata questa “dinamica intertemporale della felicità” che ha legato e affratellato le generazioni tra di loro, che ha fatto partire gli emigranti per mandare a casa la maggior parte del loro salario amaro, e che spesso li ha fatti ritornare. […] Nell’età moderna questa antica e radicata idea di felicità è entrata profondamente in crisi, e al suo posto si è fatta strada l’idea, che era tipica del mondo pre-cristiano, che la nostra felicità sia il bene ultimo e assoluto, il fine rispetto al quale qualsiasi altro obiettivo diventa ancillare e subordinato. E così, in America “la ricerca della felicità” (1776) veniva proclamato diritto individuale inalienabile, e posto accanto alla vita e alla libertà a formare i tre pilastri della civiltà dei moderni. Il mondo latino e cattolico, invece, più legato alle sue radici medievali, ha continuato a considerare la felicità individuale una parola insufficiente per fondarci la società. […] L’economia contemporanea, con la sua matrice culturale anglosassone, si è sposata perfettamente con l’ideale della felicità individuale. […] Per l’economia, il mondo è abitato soltanto da persone che vogliono soddisfare al massimo la propria felicità. […] Da questa prospettiva, che domina l’economia e sempre più la vita, non è quindi possibile scegliere di ridurre volontariamente la nostra felicità. Solo gli stupidi, si pensa, decidono intenzionalmente di ridurre il proprio benessere. Questa descrizione delle scelte umane riesce a spiegare molte cose, ma è inutile o fuorviante quando dobbiamo spiegare quelle poche, ma decisive scelte dalle quali dipende quasi tutta la qualità morale e spirituale della nostra vita. Quando Abramo decise di incamminarsi con Isacco verso il Monte Moria non pensava certo alla propria felicità […] ma certamente stava seguendo una voce, dolorosissima, che lo chiamava. E, come lui, tanti continuano a salire i Monti Moria della loro vita. I momenti, gli atti e le scelte nel corso della nostra esistenza non sono tutti uguali. […]