
14 Ott 2015 | Cultura, Focolari nel Mondo, Spiritualità
 «Il Nobel 2015 assegnato ad Angus Deaton per i suoi studi sullo sviluppo economico, sul benessere, sulla diseguaglianza, sui consumi e sulle determinanti della povertà è un segnale molto importante: dopo alcuni anni in cui, in piena crisi finanziaria, Stoccolma ed i suoi consulenti continuavano a premiare gli economisti che avevano studiato e promosso l’economia e la finanza e avevano contribuito a generare la crisi, col Nobel a Deaton si torna a premiare, nel luogo più importante per la scienza contemporanea, scienziati sociali a tutto tondo, continuatori della scienza politica o civile che è all’origine dell’economia moderna. La politica di Stoccolma è stata alquanto bizzarra negli ultimi anni: dal 2010 al 2013, mentre il capitalismo stava rischiando di implodere sotto una crisi finanziaria mai conosciuta prima di allora, i Nobel per l’Economia sono stati assegnati ad alcuni economisti tra i maggiori teorici di quel paradigma economico e finanziario che stava mostrando tutti i suoi drammatici limiti. Come se, durante un’estate con il più alto numero di incendi dolosi mai registrati, venissero assegnati premi a coloro che studiano tecniche sofisticate di accensione avanzata di incendi. Ecco perché questo Nobel e anche, in misura diversa, quello dello scorso anno assegnato al francese Jean Tirole potrebbero indicare una prima inversione di tendenza essendo Deaton molto più simile a premi Nobel come Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, Elinor Ostrom che ai più recenti Eugene Fama e Lloyd Stowell Shapley. Non dobbiamo dimenticare che la crisi finanziaria ed economica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non è indipendente dalle teorie economiche degli ultimi decenni, perché a differenza degli astrofisici le cui teorie non modificano le orbite dei pianeti, gli economisti e le loro le teorie condizionano fortemente le scelte economiche. Negli ultimi anni i migliori dipartimenti di economia del mondo si sono riempiti di economisti sempre più matematici, con una formazione umanistica sempre più scarsa, espertissimi di modelli iper-specializzati e non più capaci in massima parte di avere una visione di insieme del sistema economico, e quindi di associare i loro modelli con la realtà economica e sociale. Inoltre il premio a Deaton che fa seguito a quello dato a Tirole, potrebbe indicare un ritorno di una teoria economica più europea, più attenta alla dimensione sociale della professione, una maggiore sensibilità per i temi del benessere collettivo e non solo dei profitti e delle rendite individuali. Questa possibile alba troverà però il suo mezzodì se i prossimi Nobel vedranno più economisti filosofi e meno economisti matematici, come scriveva già nel 1991 l’economista inglese Robert Sugden: “L’economista oggi deve tornare a essere più filosofo e meno matematico”. Un invito che allora non fu raccolto dalla professione, ma forse siamo ancora in tempo. Angus Deaton poi è ancora un economista che sa scrivere libri, non solo articoli matematici. Consiglio a tutti il suo ultimo libro “La grande fuga”, nel quale il neo laureato Nobel si domanda, da autentico scienziato sociale e legittimo erede del suo compatriota Adam Smith (filosofo ed economista) se l’umanità potrà conoscere in futuro una stagione di progresso senza disuguaglianza, una domanda fondamentale quando oggi il prezzo del progresso lo stiamo pagando con una crescente disuguaglianza nel mondo e una diminuzione di felicità. L’economia potrà tornare ad essere una scienza morale amica della società se tornerà a porsi questa e simili domande, abbandonate troppo velocemente per rispondere ad altre domande molto più facili e molto meno utili al progresso umano». Luigino Bruni www.edc-online.org (altro…)
«Il Nobel 2015 assegnato ad Angus Deaton per i suoi studi sullo sviluppo economico, sul benessere, sulla diseguaglianza, sui consumi e sulle determinanti della povertà è un segnale molto importante: dopo alcuni anni in cui, in piena crisi finanziaria, Stoccolma ed i suoi consulenti continuavano a premiare gli economisti che avevano studiato e promosso l’economia e la finanza e avevano contribuito a generare la crisi, col Nobel a Deaton si torna a premiare, nel luogo più importante per la scienza contemporanea, scienziati sociali a tutto tondo, continuatori della scienza politica o civile che è all’origine dell’economia moderna. La politica di Stoccolma è stata alquanto bizzarra negli ultimi anni: dal 2010 al 2013, mentre il capitalismo stava rischiando di implodere sotto una crisi finanziaria mai conosciuta prima di allora, i Nobel per l’Economia sono stati assegnati ad alcuni economisti tra i maggiori teorici di quel paradigma economico e finanziario che stava mostrando tutti i suoi drammatici limiti. Come se, durante un’estate con il più alto numero di incendi dolosi mai registrati, venissero assegnati premi a coloro che studiano tecniche sofisticate di accensione avanzata di incendi. Ecco perché questo Nobel e anche, in misura diversa, quello dello scorso anno assegnato al francese Jean Tirole potrebbero indicare una prima inversione di tendenza essendo Deaton molto più simile a premi Nobel come Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, Elinor Ostrom che ai più recenti Eugene Fama e Lloyd Stowell Shapley. Non dobbiamo dimenticare che la crisi finanziaria ed economica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non è indipendente dalle teorie economiche degli ultimi decenni, perché a differenza degli astrofisici le cui teorie non modificano le orbite dei pianeti, gli economisti e le loro le teorie condizionano fortemente le scelte economiche. Negli ultimi anni i migliori dipartimenti di economia del mondo si sono riempiti di economisti sempre più matematici, con una formazione umanistica sempre più scarsa, espertissimi di modelli iper-specializzati e non più capaci in massima parte di avere una visione di insieme del sistema economico, e quindi di associare i loro modelli con la realtà economica e sociale. Inoltre il premio a Deaton che fa seguito a quello dato a Tirole, potrebbe indicare un ritorno di una teoria economica più europea, più attenta alla dimensione sociale della professione, una maggiore sensibilità per i temi del benessere collettivo e non solo dei profitti e delle rendite individuali. Questa possibile alba troverà però il suo mezzodì se i prossimi Nobel vedranno più economisti filosofi e meno economisti matematici, come scriveva già nel 1991 l’economista inglese Robert Sugden: “L’economista oggi deve tornare a essere più filosofo e meno matematico”. Un invito che allora non fu raccolto dalla professione, ma forse siamo ancora in tempo. Angus Deaton poi è ancora un economista che sa scrivere libri, non solo articoli matematici. Consiglio a tutti il suo ultimo libro “La grande fuga”, nel quale il neo laureato Nobel si domanda, da autentico scienziato sociale e legittimo erede del suo compatriota Adam Smith (filosofo ed economista) se l’umanità potrà conoscere in futuro una stagione di progresso senza disuguaglianza, una domanda fondamentale quando oggi il prezzo del progresso lo stiamo pagando con una crescente disuguaglianza nel mondo e una diminuzione di felicità. L’economia potrà tornare ad essere una scienza morale amica della società se tornerà a porsi questa e simili domande, abbandonate troppo velocemente per rispondere ad altre domande molto più facili e molto meno utili al progresso umano». Luigino Bruni www.edc-online.org (altro…)

28 Set 2015 | Cultura, Focolari nel Mondo
 “La vera generosità è uno scambio dalle conseguenze imprevedibili. È un rischio, perché mescola i nostri bisogni e i nostri desideri con i bisogni e i desideri degli altri.” A. Phillips e B. Taylor, Elogio della gentilezza. «Le imprese e tutte le organizzazioni restano luoghi di vita buona e intera se e fino a quando lasciano vivere virtù non economiche accanto a quelle economico-aziendali. Una coesistenza decisiva ma tutt’altro che semplice, perché chiede ai dirigenti di rinunciare al controllo totale dei comportamenti delle persone, di accettare una componente di imprevedibilità nelle loro azioni, di essere disposti a relativizzare anche l’efficienza, che sta diventando il vero dogma della nuova religione del nostro tempo. La generosità è una di queste virtù non economiche, ma essenziali anche a ogni azienda e istituzione. La radice della generosità si trova nella parola latina genus, generis, un termine che rimanda a stirpe, famiglia, nascita – è questo il primo significato della parola genere. Questa antica etimologia, oggi perduta, ci dice cose importanti sulla generosità. Innanzitutto ci ricorda che la nostra generosità ha molto a che fare con la trasmissione della vita: con la nostra famiglia, con la gente attorno a noi, con l’ambiente nel quale cresciamo e impariamo a vivere. La riceviamo in eredità venendo al mondo. È una dote che ci lasciano i nostri genitori e parenti. La generosità si forma dentro casa. Quella che ci ritroviamo dentro dipende molto dalla generosità dei nostri genitori, da come e quanto si sono amati prima che nascessimo, dalle scelte di vita che hanno fatto e di quelle che fanno mentre noi incominciamo a guardarli. Dalla loro fedeltà, dalla loro ospitalità, dal loro atteggiamento con i poveri, dalla loro disponibilità a “sprecare” tempo per ascoltare e aiutare gli amici, dal loro amore e dalla riconoscenza per i genitori. Questa generosità primaria non è una virtù individuale, ma un dono che entra a far parte della dotazione morale e spirituale di quello che si chiama carattere. È un capitale con cui arriviamo sulla terra, che si è formato prima della nostra nascita e che si alimenta della qualità delle relazioni nei primissimi anni di vita. Dipende anche dalla generosità dei nostri nonni, dei bisnonni, dei vicini di casa, e da quella di molti altri che pur non componendo il mio DNA sono comunque presenti, in modi misteriosi ma realissimi, nella mia generosità (e non generosità). È influenzata dai poeti che hanno nutrito il cuore della mia famiglia. Dalle preghiere della mia gente, dai musicisti che amo e ascolto, dai cantastorie nelle feste di paese, dai discorsi e dalle azioni dei politici, dalle omelie dei predicatori. Dai martiri di tutte le resistenze, da chi ieri ha donato la sua vita per la mia libertà di oggi. Dalle generosità infinite delle donne dei secoli passati (c’è una grande affinità tra donna e generosità), che molte volte hanno messo la fioritura della famiglia a cui hanno dato vita prima della propria – e continuano a farlo. La generosità genera riconoscenza per chi ci ha resi generosi con la sua generosità. Vivere con persone generose ci rende più generosi – proprio come accade con la preghiera, con la musica, con la bellezza …. Coltivare la generosità produce molti più effetti di quelli che riusciamo a vedere e a misurare – e lo stesso accade con la non-generosità nostra e degli altri. Lo stock di generosità di una famiglia, di una comunità, di un popolo è una specie di somma della generosità di ciascuno. Ogni generazione incrementa il valore di questo stock o lo riduce, come sta accadendo oggi in Europa, dove la nostra generazione impoverita di ideali e di passioni grandi sta dilapidando il patrimonio di generosità che ha ereditato. Un Paese che lascia metà dei suoi giovani senza lavoro, non è un paese generoso». (leggi tutto) di Luigino Bruni Pubblicato sul giornale Avvenire il 23/08/2015. (altro…)
“La vera generosità è uno scambio dalle conseguenze imprevedibili. È un rischio, perché mescola i nostri bisogni e i nostri desideri con i bisogni e i desideri degli altri.” A. Phillips e B. Taylor, Elogio della gentilezza. «Le imprese e tutte le organizzazioni restano luoghi di vita buona e intera se e fino a quando lasciano vivere virtù non economiche accanto a quelle economico-aziendali. Una coesistenza decisiva ma tutt’altro che semplice, perché chiede ai dirigenti di rinunciare al controllo totale dei comportamenti delle persone, di accettare una componente di imprevedibilità nelle loro azioni, di essere disposti a relativizzare anche l’efficienza, che sta diventando il vero dogma della nuova religione del nostro tempo. La generosità è una di queste virtù non economiche, ma essenziali anche a ogni azienda e istituzione. La radice della generosità si trova nella parola latina genus, generis, un termine che rimanda a stirpe, famiglia, nascita – è questo il primo significato della parola genere. Questa antica etimologia, oggi perduta, ci dice cose importanti sulla generosità. Innanzitutto ci ricorda che la nostra generosità ha molto a che fare con la trasmissione della vita: con la nostra famiglia, con la gente attorno a noi, con l’ambiente nel quale cresciamo e impariamo a vivere. La riceviamo in eredità venendo al mondo. È una dote che ci lasciano i nostri genitori e parenti. La generosità si forma dentro casa. Quella che ci ritroviamo dentro dipende molto dalla generosità dei nostri genitori, da come e quanto si sono amati prima che nascessimo, dalle scelte di vita che hanno fatto e di quelle che fanno mentre noi incominciamo a guardarli. Dalla loro fedeltà, dalla loro ospitalità, dal loro atteggiamento con i poveri, dalla loro disponibilità a “sprecare” tempo per ascoltare e aiutare gli amici, dal loro amore e dalla riconoscenza per i genitori. Questa generosità primaria non è una virtù individuale, ma un dono che entra a far parte della dotazione morale e spirituale di quello che si chiama carattere. È un capitale con cui arriviamo sulla terra, che si è formato prima della nostra nascita e che si alimenta della qualità delle relazioni nei primissimi anni di vita. Dipende anche dalla generosità dei nostri nonni, dei bisnonni, dei vicini di casa, e da quella di molti altri che pur non componendo il mio DNA sono comunque presenti, in modi misteriosi ma realissimi, nella mia generosità (e non generosità). È influenzata dai poeti che hanno nutrito il cuore della mia famiglia. Dalle preghiere della mia gente, dai musicisti che amo e ascolto, dai cantastorie nelle feste di paese, dai discorsi e dalle azioni dei politici, dalle omelie dei predicatori. Dai martiri di tutte le resistenze, da chi ieri ha donato la sua vita per la mia libertà di oggi. Dalle generosità infinite delle donne dei secoli passati (c’è una grande affinità tra donna e generosità), che molte volte hanno messo la fioritura della famiglia a cui hanno dato vita prima della propria – e continuano a farlo. La generosità genera riconoscenza per chi ci ha resi generosi con la sua generosità. Vivere con persone generose ci rende più generosi – proprio come accade con la preghiera, con la musica, con la bellezza …. Coltivare la generosità produce molti più effetti di quelli che riusciamo a vedere e a misurare – e lo stesso accade con la non-generosità nostra e degli altri. Lo stock di generosità di una famiglia, di una comunità, di un popolo è una specie di somma della generosità di ciascuno. Ogni generazione incrementa il valore di questo stock o lo riduce, come sta accadendo oggi in Europa, dove la nostra generazione impoverita di ideali e di passioni grandi sta dilapidando il patrimonio di generosità che ha ereditato. Un Paese che lascia metà dei suoi giovani senza lavoro, non è un paese generoso». (leggi tutto) di Luigino Bruni Pubblicato sul giornale Avvenire il 23/08/2015. (altro…)

26 Giu 2015 | Chiesa, Cultura, Spiritualità

Luigino Bruni
Alcuni commentatori, sedicenti amanti del libero mercato, hanno scritto che l’enciclica Laudato si’ è contro il mercato e contro la libertà economica, espressione dell’anti-modernismo e, addirittura, del marxismo del Papa «preso quasi alla fine del mondo». Nell’enciclica non si trova niente di tutto questo, anzi vi si trova l’opposto. Francesco ci ricorda che il mercato e l’impresa sono preziosi alleati del bene comune se non diventano ideologia, se la parte (il mercato) non diventa il tutto (la vita). Il mercato è una dimensione della vita sociale essenziale per ogni bene comune (sono molte le parole dell’enciclica che lodano gli imprenditori responsabili e le tecnologie al servizio del mercato che include e crea lavoro). Ma non è l’unica, e neppure la prima.
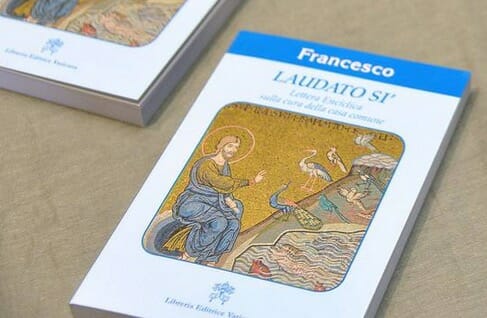 Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.
Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.
A un secondo livello, Francesco ci ricorda qualcosa di fondamentale che oggi è sistematicamente trascurato. La tanto declamata «efficienza», la parola d’ordine della nuova ideologia globale, non è mai una faccenda solo tecnica e quindi eticamente neutrale (34). I calcoli costi-benefici, che sono alla base di ogni scelta “razionale” delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, dipendono decisamente da che cosa inseriamo tra i costi e che cosa tra i benefici. Per decenni abbiamo considerato efficienti imprese che tra i costi non mettevano i danni che stavano producendo nei mari, nei fiumi, nell’atmosfera. Ma il Papa ci invita ad allargare il calcolo a tutte le specie, includendole in una fraternità cosmica, estendono la reciprocità anche ai viventi non umani, dando loro voce nei nostri bilanci economici e politici. C’è, poi, un terzo livello. Anche riconoscendo il «mutuo vantaggio» come legge fondamentale del mercato civile, e magari estendendola anche al rapporto con altre specie viventi e con la terra, il «mutuo vantaggio» non può e non deve essere l’unica legge della vita. È importante, ma non è la sola. Esistono anche quelli che l’economista e filosofo indiano Amartya Sen chiama «gli obblighi di potere». Dobbiamo agire responsabilmente nei confronti del creato perché, oggi, la tecnica ci ha attribuito un potere per determinare unilateralmente conseguenze molto gravi verso altri esseri viventi con i quali siamo legati. Tutto nell’universo è vivo, e tutto ci chiama a responsabilità. Esistono anche obblighi morali senza vantaggi per noi. Il «mutuo vantaggio» del buon mercato non basta a coprire tutto lo spettro della responsabilità e della giustizia. Anche il mercato migliore se diventa l’unico criterio si trasforma in un mostro. Nessuna logica economica ci spinge a lasciare le foreste in eredità a chi vivrà tra mille anni, eppure abbiamo obblighi morali anche verso quei futuri abitanti della terra. Molto importante è la questione del «debito ecologico» (51), che rappresenta uno dei passaggi più alti e profetici dell’enciclica. La logica spietata dei debiti degli Stati domina la terra, mette in ginocchio interi popoli (come nel caso della Grecia), e ne tiene sotto ricatto molti altri. Molto potere nel mondo è esercitato in nome del debito e del credito. Esiste però anche un grande «debito ecologico» del Nord del mondo nei confronti del Sud, di un 10% dell’umanità che ha costruito il proprio benessere scaricando i costi sull’atmosfera di tutti, e che continua a produrre “cambiamenti climatici”. L’espressione “cambiamenti” è fuorviante perché è eticamente neutrale. Il Papa parla invece di «inquinamento» e di deterioramento di quel bene comune chiamato clima (23). Il deterioramento del clima contribuisce alla desertificazione di intere regioni che influiscono decisamente sulle miserie, le morti e le migrazioni dei popoli (25). Di questo immenso «debito ecologico» e di giustizia globale non si tiene conto quando chiudiamo le nostre frontiere a chi arriva da noi perché gli stiamo bruciando la casa. Questo debito ecologico non pesa per nulla nell’ordine politico mondiale, nessuna Troika condanna un Paese perché ha inquinato e desertificato un altro Paese, e così il «debito ecologico» continua a crescere nell’indifferenza dei grandi e dei potenti. Infine, un consiglio. Chi deve ancora leggere questa meravigliosa enciclica, non inizi la lettura nel proprio studio o seduto sul divano. Esca di casa, vada in mezzo a un prato o in un bosco, e lì inizi a meditare il cantico di papa Francesco. La terra di cui ci parla è una terra reale, toccata, sentita, odorata, vista, amata. E, poi, concluda la lettura in qualche periferia reale, in mezzo ai poveri, e guardi il mondo dei ricchi epuloni accanto ai nostri lazzari, e ne abbracci almeno uno, come Francesco. Da questi luoghi potremmo reimparare a «stupirci» (11) delle meraviglie della terra e degli uomini, e così forse potremo capire e pregare Laudato si’». di Luigino Bruni pubblicato su Avvenire il 24/06/2015 www.edc-online.org (altro…)

3 Giu 2015 | Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Sociale, Spiritualità
 «L’Economia di Comunione è tornata in Africa. Siamo venuti qui da tutto il mondo attratti dalle benedizioni e dalle ferite di questo grande continente, per guardare l’economia mondiale dalla prospettiva africana. Anche per lasciarci istruire da questi popoli, dalla loro grande vocazione alla vita, alle relazioni sociali, all’incontro. Dell’Africa mi ha sempre colpito la sua capacità generativa, la sua vita. C’è molta danza in Africa, molta festa, soprattutto danza di donne. Come nella Bibbia, dove molte volte le donne danzano. E, ciò che è stupendo, in Africa si vedono molti anziani, molte donne anziane danzare. Oggi in Europa e nei paesi del Nord del mondo è molto raro vedere donne e uomini anziani far festa per gratuità e per la gioia della vita in comunione. E questo perché la nostra cultura del consumismo e della finanza non li fa danzare. Siamo venuti in Africa anche per imparare a danzare, giovani, bambini, adulti e anziani. L’Africa ha certamente una vocazione a generare vita, in tutte le sue dimensioni. La fraternità con la terra e con la natura è un grande valore delle culture africane. Questo è uno dei doni che l’Africa fa a tutta l’Economia di Comunione nel mondo, e molti altri li dovremo scoprire insieme nei prossimi anni e nelle prossime generazioni. Quali sono i messaggi che dall’EdC possono arrivare all’Africa di oggi? Le vie africane alla proposta di Chiara Lubich, nascerà dall’Africa in comunione con tutto il mondo. Il primo contributo che l’EdC vuole portare all’Africa è uno sguardo di stima per quello che l’Africa è già e non solo per quello che dovrà diventare. La prima forza dei popoli sono i loro sogni, soprattutto quelli collettivi e quelli dei poveri. Ridiamo tempo alle nostre storie, grandi e piccole, e da lì ripartiamo verso una nuova terra. “Generare” è molto legato ad una parola economica importante, per l’Africa e per tutti: innovazione Un primo messaggio che ci arriva dalla logica dell’innovazione-germoglio si chiama sussidiarietà: le nostre mani e la tecnologia possono solo sussidiarla, cioè aiutare il germoglio a fiorire; non possono inventarlo. Le innovazioni economiche e sociali dell’Africa, nasceranno prima di tutto dal suo humus, dalla sua terra e non da mani esterne. L’EdC è dono di occhi capaci di vedere germogli dove gli altri vedono solo deserti. Qui nelle terre africane, ci sono molti giovani che si sono messi in cammino, spesso insieme: è da questi germogli che dobbiamo imparare a vedere la foresta. L’energia essenziale in tutte le riprese è la fame di vita e di futuro dei giovani e dei poveri, che qui in Africa è abbondante. Perché i poveri e gli esclusi possano diventare motore di cambiamento di un paese essenziale è il ruolo delle istituzioni, istituzioni politiche, istituzioni economiche. Dall’EdC stanno nascendo nuove istituzioni finanziarie. Ma le banche e tutte le istituzioni possono solo aiutare le innovazioni economiche, non crearle né inventarle. Senza persone con creatività, talento, competenze e passioni, non si dà vita a nessuna esperienza di nuova economia. È necessario che ciascuno attivi la propria capacità innovativa e, se può, si metta assieme ad altri che hanno la sua stessa voglia di fare e di creare. Il nostro sogno è di creare anche qui alla cittadella “Mariapoli Piero” una di queste istituzioni. Un centro che possa essere un ‘luogo della fiducia’ per accompagnare e servire le nuove idee EdC che nasceranno, soprattutto da parte dei giovani». Leggi l’intervento integrale di Luigino Bruni (altro…)
«L’Economia di Comunione è tornata in Africa. Siamo venuti qui da tutto il mondo attratti dalle benedizioni e dalle ferite di questo grande continente, per guardare l’economia mondiale dalla prospettiva africana. Anche per lasciarci istruire da questi popoli, dalla loro grande vocazione alla vita, alle relazioni sociali, all’incontro. Dell’Africa mi ha sempre colpito la sua capacità generativa, la sua vita. C’è molta danza in Africa, molta festa, soprattutto danza di donne. Come nella Bibbia, dove molte volte le donne danzano. E, ciò che è stupendo, in Africa si vedono molti anziani, molte donne anziane danzare. Oggi in Europa e nei paesi del Nord del mondo è molto raro vedere donne e uomini anziani far festa per gratuità e per la gioia della vita in comunione. E questo perché la nostra cultura del consumismo e della finanza non li fa danzare. Siamo venuti in Africa anche per imparare a danzare, giovani, bambini, adulti e anziani. L’Africa ha certamente una vocazione a generare vita, in tutte le sue dimensioni. La fraternità con la terra e con la natura è un grande valore delle culture africane. Questo è uno dei doni che l’Africa fa a tutta l’Economia di Comunione nel mondo, e molti altri li dovremo scoprire insieme nei prossimi anni e nelle prossime generazioni. Quali sono i messaggi che dall’EdC possono arrivare all’Africa di oggi? Le vie africane alla proposta di Chiara Lubich, nascerà dall’Africa in comunione con tutto il mondo. Il primo contributo che l’EdC vuole portare all’Africa è uno sguardo di stima per quello che l’Africa è già e non solo per quello che dovrà diventare. La prima forza dei popoli sono i loro sogni, soprattutto quelli collettivi e quelli dei poveri. Ridiamo tempo alle nostre storie, grandi e piccole, e da lì ripartiamo verso una nuova terra. “Generare” è molto legato ad una parola economica importante, per l’Africa e per tutti: innovazione Un primo messaggio che ci arriva dalla logica dell’innovazione-germoglio si chiama sussidiarietà: le nostre mani e la tecnologia possono solo sussidiarla, cioè aiutare il germoglio a fiorire; non possono inventarlo. Le innovazioni economiche e sociali dell’Africa, nasceranno prima di tutto dal suo humus, dalla sua terra e non da mani esterne. L’EdC è dono di occhi capaci di vedere germogli dove gli altri vedono solo deserti. Qui nelle terre africane, ci sono molti giovani che si sono messi in cammino, spesso insieme: è da questi germogli che dobbiamo imparare a vedere la foresta. L’energia essenziale in tutte le riprese è la fame di vita e di futuro dei giovani e dei poveri, che qui in Africa è abbondante. Perché i poveri e gli esclusi possano diventare motore di cambiamento di un paese essenziale è il ruolo delle istituzioni, istituzioni politiche, istituzioni economiche. Dall’EdC stanno nascendo nuove istituzioni finanziarie. Ma le banche e tutte le istituzioni possono solo aiutare le innovazioni economiche, non crearle né inventarle. Senza persone con creatività, talento, competenze e passioni, non si dà vita a nessuna esperienza di nuova economia. È necessario che ciascuno attivi la propria capacità innovativa e, se può, si metta assieme ad altri che hanno la sua stessa voglia di fare e di creare. Il nostro sogno è di creare anche qui alla cittadella “Mariapoli Piero” una di queste istituzioni. Un centro che possa essere un ‘luogo della fiducia’ per accompagnare e servire le nuove idee EdC che nasceranno, soprattutto da parte dei giovani». Leggi l’intervento integrale di Luigino Bruni (altro…)
![L’altra metà dell’ economia. Gratuità e mercati]()
12 Mag 2014 | Cultura

L’altra metà dell’economia, Bruni-Smerilli, Città Nuova editrice 2014

 «Il Nobel 2015 assegnato ad Angus Deaton per i suoi studi sullo sviluppo economico, sul benessere, sulla diseguaglianza, sui consumi e sulle determinanti della povertà è un segnale molto importante: dopo alcuni anni in cui, in piena crisi finanziaria, Stoccolma ed i suoi consulenti continuavano a premiare gli economisti che avevano studiato e promosso l’economia e la finanza e avevano contribuito a generare la crisi, col Nobel a Deaton si torna a premiare, nel luogo più importante per la scienza contemporanea, scienziati sociali a tutto tondo, continuatori della scienza politica o civile che è all’origine dell’economia moderna. La politica di Stoccolma è stata alquanto bizzarra negli ultimi anni: dal 2010 al 2013, mentre il capitalismo stava rischiando di implodere sotto una crisi finanziaria mai conosciuta prima di allora, i Nobel per l’Economia sono stati assegnati ad alcuni economisti tra i maggiori teorici di quel paradigma economico e finanziario che stava mostrando tutti i suoi drammatici limiti. Come se, durante un’estate con il più alto numero di incendi dolosi mai registrati, venissero assegnati premi a coloro che studiano tecniche sofisticate di accensione avanzata di incendi. Ecco perché questo Nobel e anche, in misura diversa, quello dello scorso anno assegnato al francese Jean Tirole potrebbero indicare una prima inversione di tendenza essendo Deaton molto più simile a premi Nobel come Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, Elinor Ostrom che ai più recenti Eugene Fama e Lloyd Stowell Shapley. Non dobbiamo dimenticare che la crisi finanziaria ed economica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non è indipendente dalle teorie economiche degli ultimi decenni, perché a differenza degli astrofisici le cui teorie non modificano le orbite dei pianeti, gli economisti e le loro le teorie condizionano fortemente le scelte economiche. Negli ultimi anni i migliori dipartimenti di economia del mondo si sono riempiti di economisti sempre più matematici, con una formazione umanistica sempre più scarsa, espertissimi di modelli iper-specializzati e non più capaci in massima parte di avere una visione di insieme del sistema economico, e quindi di associare i loro modelli con la realtà economica e sociale. Inoltre il premio a Deaton che fa seguito a quello dato a Tirole, potrebbe indicare un ritorno di una teoria economica più europea, più attenta alla dimensione sociale della professione, una maggiore sensibilità per i temi del benessere collettivo e non solo dei profitti e delle rendite individuali. Questa possibile alba troverà però il suo mezzodì se i prossimi Nobel vedranno più economisti filosofi e meno economisti matematici, come scriveva già nel 1991 l’economista inglese Robert Sugden: “L’economista oggi deve tornare a essere più filosofo e meno matematico”. Un invito che allora non fu raccolto dalla professione, ma forse siamo ancora in tempo. Angus Deaton poi è ancora un economista che sa scrivere libri, non solo articoli matematici. Consiglio a tutti il suo ultimo libro “La grande fuga”, nel quale il neo laureato Nobel si domanda, da autentico scienziato sociale e legittimo erede del suo compatriota Adam Smith (filosofo ed economista) se l’umanità potrà conoscere in futuro una stagione di progresso senza disuguaglianza, una domanda fondamentale quando oggi il prezzo del progresso lo stiamo pagando con una crescente disuguaglianza nel mondo e una diminuzione di felicità. L’economia potrà tornare ad essere una scienza morale amica della società se tornerà a porsi questa e simili domande, abbandonate troppo velocemente per rispondere ad altre domande molto più facili e molto meno utili al progresso umano». Luigino Bruni www.edc-online.org (altro…)
«Il Nobel 2015 assegnato ad Angus Deaton per i suoi studi sullo sviluppo economico, sul benessere, sulla diseguaglianza, sui consumi e sulle determinanti della povertà è un segnale molto importante: dopo alcuni anni in cui, in piena crisi finanziaria, Stoccolma ed i suoi consulenti continuavano a premiare gli economisti che avevano studiato e promosso l’economia e la finanza e avevano contribuito a generare la crisi, col Nobel a Deaton si torna a premiare, nel luogo più importante per la scienza contemporanea, scienziati sociali a tutto tondo, continuatori della scienza politica o civile che è all’origine dell’economia moderna. La politica di Stoccolma è stata alquanto bizzarra negli ultimi anni: dal 2010 al 2013, mentre il capitalismo stava rischiando di implodere sotto una crisi finanziaria mai conosciuta prima di allora, i Nobel per l’Economia sono stati assegnati ad alcuni economisti tra i maggiori teorici di quel paradigma economico e finanziario che stava mostrando tutti i suoi drammatici limiti. Come se, durante un’estate con il più alto numero di incendi dolosi mai registrati, venissero assegnati premi a coloro che studiano tecniche sofisticate di accensione avanzata di incendi. Ecco perché questo Nobel e anche, in misura diversa, quello dello scorso anno assegnato al francese Jean Tirole potrebbero indicare una prima inversione di tendenza essendo Deaton molto più simile a premi Nobel come Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, Elinor Ostrom che ai più recenti Eugene Fama e Lloyd Stowell Shapley. Non dobbiamo dimenticare che la crisi finanziaria ed economica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non è indipendente dalle teorie economiche degli ultimi decenni, perché a differenza degli astrofisici le cui teorie non modificano le orbite dei pianeti, gli economisti e le loro le teorie condizionano fortemente le scelte economiche. Negli ultimi anni i migliori dipartimenti di economia del mondo si sono riempiti di economisti sempre più matematici, con una formazione umanistica sempre più scarsa, espertissimi di modelli iper-specializzati e non più capaci in massima parte di avere una visione di insieme del sistema economico, e quindi di associare i loro modelli con la realtà economica e sociale. Inoltre il premio a Deaton che fa seguito a quello dato a Tirole, potrebbe indicare un ritorno di una teoria economica più europea, più attenta alla dimensione sociale della professione, una maggiore sensibilità per i temi del benessere collettivo e non solo dei profitti e delle rendite individuali. Questa possibile alba troverà però il suo mezzodì se i prossimi Nobel vedranno più economisti filosofi e meno economisti matematici, come scriveva già nel 1991 l’economista inglese Robert Sugden: “L’economista oggi deve tornare a essere più filosofo e meno matematico”. Un invito che allora non fu raccolto dalla professione, ma forse siamo ancora in tempo. Angus Deaton poi è ancora un economista che sa scrivere libri, non solo articoli matematici. Consiglio a tutti il suo ultimo libro “La grande fuga”, nel quale il neo laureato Nobel si domanda, da autentico scienziato sociale e legittimo erede del suo compatriota Adam Smith (filosofo ed economista) se l’umanità potrà conoscere in futuro una stagione di progresso senza disuguaglianza, una domanda fondamentale quando oggi il prezzo del progresso lo stiamo pagando con una crescente disuguaglianza nel mondo e una diminuzione di felicità. L’economia potrà tornare ad essere una scienza morale amica della società se tornerà a porsi questa e simili domande, abbandonate troppo velocemente per rispondere ad altre domande molto più facili e molto meno utili al progresso umano». Luigino Bruni www.edc-online.org (altro…)


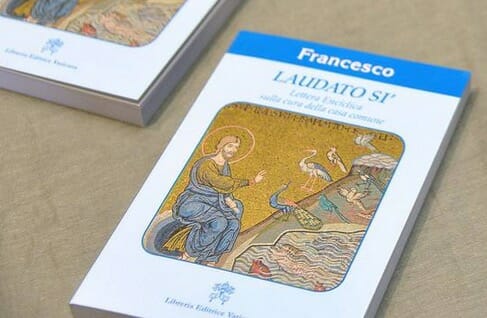 Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.
Il Papa, innanzitutto, richiama il mercato alla sua vocazione di reciprocità e di «mutuo vantaggio». E su questa base critica le imprese che depredano persone e terra (e lo fanno spesso), perché stanno negando la natura stessa del mercato, arricchendosi grazie all’impoverimento della parte più debole.
