
Da 50 anni testimoni e costruttori di pace
In occasione dei 50 anni di Religions for Peace, facciamo il punto sul cammino fatto e le prospettive future con Azza Karram, eletta segretario generale.

Azza Karram
A cura di Maddalena Maltese

In occasione dei 50 anni di Religions for Peace, facciamo il punto sul cammino fatto e le prospettive future con Azza Karram, eletta segretario generale.

Azza Karram
A cura di Maddalena Maltese
La sofferenza è maestra di sapienza. È questa la convinzione che esprime Chiara Lubich nella riflessione seguente. Dobbiamo avvicinarsi a chi soffre non solo con compassione, ma con un atteggiamento di riverenza e di ascolto. Perché qualche uomo all’oscuro delle scienze, anche religiose, s’è fatto santo con il solo libro del Crocifisso? Perché non s’è fermato a contemplarlo, o a venerarlo e a baciarne le piaghe, ma ha voluto riviverlo in sé. E chi soffre ed è nell’oscurità, vede più lontano di chi non soffre, precisamente come occorre che tramonti il sole per vedere le stelle. La sofferenza insegna ciò che in nessun’altra maniera si può apprendere. Essa siede sulla più alta cattedra. È maestra di sapienza, e chi ha la sapienza è beato (cfr. Pr 3,13) «Beati gli afflitti, perché saranno consolati» (Mt 5,4) non solo col premio di là, ma anche con la contemplazione di cose celesti di qua. Occorre appressarsi a chi soffre con la riverenza, ed ancor più, con cui si avvicinavano un tempo gli anziani, quando da essi ci si attendeva la saggezza.
Chiara Lubich
Chiara Lubich, Vede più lontano. Scritti Spirituali /2, Città Nuova Editrice – Roma, 1997, pag. 78. (altro…)
Gesù non è indifferente alle nostre tribolazioni e impegna se stesso nel guarire il nostro cuore dalla durezza dell’egoismo, nel riempire la nostra solitudine, nel dare forza alla nostra azione. Un matrimonio salvato Una nostra figlia stava attraversando un momento estremamente delicato della sua vita di coppia. L’ultima volta in cui ho parlato con lei per telefono, mi confidava che ormai aveva perso ogni speranza di salvare il matrimonio; come unica cosa da fare, diceva piangendo, rimaneva il divorzio. Sempre aveva colpito me e mio marito la promessa fatta ai discepoli da Gesù: “Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà”. Con questa fiducia, promisi a nostra figlia che insieme agli altri suoi cinque fratelli avremmo pregato per ottenere la riconciliazione. Non molto tempo dopo lei mi telefonò risollevata e quasi incredula: dopo lunga riflessione, suo marito aveva accettato di fare un colloquio con chi avrebbe potuto aiutarli a risolvere i loro problemi. Difatti si riappacificarono. Non solo: passato qualche anno, nostro genero le manifestò il desiderio di entrare a far parte della Chiesa cattolica. Per questo le chiedeva di accompagnarlo da un sacerdote per iniziare la preparazione necessaria. (G. B. – Usa) Un nuovo inizio Non vedevo l’ora di cominciare a insegnare in un liceo della Chiesa d’Inghilterra a West London. Ma il mio entusiasmo è svanito presto: non accolto dagli studenti come avrei desiderato e in costante conflitto con loro, ho cominciato a usare i miei poteri. Ma confidandomi con amici, ho capito che un’altra era la tattica da seguire, anche se mi sentivo dalla parte giusta. Gesù non avrebbe fatto così. Il giorno dopo, in classe, mi sono scusato dicendo che avevo probabilmente fatto un sacco di errori che un insegnante più esperto avrebbe evitato. In un grande silenzio e ascolto da parte degli alunni, ho detto che avrei provato a vederli tutti con occhi nuovi e speravo che facessero altrettanto con me. Uno dei principali piantagrane ha pubblicamente accettato le mie scuse, scusandomi a sua volta per il comportamento proprio e del resto della classe. Vari studenti annuivano a queste parole. Ho visto alcuni di loro sorridere. Era accaduto qualcosa di imprevedibile: un insegnante si era scusato di fronte a tutta la classe. È stato un nuovo inizio per tutti. (G.P. – Inghilterra) Il ragazzo dell’incrocio Ogni mattina, prima di recarmi al mio posto di lavoro come vigile urbano, sono solito andare a Messa e chiedere a Gesù l’aiuto per amare chiunque incontrerò durante la giornata. Un giorno, ad un incrocio con molto traffico, vedo sfrecciare un ragazzo in moto. Dopo poco lui torna, sempre ad altissima velocità, e questo si ripete numerose volte. Gli intima inutilmente di fermarsi, sperando in cuor mio che non provochi guai. Finalmente si ferma, solo per dirmi: “Ho molte difficoltà, voglio farla finita con la vita”. Lo ascolto a lungo, pur continuando il mio lavoro. Gli offro la mia disponibilità ad aiutarlo e non gli faccio la multa. Lo vedo andar via più sereno. Passano alcuni anni. Mentre sono di servizio in un altro posto, mi si avvicina un giovanottone sorridente che mi abbraccia commosso. Io gli dico: “Guarda, devi aver sbagliato vigile”. E lui: “No, sono il ragazzo dell’incrocio; ora sono felicemente sposato e contento della vita. Sono venuto fin qui dalla città dove abito ora, perché la volevo ringraziare”. In cuor mio posso solo ringraziare Dio. (S.A. – Italia)
a cura di Stefania Tanesini
(tratto da Il Vangelo del Giorno, Città Nuova, anno VI, n.6, novembre-dicembre 2020) (altro…)

Ideata come uno degli eventi per il Centenario di Chiara Lubich, era stata sospesa a causa della pandemia ed i fondi raccolti donati in beneficienza. Adesso arriva sui social dei Focolari in Brasile con gli stessi contenuti e nuovi linguaggi. Una mostra prevista per agosto 2020 poi rimandata a novembre e infine approdata sul web. Un itinerario faticoso per questo evento dedicato a Chiara Lubich in occasione del Centenario della sua nascita ed oggi fruibile attraverso i profili social di @focolaresbrasil (Facebook, Instagram e Youtube): foto, video e contenuti testuali saranno pubblicati quotidianamente per tutto il mese di novembre 2020. Una mostra diversa da quella prevista, con un pubblico ampliato grazie al web, arricchita del contributo di un’équipe intergenerazionale. Ne parliamo con Josè Portella, uno dei curatori della mostra.  Come è nata l’idea di sostituire la mostra in presenza con una virtuale? Chi ha fatto parte dell’équipe di realizzazione e come avete lavorato? Siamo un team di sedici persone del Movimento dei Focolari, di diverse età e vocazioni: giovani e adulti, volontari e focolarini. Dall’inizio del 2019 lavoravamo insieme per presentare in Brasile una versione ridotta della mostra allestita alle Gallerie di Trento in Italia. Poi è arrivata la pandemia. A maggio 2020, rendendoci conto della gravità della situazione, abbiamo capito che potevamo “celebrare” il Centenario aiutando i bisognosi colpiti dalla pandemia. In accordo con le persone che avevano già fatto donazioni per la mostra, abbiamo donato quanto ricevuto a chi era più in difficoltà. È stato allora che abbiamo saputo che per la mostra di Trento si stava preparando un percorso online. Ma la semplice traduzione non bastava per raggiungere la realtà brasiliana. Perché non fare qualcosa di virtuale specifico per il nostro Paese? Con alcuni esperti delle nuove generazioni, che si sono uniti all’équipe, ci siamo divisi in tre gruppi per adattare il materiale espositivo di Trento, preparare video, valutare le esigenze finanziarie. Un’esperienza di unità tra generazioni. La difficoltà principale è stata mantenere la narrativa della mostra di Trento, ma con un approccio brasiliano e un linguaggio adatto ai social media. Quali sono le caratteristiche del percorso che avete riservato ai visitatori virtuali? Ci sono quattro video promozionali e un video per il lancio della Mostra. Poi si presenta Chiara Lubich e il suo carisma secondo tre tematiche: essere con la storia della Lubich; influire con la testimonianza delle persone che hanno conosciuto e che vivono la spiritualità dell’unità; agire con tutte le realtà che sono nate attraverso il suo carisma. Che cosa secondo voi Chiara Lubich ha da dire al Brasile di oggi, anche nel particolare momento di pandemia che stiamo vivendo a livello planetario? Chiara Lubich durante un viaggio in Brasile nel 1991, di fronte alla disuguaglianza che osservava, ha intuito l’Economia di Comunione e affermato che il Movimento in Brasile è chiamato ad agire sulla comunione dei beni a livello globale. Oggi, nel contesto della pandemia, incarnare questo carisma significa prendersi cura dell’altro, condividere non solo beni materiali, ma dedicare la propria vita al servizio degli altri, non chiedersi chi è il mio prossimo, ma di chi sono io il prossimo. In sintonia con l’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” siamo chiamati come popolo ad agire in fraternità, sull’esempio del buon samaritano. Solo allora emergeranno uomini nuovi per costruire una società più inclusiva e fraterna.
Come è nata l’idea di sostituire la mostra in presenza con una virtuale? Chi ha fatto parte dell’équipe di realizzazione e come avete lavorato? Siamo un team di sedici persone del Movimento dei Focolari, di diverse età e vocazioni: giovani e adulti, volontari e focolarini. Dall’inizio del 2019 lavoravamo insieme per presentare in Brasile una versione ridotta della mostra allestita alle Gallerie di Trento in Italia. Poi è arrivata la pandemia. A maggio 2020, rendendoci conto della gravità della situazione, abbiamo capito che potevamo “celebrare” il Centenario aiutando i bisognosi colpiti dalla pandemia. In accordo con le persone che avevano già fatto donazioni per la mostra, abbiamo donato quanto ricevuto a chi era più in difficoltà. È stato allora che abbiamo saputo che per la mostra di Trento si stava preparando un percorso online. Ma la semplice traduzione non bastava per raggiungere la realtà brasiliana. Perché non fare qualcosa di virtuale specifico per il nostro Paese? Con alcuni esperti delle nuove generazioni, che si sono uniti all’équipe, ci siamo divisi in tre gruppi per adattare il materiale espositivo di Trento, preparare video, valutare le esigenze finanziarie. Un’esperienza di unità tra generazioni. La difficoltà principale è stata mantenere la narrativa della mostra di Trento, ma con un approccio brasiliano e un linguaggio adatto ai social media. Quali sono le caratteristiche del percorso che avete riservato ai visitatori virtuali? Ci sono quattro video promozionali e un video per il lancio della Mostra. Poi si presenta Chiara Lubich e il suo carisma secondo tre tematiche: essere con la storia della Lubich; influire con la testimonianza delle persone che hanno conosciuto e che vivono la spiritualità dell’unità; agire con tutte le realtà che sono nate attraverso il suo carisma. Che cosa secondo voi Chiara Lubich ha da dire al Brasile di oggi, anche nel particolare momento di pandemia che stiamo vivendo a livello planetario? Chiara Lubich durante un viaggio in Brasile nel 1991, di fronte alla disuguaglianza che osservava, ha intuito l’Economia di Comunione e affermato che il Movimento in Brasile è chiamato ad agire sulla comunione dei beni a livello globale. Oggi, nel contesto della pandemia, incarnare questo carisma significa prendersi cura dell’altro, condividere non solo beni materiali, ma dedicare la propria vita al servizio degli altri, non chiedersi chi è il mio prossimo, ma di chi sono io il prossimo. In sintonia con l’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” siamo chiamati come popolo ad agire in fraternità, sull’esempio del buon samaritano. Solo allora emergeranno uomini nuovi per costruire una società più inclusiva e fraterna.
a cura di Anna Lisa Innocenti
Nella spiritualità dell’unità la persona non cerca soltanto Dio in fondo alla propria anima, ma scopre la sua presenza nello spazio che apre quando due o più persone si amano nello spirito del Vangelo. L’immagine che usa Chiara Lubich per descrivere questa realtà è quello di un castello: non interiore, ma esteriore. Per chi percorre la via dell’unità, la presenza di Gesù in mezzo ai fratelli è essenziale. Pena il fallimento personale, occorre che essa sia sempre viva. Ed è proprio questa presenza che caratterizza il carisma dell’unità. Come due poli della luce elettrica, pur essendoci la corrente, non fanno luce finché non si uniscono, ma la producono appena uniti, così due persone non possono sperimentare la luce tipica di questo carisma finché non si uniscono in Cristo mediante la carità. In questa via dell’unità tutto ha significato e valore nel lavoro, nello studio, anche nella preghiera e nella tensione alla santità, come nell’irradiazione della vita cristiana, se vi è con i fratelli la presenza di Gesù in mezzo, che è la norma delle norme di questa vita. In questa spiritualità si raggiunge la santità se si fa verso Dio una marcia in unità. […] Santa Teresa d’Avila, dottore della Chiesa, parla di un “castello interiore”: la realtà dell’anima abitata al centro da Sua Maestà, da scoprire e illuminare tutto durante la vita superando le varie prove. E questo è un culmine di santità in una via prevalentemente personale, anche se poi lei trascinava in quest’esperienza tutte le sue figliole. Ma è venuto il momento, almeno ci sembra, di scoprire, illuminare, edificare, oltre il “castello interiore”, anche il “castello esteriore”. […] Ma se noi pensiamo che questa nuova spiritualità che Dio dona oggi alla Chiesa arriva anche a responsabili della società e della Chiesa, comprendiamo subito che questo carisma […] tende a farlo (un castello esteriore anche) del corpo sociale ed ecclesiale. Il Santo Padre, parlando recentemente ad una settantina di Vescovi, amici del Movimento, ha detto: “Il Signore Gesù … non ha chiamato i discepoli ad una sequela individuale, ma inscindibilmente personale e comunitaria. E se ciò è vero per tutti i battezzati – continua il Papa – vale in modo particolare (…) per gli Apostoli e per i loro successori, i Vescovi”1. Così questa spiritualità, come tutti i carismi, è fatta per tutto il popolo di Dio la cui vocazione è di essere sempre più uno e più santo.
Chiara Lubich
Da: Una spiritualità di comunione. In: Chiara Lubich, La dottrina spirituale, Milano 2001, pag. 69. 1) Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII (1995) 1, Città del Vaticano 1997, p.382. (altro…)
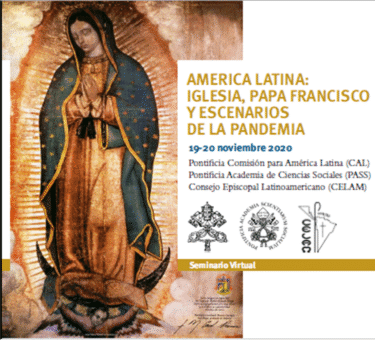
Un Webinar promosso dalla pontificia commissione per l’America Latina aperto a tutti per riflettere e analizzare l’impatto e le conseguenze del COVID-19. I risvolti sociali, economici, politici e il pensiero di papa Francesco. 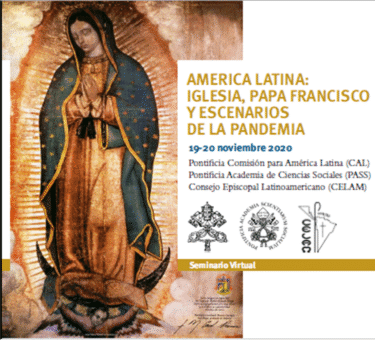 Si svolgerà il 19 e 20 novembre prossimi il seminario virtuale dal titolo America Latina: Chiesa, Papa Francesco e lo scenario della pandemia e sarà aperto a tutti quanti sono interessati a questo pezzo di mondo, anch’esso pesantemente colpito dal virus; uno scenario già complicato in molte aree da povertà ed emarginazione. Organizzato dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Conferenza Episcopale Latino Americana (CELAM), l’appuntamento punta a riflettere e analizzare la situazione della pandemia nel continente latino americano, le sue conseguenze e, soprattutto, le linee d’azione e gli aiuti dei governi e della Chiesa. Il Papa si farà presente con un video-messaggio ed interverranno, tra gli altri, anche il Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, Carlos Afonso Nobre, Premio Nobel per la Pace nel 2007, l’economista Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile alla Columbia University e Gustavo Beliz, Segretario agli Affari strategici della Presidenza argentina. La nota introduttiva al seminario spiega che ad oggi nel continente latino-americano, come nel resto del mondo, è impossibile calcolare i danni della pandemia: “In molti casi, gli effetti negativi della chiusura delle frontiere e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sono stati solo l’inizio di una spirale di danni non ancora quantificati, tanto meno una ricetta per una soluzione a medio termine”. Per questo il seminario sarà l’occasione di un incontro e di un dialogo a tutto campo tra l’azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica e il contributo di vari specialisti del mondo dell’economia e della politica, per poter potenziare una rete culturale e operativa e garantire così un futuro migliore al continente. Papa Francesco si farà presente anche con la presentazione della Task Force contro il Covid-19, da lui istituita e rappresentata al seminario dal suo capo che ne esporrà il lavoro. In tempi di incertezza e di mancanza di futuro la Chiesa guarda al “continente della speranza” e cerca strumenti condivisi che possano trasformare la crisi in opportunità o almeno trovare le vie per uscirne. Il programma dell’evento Iscriviti qui
Si svolgerà il 19 e 20 novembre prossimi il seminario virtuale dal titolo America Latina: Chiesa, Papa Francesco e lo scenario della pandemia e sarà aperto a tutti quanti sono interessati a questo pezzo di mondo, anch’esso pesantemente colpito dal virus; uno scenario già complicato in molte aree da povertà ed emarginazione. Organizzato dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dalla Conferenza Episcopale Latino Americana (CELAM), l’appuntamento punta a riflettere e analizzare la situazione della pandemia nel continente latino americano, le sue conseguenze e, soprattutto, le linee d’azione e gli aiuti dei governi e della Chiesa. Il Papa si farà presente con un video-messaggio ed interverranno, tra gli altri, anche il Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente del CELAM, Carlos Afonso Nobre, Premio Nobel per la Pace nel 2007, l’economista Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile alla Columbia University e Gustavo Beliz, Segretario agli Affari strategici della Presidenza argentina. La nota introduttiva al seminario spiega che ad oggi nel continente latino-americano, come nel resto del mondo, è impossibile calcolare i danni della pandemia: “In molti casi, gli effetti negativi della chiusura delle frontiere e le conseguenti ripercussioni sociali ed economiche sono stati solo l’inizio di una spirale di danni non ancora quantificati, tanto meno una ricetta per una soluzione a medio termine”. Per questo il seminario sarà l’occasione di un incontro e di un dialogo a tutto campo tra l’azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica e il contributo di vari specialisti del mondo dell’economia e della politica, per poter potenziare una rete culturale e operativa e garantire così un futuro migliore al continente. Papa Francesco si farà presente anche con la presentazione della Task Force contro il Covid-19, da lui istituita e rappresentata al seminario dal suo capo che ne esporrà il lavoro. In tempi di incertezza e di mancanza di futuro la Chiesa guarda al “continente della speranza” e cerca strumenti condivisi che possano trasformare la crisi in opportunità o almeno trovare le vie per uscirne. Il programma dell’evento Iscriviti qui
Stefania Tanesini

Il Global Compact on Education, voluto da Papa Francesco, invita tutte le persone di aderire ad un Patto. Ne parliamo con Silvia Cataldi, sociologa, docente all’Università La Sapienza di Roma  I protagonisti sono loro, depositari della speranza per un mondo più giusto, solidale, in pace. Il Global Compact on Education, voluto da Papa Francesco, guarda ai giovani come destinatari dei percorsi educativi e insieme agenti degli stessi. Coinvolti insieme alle loro “famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti” in una “alleanza educativa” per un’umanità più fraterna e in pace. Se n’è parlato durante l’incontro “Insieme per guardare oltre” che si è tenuto alla Pontificia Università Lateranense (Roma, Italia) il 15 ottobre, durante il quale il Santo Padre, in un videomessaggio, ha esortato tutte le persone di buona volontà ad aderire al Patto. A commentare le parole del Papa era presente Silvia Cataldi, sociologa, docente all’Università La Sapienza di Roma. Negli ultimi anni registriamo un forte protagonismo dei giovani sui grandi temi dell’attualità. Sembra obsoleto il modello educativo che li vede soggetti passivi… “Spesso il limite dei modelli educativi è quello di fraintendere la cultura come nozionismo. Il pedagogista Paulo Freire parla di “educazione depositaria”, in cui il sapere può essere versato o depositato come in un contenitore. Questo sapere ha però due rischi: quello di rimanere astratto e sganciato dalla vita, e quello di presupporre una visione gerarchica del sapere. Rispetto a questo, il Patto mi colpisce come educatore, perché ci invita ad ascoltare il grido delle giovani generazioni, a lasciarci interpellare dalle loro questioni. Dobbiamo renderci conto che l’educazione è un percorso partecipato, non unidirezionale”. Dunque, cosa significa educare? “Il termine cultura viene da colere e significa coltivare. È quindi un verbo stanziale, bisogna starci, dedicare tempo e spazio, partire dalle domande e non dal fornire risposte. Ma ha anche il significato di prendersi cura, amare. Per questo mi colpisce molto il Patto, in quanto dice con forza che “l’educazione è soprattutto una questione di amore”. Quando si parla di amore si pensa al cuore, al sentimento. Ma l’amore ha una dimensione eminentemente pratica, richiede le mani. Allora noi educatori facciamo il nostro lavoro solo se sappiamo riconoscere che l’educazione è cura. La cura quotidiana è un gesto rivoluzionario perché è un elemento di critica e di trasformazione del mondo. Lo spiega bene Hannah Arendt quando dice che “L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo perché porta a trasformarlo”. Come far sì che il Patto non rimanga un semplice appello? L’invito alla fratellanza universale – il cuore del Patto – ha implicazioni importanti, ma perché abbia davvero un potere trasformante deve promuovere un cambio di prospettiva che porti ad accogliere le diversità e guarire le disuguaglianze. Dice il sociologo francese Alain Caillé che la “fraternità è plurale”, e ciò significa che se in passato la fratellanza era solo tra simili, consanguinei, in una classe o in un gruppo, oggi richiede di riconoscere “la specificità, la bellezza, e l’unicità” di ciascuno. Inoltre, se siamo tutti fratelli allora cambia il nostro modo di concepire la realtà perché la guardiamo da una prospettiva specifica, che è quella degli ultimi, e siamo spinti ad agire, ad esempio per tutelare i diritti fondamentali dei bambini, delle donne, degli anziani, i disabili e gli oppressi”.
I protagonisti sono loro, depositari della speranza per un mondo più giusto, solidale, in pace. Il Global Compact on Education, voluto da Papa Francesco, guarda ai giovani come destinatari dei percorsi educativi e insieme agenti degli stessi. Coinvolti insieme alle loro “famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti” in una “alleanza educativa” per un’umanità più fraterna e in pace. Se n’è parlato durante l’incontro “Insieme per guardare oltre” che si è tenuto alla Pontificia Università Lateranense (Roma, Italia) il 15 ottobre, durante il quale il Santo Padre, in un videomessaggio, ha esortato tutte le persone di buona volontà ad aderire al Patto. A commentare le parole del Papa era presente Silvia Cataldi, sociologa, docente all’Università La Sapienza di Roma. Negli ultimi anni registriamo un forte protagonismo dei giovani sui grandi temi dell’attualità. Sembra obsoleto il modello educativo che li vede soggetti passivi… “Spesso il limite dei modelli educativi è quello di fraintendere la cultura come nozionismo. Il pedagogista Paulo Freire parla di “educazione depositaria”, in cui il sapere può essere versato o depositato come in un contenitore. Questo sapere ha però due rischi: quello di rimanere astratto e sganciato dalla vita, e quello di presupporre una visione gerarchica del sapere. Rispetto a questo, il Patto mi colpisce come educatore, perché ci invita ad ascoltare il grido delle giovani generazioni, a lasciarci interpellare dalle loro questioni. Dobbiamo renderci conto che l’educazione è un percorso partecipato, non unidirezionale”. Dunque, cosa significa educare? “Il termine cultura viene da colere e significa coltivare. È quindi un verbo stanziale, bisogna starci, dedicare tempo e spazio, partire dalle domande e non dal fornire risposte. Ma ha anche il significato di prendersi cura, amare. Per questo mi colpisce molto il Patto, in quanto dice con forza che “l’educazione è soprattutto una questione di amore”. Quando si parla di amore si pensa al cuore, al sentimento. Ma l’amore ha una dimensione eminentemente pratica, richiede le mani. Allora noi educatori facciamo il nostro lavoro solo se sappiamo riconoscere che l’educazione è cura. La cura quotidiana è un gesto rivoluzionario perché è un elemento di critica e di trasformazione del mondo. Lo spiega bene Hannah Arendt quando dice che “L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo perché porta a trasformarlo”. Come far sì che il Patto non rimanga un semplice appello? L’invito alla fratellanza universale – il cuore del Patto – ha implicazioni importanti, ma perché abbia davvero un potere trasformante deve promuovere un cambio di prospettiva che porti ad accogliere le diversità e guarire le disuguaglianze. Dice il sociologo francese Alain Caillé che la “fraternità è plurale”, e ciò significa che se in passato la fratellanza era solo tra simili, consanguinei, in una classe o in un gruppo, oggi richiede di riconoscere “la specificità, la bellezza, e l’unicità” di ciascuno. Inoltre, se siamo tutti fratelli allora cambia il nostro modo di concepire la realtà perché la guardiamo da una prospettiva specifica, che è quella degli ultimi, e siamo spinti ad agire, ad esempio per tutelare i diritti fondamentali dei bambini, delle donne, degli anziani, i disabili e gli oppressi”.
Claudia Di Lorenzi

L’impegno dei giovani dei Focolari Ho Chi Minh City, in Vietnam per le persone in difficoltà: farsi carico dei loro bisogni attraverso la distribuzione di 300 pacchi di merci alle famiglie e 370 piccoli regali per i bambini.  Nel mese di luglio 2020, alcuni Gen2, giovani dei Focolari di Ho Chi Minh City, in Vietnam, hanno voluto fare qualcosa di concreto per l’operazione #daretocare – la campagna dei giovani dei Focolari per “farsi carico” delle nostre società e del pianeta -, per aiutare le persone della comunità in difficoltà. Hanno scelto di andare a condividere il loro amore nel distretto di Cu M’gar, nella provincia di Dak Lak. È un luogo con la più ampia area di caffè e la gente proviene da un’altra etnia. È a 8 ore di macchina dall’HCMC. “Abbiamo iniziato a confezionare e vendere frutta, yogurt e patate dolci online. Abbiamo raccolto vestiti usati per adulti e bambini, abbiamo ricevuto alcune donazioni e a un certo punto le restrizioni per COVID19 sono finite, così abbiamo potuto vendere merce come “raccolta fondi” alla parrocchia. Durante la preparazione è stata una grande sfida per noi vedere le cose insieme, non sono mancati malintesi e disaccordi. Ma sapendo che ci sono 300 famiglie che ci aspettano, continuiamo ad andare avanti con amore, pazienza e un po’ di sacrificio.
Nel mese di luglio 2020, alcuni Gen2, giovani dei Focolari di Ho Chi Minh City, in Vietnam, hanno voluto fare qualcosa di concreto per l’operazione #daretocare – la campagna dei giovani dei Focolari per “farsi carico” delle nostre società e del pianeta -, per aiutare le persone della comunità in difficoltà. Hanno scelto di andare a condividere il loro amore nel distretto di Cu M’gar, nella provincia di Dak Lak. È un luogo con la più ampia area di caffè e la gente proviene da un’altra etnia. È a 8 ore di macchina dall’HCMC. “Abbiamo iniziato a confezionare e vendere frutta, yogurt e patate dolci online. Abbiamo raccolto vestiti usati per adulti e bambini, abbiamo ricevuto alcune donazioni e a un certo punto le restrizioni per COVID19 sono finite, così abbiamo potuto vendere merce come “raccolta fondi” alla parrocchia. Durante la preparazione è stata una grande sfida per noi vedere le cose insieme, non sono mancati malintesi e disaccordi. Ma sapendo che ci sono 300 famiglie che ci aspettano, continuiamo ad andare avanti con amore, pazienza e un po’ di sacrificio.  Il 17-18 ottobre, con 30 giovani energici ed entusiasti, abbiamo fatto un viaggio significativo. Abbiamo potuto distribuire 300 pacchi di merci alle famiglie e 370 piccoli regali per i bambini. Durante il viaggio ci siamo resi conto di quanto siamo fortunati e felici rispetto alle situazioni di queste famiglie. Abbiamo condiviso ciò che abbiamo portato per dimostrare il nostro amore, ma alla fine abbiamo ricevuto più AMORE attraverso i loro sorrisi… Infatti, ogni volta che ci avviciniamo a loro sembra che ci conosciamo da molto tempo. Durante il viaggio alcuni giovani hanno portato i loro amici. Ci siamo trovati insieme da diverse parti del Vietnam. C’era la gioia di conoscerci ognuno, di ridere e di lavorare insieme come fratelli e sorelle senza distinzioni. Grazie per questo progetto #daretocare, una buona scusa per lavorare insieme e costruire questa fraternità tra di noi”.
Il 17-18 ottobre, con 30 giovani energici ed entusiasti, abbiamo fatto un viaggio significativo. Abbiamo potuto distribuire 300 pacchi di merci alle famiglie e 370 piccoli regali per i bambini. Durante il viaggio ci siamo resi conto di quanto siamo fortunati e felici rispetto alle situazioni di queste famiglie. Abbiamo condiviso ciò che abbiamo portato per dimostrare il nostro amore, ma alla fine abbiamo ricevuto più AMORE attraverso i loro sorrisi… Infatti, ogni volta che ci avviciniamo a loro sembra che ci conosciamo da molto tempo. Durante il viaggio alcuni giovani hanno portato i loro amici. Ci siamo trovati insieme da diverse parti del Vietnam. C’era la gioia di conoscerci ognuno, di ridere e di lavorare insieme come fratelli e sorelle senza distinzioni. Grazie per questo progetto #daretocare, una buona scusa per lavorare insieme e costruire questa fraternità tra di noi”.
I Gen e i giovani dei Focolari del Vietnam
Una spiritualità comunitaria conosce anche una “purificazione” comunitaria, come spiega Chiara Lubich nel seguente testo. Come il fratello amato nello stile evangelico, è causa di enorme gioia, così l’assenza di rapporti e di unità con gli altri può causare sofferenza e dolore. Giacché anche la via comunitaria non è e non può esser solamente tale, ma anche pienamente personale, è esperienza generale che quando ci si trova soli, dopo aver amato i fratelli, si avverte nell’anima l’unione con Dio. […] Per cui si può dire che chi va al fratello […], amando come il Vangelo insegna, si ritrova più Cristo, più uomo. E, poiché si cerca di essere uniti con i fratelli, si ama in modo speciale, oltre il silenzio, la parola, che è mezzo di comunicazione. Si parla per farsi uno con i fratelli. Si parla, nel Movimento, per comunicarsi le proprie esperienze sulla pratica della Parola di vita o sulla propria vita spirituale, consci che il fuoco non comunicato si spegne e che questa comunione d’anima è di grande valore spirituale. San Lorenzo Giustiniani diceva: “(…) Nulla infatti al mondo rende più lode a Dio e più lo rivela degno di lode, quanto l’umile e fraterno scambio di doni spirituali…”[1]. […] E quando non si parla si scrive: si scrivono lettere, articoli, libri, diari perché il Regno di Dio avanzi nei cuori. Si usano tutti i mezzi moderni di comunicazione. […] Anche nel (nostro) Movimento si praticano le mortificazioni indispensabili ad ogni vita cristiana, si fanno le penitenze, specie quelle consigliate dalla Chiesa, ma si ha una stima particolare per quelle che offre la vita d’unità con i fratelli. Essa non è facile per “l’uomo vecchio”, come lo chiama san Paolo[2], sempre pronto a farsi strada dentro di noi. L’unità fraterna poi non si compone una volta per tutte; occorre sempre ricostruirla. E se, quando l’unità esiste, e per essa c’è la presenza di Gesù in mezzo a noi, si sperimenta immensa gioia, quella promessa da Gesù nella sua preghiera per l’unità, quando l’unità vien meno subentrano le ombre e il disorientamento. Si vive in una specie di purgatorio. Ed è questa la penitenza che dobbiamo essere pronti ad affrontare. È qui che deve entrare in azione il nostro amore per Gesù crocifisso e abbandonato, chiave dell’unità; è qui che per amore di Lui, risolvendo prima in noi ogni dolore, si fa ogni sforzo per ricomporre l’unità.
Chiara Lubich
Da: Una spiritualità di comunione. In: Chiara Lubich, La dottrina spirituale, Milano 2001, pag. 69. [1] S. Lorenzo Giustiniani, Disciplina e perfezione della vita monastica, Roma 1967, p.4. [2] Uomo vecchio: nel senso paolino di uomo prigioniero dal proprio egoismo, cfr. Ef 4,22. (altro…)
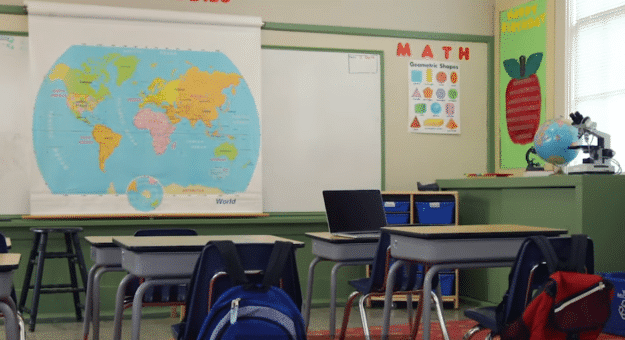
L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19, è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”.  Sanità, scuola, sicurezza sono l’architrave di qualsiasi nazione e per questo non possono sottostare al gioco dei profitti. L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19 (Progetto “Covid 19 Costruire un futuro migliore”, creato in collaborazione dal Dicastero per la Comunicazione e dello Sviluppo Umano Integrale), è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”. Perché, sostiene, tutto è fondamentalmente bene comune: lo è la politica nel suo senso più alto, lo è l’economia che guarda all’uomo prima che al tornaconto. E in questo nuovo paradigma globale che può nascere dal post-Covid la Chiesa, afferma, deve farsi “garante” di questo patrimonio collettivo, in quanto estranea alle logiche del mercato. La speranza, per Bruni, è che questa esperienza condizionata da un virus senza confini non faccia dimenticare “l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale”. Lei fa parte della Commissione vaticana COVID 19, il meccanismo di risposta istituito da Papa Francesco per far fronte a una pandemia senza precedenti. Personalmente, cosa spera di imparare da questa esperienza? In che modo la società, nel suo complesso, potrà trarre ispirazione dal lavoro della Commissione? La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è l’importanza del principio di precauzione e dei beni comuni. Il principio di precauzione, pilastro della Dottrina della Chiesa, il grande assente nella fase iniziale dell’epidemia, ci dice qualcosa di estremamente importante: il principio di precauzione è vissuto in modo ossessivo a livello individuale (basti pensare alle assicurazioni che stanno occupando al mondo) ma è totalmente assente a livello collettivo, il che rende le società del 21° secolo estremamente vulnerabili. Ecco perché quei Paesi che avevano salvato un po’ di welfare state si sono dimostrati molto più forti di quelli gestiti interamente dal mercato. E poi i beni comuni: come un male comune ci ha rivelato cosa sia il bene comune, la pandemia ci ha fatto vedere che con i beni comuni c’è bisogno di comunità e non solo del mercato. La sanità, la sicurezza, la scuola non possono essere lasciate al gioco dei profitti. Papa Francesco ha chiesto alla Commissione COVID 19 di preparare il futuro invece che di prepararsi per il futuro. In questa impresa, quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa cattolica come istituzione? La Chiesa Cattolica è una delle pochissime (se non l’unica) istituzione garante e custode del bene comune globale. Non avendo interessi privati, può perseguire l’interesse di tutti. Per questo oggi è molto ascoltata, per questa stessa ragione ha una responsabilità da esercitare su scala mondiale. Quali insegnamenti personali (se ce ne sono) ha tratto dall’esperienza di questa pandemia? Quali cambiamenti concreti spera di vedere dopo questa crisi, sia da un punto di vista personale che globale? Il primo insegnamento è il valore del bene relazionali: non potendo abbracciarci in questi mesi, ho riscoperto il valore di un abbraccio e di un incontro. Il secondo: possiamo e dobbiamo fare molte riunioni online e molto smart working, ma per decisioni importanti e per gli incontri decisivi la rete non basta, c’è bisogno del corpo. Quindi il boom del virtuale ci sta facendo scoprire l’importanza degli incontri in carne e ossa e dell’intelligenza dei corpi. Mi auguro che non dimenticheremo le lezioni di questi mesi (perché l’uomo dimentica molto velocemente), in particolare l’importanza della politica come la abbiamo riscoperta in questi mesi (come l’arte del bene comune contro i mali comuni), e che non ci dimenticheremo l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale.
Sanità, scuola, sicurezza sono l’architrave di qualsiasi nazione e per questo non possono sottostare al gioco dei profitti. L’economista Luigino Bruni, uno degli esperti chiamati da Papa Francesco a far parte della Commissione vaticana Covid-19 (Progetto “Covid 19 Costruire un futuro migliore”, creato in collaborazione dal Dicastero per la Comunicazione e dello Sviluppo Umano Integrale), è convinto che la lezione della pandemia aiuterà a riscoprire la verità profonda connessa all’espressione “bene comune”. Perché, sostiene, tutto è fondamentalmente bene comune: lo è la politica nel suo senso più alto, lo è l’economia che guarda all’uomo prima che al tornaconto. E in questo nuovo paradigma globale che può nascere dal post-Covid la Chiesa, afferma, deve farsi “garante” di questo patrimonio collettivo, in quanto estranea alle logiche del mercato. La speranza, per Bruni, è che questa esperienza condizionata da un virus senza confini non faccia dimenticare “l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale”. Lei fa parte della Commissione vaticana COVID 19, il meccanismo di risposta istituito da Papa Francesco per far fronte a una pandemia senza precedenti. Personalmente, cosa spera di imparare da questa esperienza? In che modo la società, nel suo complesso, potrà trarre ispirazione dal lavoro della Commissione? La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è l’importanza del principio di precauzione e dei beni comuni. Il principio di precauzione, pilastro della Dottrina della Chiesa, il grande assente nella fase iniziale dell’epidemia, ci dice qualcosa di estremamente importante: il principio di precauzione è vissuto in modo ossessivo a livello individuale (basti pensare alle assicurazioni che stanno occupando al mondo) ma è totalmente assente a livello collettivo, il che rende le società del 21° secolo estremamente vulnerabili. Ecco perché quei Paesi che avevano salvato un po’ di welfare state si sono dimostrati molto più forti di quelli gestiti interamente dal mercato. E poi i beni comuni: come un male comune ci ha rivelato cosa sia il bene comune, la pandemia ci ha fatto vedere che con i beni comuni c’è bisogno di comunità e non solo del mercato. La sanità, la sicurezza, la scuola non possono essere lasciate al gioco dei profitti. Papa Francesco ha chiesto alla Commissione COVID 19 di preparare il futuro invece che di prepararsi per il futuro. In questa impresa, quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa cattolica come istituzione? La Chiesa Cattolica è una delle pochissime (se non l’unica) istituzione garante e custode del bene comune globale. Non avendo interessi privati, può perseguire l’interesse di tutti. Per questo oggi è molto ascoltata, per questa stessa ragione ha una responsabilità da esercitare su scala mondiale. Quali insegnamenti personali (se ce ne sono) ha tratto dall’esperienza di questa pandemia? Quali cambiamenti concreti spera di vedere dopo questa crisi, sia da un punto di vista personale che globale? Il primo insegnamento è il valore del bene relazionali: non potendo abbracciarci in questi mesi, ho riscoperto il valore di un abbraccio e di un incontro. Il secondo: possiamo e dobbiamo fare molte riunioni online e molto smart working, ma per decisioni importanti e per gli incontri decisivi la rete non basta, c’è bisogno del corpo. Quindi il boom del virtuale ci sta facendo scoprire l’importanza degli incontri in carne e ossa e dell’intelligenza dei corpi. Mi auguro che non dimenticheremo le lezioni di questi mesi (perché l’uomo dimentica molto velocemente), in particolare l’importanza della politica come la abbiamo riscoperta in questi mesi (come l’arte del bene comune contro i mali comuni), e che non ci dimenticheremo l’importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale. 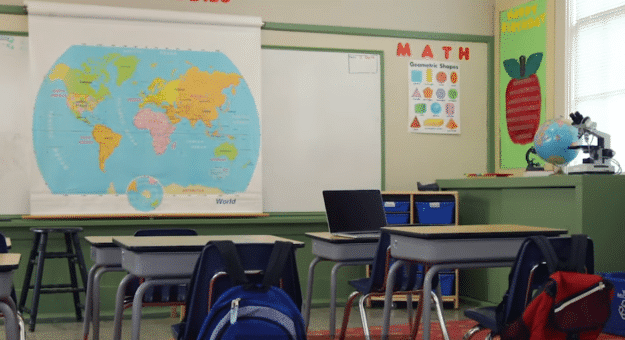 Preparare il mondo post-covid significa anche preparare le generazioni future, quelle che un domani saranno chiamate a decidere, a tracciare nuove vie. L’educazione, in questo senso, non è solo una “spesa” da contenere, anche in tempo di crisi? L’educazione, soprattutto quella dei bambini e dei giovani, è molto più di una “spesa”… è l’investimento collettivo con il più alto tasso di rendimento sociale. Mi auguro che quando, nei Paesi dove la scuola è ancora chiusa, questa verrà riaperta, si indica un giorno di festa nazionale. La democrazia comincia nei banchi di scuola e lì rinasce in ogni generazione. Il primo patrimonio (patres munus) che ci passiamo fra generazioni è quello educativo. Decine di milioni di ragazzi e ragazze nel mondo non hanno accesso all’educazione. Si può ignorare l’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani che afferma il diritto all’educazione per tutti, gratuita e obbligatoria, almeno per l’insegnamento elementare? Chiaramente non si dovrebbe ignorare, ma non possiamo chiedere che il costo della scuola venga sostenuto interamente da Paesi che non hanno sufficienti risorse. Dovremmo dar vita presto ad una nuova cooperazione internazionale sotto lo slogan: “la scuola per bambini e adolescenti è bene comune globale”, dove Paesi con più risorse aiutino quelli con meno a rendere effettivo il diritto allo studio gratuito. Questa pandemia ci sta mostrando che il mondo è una grande comunità, dobbiamo trasformare questo male comune in nuovi beni comuni globali. Anche nei paesi ricchi, le parti di bilancio dedicate all’educazione hanno subito tagli, a volta ingenti. Ci può essere un interesse a non investire sulle generazioni future? Se la logica economica prende il sopravvento aumenteranno i ragionamenti del tipo: “perché debbo fare qualcosa per le future generazioni, che cosa hanno fatto loro per me?”. Se il “do ut des”, il registro commerciale, diventa la nuova logica delle nazioni, investiremo sempre meno per la scuola, faremo sempre più debiti che pagheranno i bambini di oggi. Dobbiamo tornare generosi, coltivare virtù non economiche come la compassione, la mitezza, la magnanimità. La Chiesa cattolica è in prima linea per offrire un’educazione ai più poveri. Anche in condizioni di grande difficoltà economica, perché come vediamo in questo periodo di pandemia, i lockdown hanno avuto un impatto considerevole sulle scuole cattoliche. Ma la chiesa c’è e accoglie tutti, senza distinzione di fede, facendosi spazio di incontro e di dialogo. Quant’è importante quest’ultimo aspetto? La Chiesa è sempre stata una istituzione del bene comune. La parabola di Luca non ci dice che fede avesse l’uomo mezzo morto soccorso dal Samaritano. È proprio durante le grandi crisi che la Chiesa recupera la sua vocazione di “Mater et magistra”, che cresce la stima dei non cristiani nei suoi confronti, che ritorna quel mare che accoglie tutto per ridonare tutto a tutti, soprattutto ai più poveri, perché la Chiesa ha sempre saputo che l’indicatore di ogni bene comune è la condizione dei più poveri. L’insegnamento della religione, delle religioni, in un mondo sempre più tentato da divisioni, e che favorisce l’intrattenimento della paura e della tensione; quali risultati può portare? Dipende come la si insegna. La dimensione etica che pur c’è in ogni religione non è sufficiente. Il grande insegnamento che le religioni oggi posso dare riguarda la vita interiore e la spiritualità perché la nostra generazione nel giro di pochi decenni ha dilapidato un patrimonio millenario fatto di saggezza antica e di pietà popolare. Le religioni devono aiutare i giovani e tutti a riscrivere una nuova grammatica della vita interiore, e se non lo fanno la depressione diventerà la peste del 21° secolo. Clicca qui per vedere l’intervista
Preparare il mondo post-covid significa anche preparare le generazioni future, quelle che un domani saranno chiamate a decidere, a tracciare nuove vie. L’educazione, in questo senso, non è solo una “spesa” da contenere, anche in tempo di crisi? L’educazione, soprattutto quella dei bambini e dei giovani, è molto più di una “spesa”… è l’investimento collettivo con il più alto tasso di rendimento sociale. Mi auguro che quando, nei Paesi dove la scuola è ancora chiusa, questa verrà riaperta, si indica un giorno di festa nazionale. La democrazia comincia nei banchi di scuola e lì rinasce in ogni generazione. Il primo patrimonio (patres munus) che ci passiamo fra generazioni è quello educativo. Decine di milioni di ragazzi e ragazze nel mondo non hanno accesso all’educazione. Si può ignorare l’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani che afferma il diritto all’educazione per tutti, gratuita e obbligatoria, almeno per l’insegnamento elementare? Chiaramente non si dovrebbe ignorare, ma non possiamo chiedere che il costo della scuola venga sostenuto interamente da Paesi che non hanno sufficienti risorse. Dovremmo dar vita presto ad una nuova cooperazione internazionale sotto lo slogan: “la scuola per bambini e adolescenti è bene comune globale”, dove Paesi con più risorse aiutino quelli con meno a rendere effettivo il diritto allo studio gratuito. Questa pandemia ci sta mostrando che il mondo è una grande comunità, dobbiamo trasformare questo male comune in nuovi beni comuni globali. Anche nei paesi ricchi, le parti di bilancio dedicate all’educazione hanno subito tagli, a volta ingenti. Ci può essere un interesse a non investire sulle generazioni future? Se la logica economica prende il sopravvento aumenteranno i ragionamenti del tipo: “perché debbo fare qualcosa per le future generazioni, che cosa hanno fatto loro per me?”. Se il “do ut des”, il registro commerciale, diventa la nuova logica delle nazioni, investiremo sempre meno per la scuola, faremo sempre più debiti che pagheranno i bambini di oggi. Dobbiamo tornare generosi, coltivare virtù non economiche come la compassione, la mitezza, la magnanimità. La Chiesa cattolica è in prima linea per offrire un’educazione ai più poveri. Anche in condizioni di grande difficoltà economica, perché come vediamo in questo periodo di pandemia, i lockdown hanno avuto un impatto considerevole sulle scuole cattoliche. Ma la chiesa c’è e accoglie tutti, senza distinzione di fede, facendosi spazio di incontro e di dialogo. Quant’è importante quest’ultimo aspetto? La Chiesa è sempre stata una istituzione del bene comune. La parabola di Luca non ci dice che fede avesse l’uomo mezzo morto soccorso dal Samaritano. È proprio durante le grandi crisi che la Chiesa recupera la sua vocazione di “Mater et magistra”, che cresce la stima dei non cristiani nei suoi confronti, che ritorna quel mare che accoglie tutto per ridonare tutto a tutti, soprattutto ai più poveri, perché la Chiesa ha sempre saputo che l’indicatore di ogni bene comune è la condizione dei più poveri. L’insegnamento della religione, delle religioni, in un mondo sempre più tentato da divisioni, e che favorisce l’intrattenimento della paura e della tensione; quali risultati può portare? Dipende come la si insegna. La dimensione etica che pur c’è in ogni religione non è sufficiente. Il grande insegnamento che le religioni oggi posso dare riguarda la vita interiore e la spiritualità perché la nostra generazione nel giro di pochi decenni ha dilapidato un patrimonio millenario fatto di saggezza antica e di pietà popolare. Le religioni devono aiutare i giovani e tutti a riscrivere una nuova grammatica della vita interiore, e se non lo fanno la depressione diventerà la peste del 21° secolo. Clicca qui per vedere l’intervista
Fonte: Vatican News
Notifiche