
Nov 12, 2016 | Chiara Lubich, Chiesa, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo

 Un centinaio di partecipanti di 14 paesi europei (dal Portogallo alla Russia), tre giorni intensi di comunione, presenti imprenditori degli inizi dell’Economia di comunione (EdC), giovani imprenditori, studenti ed economisti. «Il convegno è iniziato con la mostra del pittore francese Michel Pochet su “Dio Misericordia” – raccontano gli organizzatori –. Le sue opere d’arte hanno fatto da cornice durante tutto l’incontro. In particolare i dipinti del “Buon Pastore” e del “Buon Samaritano” hanno ispirato gli imprenditori a voler diventare, nella loro impresa e ambienti di lavoro, ciò che quei dipinti rappresentano». «Sono venuto per sapere di più sull’EdC. Ero piuttosto critico, ma in questi giorni ho capito cosa significa: prendersi cura degli altri, anche nel lavoro. Si tratta di costruire dei rapporti fra le persone. Mi ha fatto molto bene incontrarmi con tutti voi. È forte vedere che gli imprenditori dell’Economia di comunione sono altruisti, che siete quelli che vi occupate dei bisogni degli altri. Spero di diventare in breve uno di voi». È l’impressione a caldo di Federico (Italia), studente di management.
Un centinaio di partecipanti di 14 paesi europei (dal Portogallo alla Russia), tre giorni intensi di comunione, presenti imprenditori degli inizi dell’Economia di comunione (EdC), giovani imprenditori, studenti ed economisti. «Il convegno è iniziato con la mostra del pittore francese Michel Pochet su “Dio Misericordia” – raccontano gli organizzatori –. Le sue opere d’arte hanno fatto da cornice durante tutto l’incontro. In particolare i dipinti del “Buon Pastore” e del “Buon Samaritano” hanno ispirato gli imprenditori a voler diventare, nella loro impresa e ambienti di lavoro, ciò che quei dipinti rappresentano». «Sono venuto per sapere di più sull’EdC. Ero piuttosto critico, ma in questi giorni ho capito cosa significa: prendersi cura degli altri, anche nel lavoro. Si tratta di costruire dei rapporti fra le persone. Mi ha fatto molto bene incontrarmi con tutti voi. È forte vedere che gli imprenditori dell’Economia di comunione sono altruisti, che siete quelli che vi occupate dei bisogni degli altri. Spero di diventare in breve uno di voi». È l’impressione a caldo di Federico (Italia), studente di management. 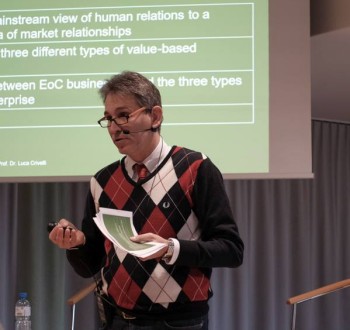 Tre giorni di intensa comunione. Tra gli interventi, quello dell’economista svizzero Luca Crivelli sulle nuove forme di Social Business, traendone spunti di interesse per l’EdC a 25 anni dal suo inizio; di Anouk Grevin, Docente all’Università di Nantes e all’Istituto Universitario Sophia, sul «dono e la gratuità nell’azienda, puntando ad avere sguardi di misericordia in grado di “vedere” il dono nel lavoro dei propri collaboratori, di “riconoscerlo”, di “ringraziarlo” per un atto libero che nessuno può comprare. Sguardi di misericordia in grado di porre ciascuno in condizione di dare il meglio di sé, perché sente la fiducia dell’altro e riesce ad esprimersi senza paura di sbagliare»; e di Herbert Lauenroth, esperto in intercultura presso il Centro ecumenico di Ottmaring (Augsburg), sulla misericordia applicata alla vita economica e politica. Un imprenditore dell’Inghilterra al suo primo incontro EdC, diceva: «Una cosa che voi avete e che potete donare a quanti lottano per un mondo migliore ma che magari non vedono la luce, è la vostra gioia. È una cosa incredibile! Un vero capitale spirituale». E Peter, giovane della Serbia: «Sono venuto pensando che poteva essere una perdita di tempo. Ma ho trovato gente aperta, ogni dialogo è stato importante per me. Porto via un grande beneficio da questo incontro».
Tre giorni di intensa comunione. Tra gli interventi, quello dell’economista svizzero Luca Crivelli sulle nuove forme di Social Business, traendone spunti di interesse per l’EdC a 25 anni dal suo inizio; di Anouk Grevin, Docente all’Università di Nantes e all’Istituto Universitario Sophia, sul «dono e la gratuità nell’azienda, puntando ad avere sguardi di misericordia in grado di “vedere” il dono nel lavoro dei propri collaboratori, di “riconoscerlo”, di “ringraziarlo” per un atto libero che nessuno può comprare. Sguardi di misericordia in grado di porre ciascuno in condizione di dare il meglio di sé, perché sente la fiducia dell’altro e riesce ad esprimersi senza paura di sbagliare»; e di Herbert Lauenroth, esperto in intercultura presso il Centro ecumenico di Ottmaring (Augsburg), sulla misericordia applicata alla vita economica e politica. Un imprenditore dell’Inghilterra al suo primo incontro EdC, diceva: «Una cosa che voi avete e che potete donare a quanti lottano per un mondo migliore ma che magari non vedono la luce, è la vostra gioia. È una cosa incredibile! Un vero capitale spirituale». E Peter, giovane della Serbia: «Sono venuto pensando che poteva essere una perdita di tempo. Ma ho trovato gente aperta, ogni dialogo è stato importante per me. Porto via un grande beneficio da questo incontro».  Il prof. Luigino Bruni, coordinatore mondiale del progetto EdC, ha ricordato i tempi della vita di Chiara Lubich a Trento, con il primo gruppo di focolarine, che invitavano i poveri a pranzo nella loro casa, «usando le tovaglie e le stoviglie più belle», sottolineando che «il nostro primo modo di curare la povertà, prima ancora di donare gli utili, è portarla dentro casa, nelle nostre aziende, e amarla con “gesti di bellezza”». Un’altra sfida individuata “per arrivare vivi al 50° dell’Economia di comunione”, riguarda le imprese. «È evidente a tutti che la comunione nelle imprese deve trovare nuove espressioni più visibili e radicali – afferma–, coinvolgendo la “governance” e soprattutto i diritti di proprietà. Finora abbiamo puntato sulla cultura e sulle motivazioni degli imprenditori, ma è sempre più evidente in un’economia in grande cambiamento che le imprese non coincidono con gli imprenditori». Ed ha aggiunto: «Uno dei punti di forza dell’EdC di questi anni, della sua resilienza, è che ha respirato con tutto il corpo. Non ha avuto delle singole persone a guidarla, ma tanti membri attivi. L’EdC è forte quando in ogni lavoratore dell’impresa c’è la stessa energia». In sintesi, ha concluso Bruni: «Abbiamo preso coscienza che l’EdC in Europa è ancora viva dopo 25 anni, che continua a portare frutto, a svilupparsi in nuovi ambienti e regioni. Significativa è stata la presenza delle prime imprese in Russia, e del nuovo incubatore di imprese in Portogallo: quell’Europa dall’Atlantico agli Urali che tutti sogniamo. Inoltre è un’EdC giovane, aperta (molti leader dell’EdC non vengono dal Movimento dei Focolari) e con tanta voglia di futuro». Servizio fotografico su Flickr: Foto gallery Il prossimo appuntamento è previsto per il 2017 in Belgio. (altro…)
Il prof. Luigino Bruni, coordinatore mondiale del progetto EdC, ha ricordato i tempi della vita di Chiara Lubich a Trento, con il primo gruppo di focolarine, che invitavano i poveri a pranzo nella loro casa, «usando le tovaglie e le stoviglie più belle», sottolineando che «il nostro primo modo di curare la povertà, prima ancora di donare gli utili, è portarla dentro casa, nelle nostre aziende, e amarla con “gesti di bellezza”». Un’altra sfida individuata “per arrivare vivi al 50° dell’Economia di comunione”, riguarda le imprese. «È evidente a tutti che la comunione nelle imprese deve trovare nuove espressioni più visibili e radicali – afferma–, coinvolgendo la “governance” e soprattutto i diritti di proprietà. Finora abbiamo puntato sulla cultura e sulle motivazioni degli imprenditori, ma è sempre più evidente in un’economia in grande cambiamento che le imprese non coincidono con gli imprenditori». Ed ha aggiunto: «Uno dei punti di forza dell’EdC di questi anni, della sua resilienza, è che ha respirato con tutto il corpo. Non ha avuto delle singole persone a guidarla, ma tanti membri attivi. L’EdC è forte quando in ogni lavoratore dell’impresa c’è la stessa energia». In sintesi, ha concluso Bruni: «Abbiamo preso coscienza che l’EdC in Europa è ancora viva dopo 25 anni, che continua a portare frutto, a svilupparsi in nuovi ambienti e regioni. Significativa è stata la presenza delle prime imprese in Russia, e del nuovo incubatore di imprese in Portogallo: quell’Europa dall’Atlantico agli Urali che tutti sogniamo. Inoltre è un’EdC giovane, aperta (molti leader dell’EdC non vengono dal Movimento dei Focolari) e con tanta voglia di futuro». Servizio fotografico su Flickr: Foto gallery Il prossimo appuntamento è previsto per il 2017 in Belgio. (altro…)

Ott 31, 2016 | Chiara Lubich, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Senza categoria

Dot.ssa Chantal Grevin
![Jesús Morán: Relazione e relazionalità]()
Ago 6, 2016 | Centro internazionale
 «In principio è la relazione», scriveva nella prima metà del secolo scorso il grande Martin Buber, esponente del pensiero ebraico. Da allora, e grazie agli sviluppi compiuti dalla scuola dialogica, questa categoria è entrata con autorevolezza nella scena filosofica contemporanea, con conseguenze per la vita sociale e l’orizzonte di senso dell’esistenza. Le scienze umane, in particolare, ne hanno fatto un uso proficuo e fecondo. Sempre più tendiamo a pensare che la relazione sia quella dimensione della persona che in qualche modo la definisce. La capacità di relazione è perciò diventata importante in tutti gli ambiti dell’agire umano. Il fallimento di tante nobili imprese, per esempio, può essere fatto risalire a problemi di relazione. Avere una buona relazione risulta, per lo più, un positivo punto di partenza e una garanzia di continuità. La relazione è davvero essenziale. Eppure, dal mio punto di vista, mi permetterei di modificare la frase del grande filosofo austriaco-israeliano con quest’altra: «In principio è la relazionalità». Con questo intendo dire che la relazione è sempre seconda, perché c’è qualcosa di più radicale: la relazionalità. È la struttura relazionale della persona che permette di entrare in relazione, ma non esige necessariamente un rapporto con l’altro per esserci. La relazionalità implica l’essere, la relazione, il fare. Relazionalità e relazione non si oppongono, ma vanno distinte perché toccano due dimensioni diverse della persona. La conclusione sembra paradossale: ci sono persone povere di relazioni ma ricche di relazionalità, e viceversa. Avere tanti rapporti, infatti, non è necessariamente indice di relazionalità. Pongo un caso estremo: una suora di clausura può essere più ricca di relazionalità di una star cinematografica, anche se infinitamente più povera di relazioni. Si può essere aperti all’infinito senza valicare il perimetro della propria stanza, così come chiusi in sé stessi mentre si gira il mondo. È una questione di quantità e qualità, allora? Sì e no. Decisiva – come criterio di qualità delle relazioni – è la misura con cui esse partono o meno dalla struttura relazionale della persona. Non è, quindi, questione di quantità o qualità, ma di profondità e reciprocità. La relazionalità proviene dal fondo dell’essere umano ed è sempre aperta. Aperta alla reciprocità, mentre non sempre le relazioni schivano la tentazione individuo-centrica. Partire dalla struttura relazionale della persona vuol dire allora essere coscienti che nelle nostre relazioni c’è sempre qualcosa che le precede e qualcosa che le eccede. Significa rinunciare a dominare le relazioni, addirittura a costruirle come se dipendessero da noi. Le relazioni non si costruiscono, si cercano. Questo vuol dire che nei nostri rapporti dobbiamo essere attenti soprattutto a ciò che ci sorprende, all’imprevisto. La “volontà di potenza” che caratterizza spesso l’uomo moderno tende non di rado a imporre le relazioni, anche per buoni fini. Può succedere, per esempio, nel rapporto padre-figli o nei rapporti di coppia. Se vogliamo rapporti carichi di relazionalità dobbiamo invece curare l’atteggiamento di attesa, di ascolto, di pazienza, anche di assenza. La relazionalità richiede amore insieme a una sorta di passività che, ben vissuta, è l’unica veramente aperta al nuovo. Le conseguenze etiche di questa distinzione, che può apparire solo accademica, sono in certi casi decisive. Un esempio: se la persona fosse primariamente relazione, intendendo con questo la capacità di costruire rapporti, l’aborto sarebbe legittimo perché l’embrione non è in grado di costruirli. Anche la persona in coma non avrebbe diritto di vivere, perché incapace di avere rapporti con gli altri. Se invece ciò che definisce alla radice la persona è la relazionalità, che per esserci non ha bisogno di rapporti perché viene prima di essi, allora le cose cambiano sostanzialmente. Fonte: Città Nuova (gennaio 2016, pag. 67) (altro…)
«In principio è la relazione», scriveva nella prima metà del secolo scorso il grande Martin Buber, esponente del pensiero ebraico. Da allora, e grazie agli sviluppi compiuti dalla scuola dialogica, questa categoria è entrata con autorevolezza nella scena filosofica contemporanea, con conseguenze per la vita sociale e l’orizzonte di senso dell’esistenza. Le scienze umane, in particolare, ne hanno fatto un uso proficuo e fecondo. Sempre più tendiamo a pensare che la relazione sia quella dimensione della persona che in qualche modo la definisce. La capacità di relazione è perciò diventata importante in tutti gli ambiti dell’agire umano. Il fallimento di tante nobili imprese, per esempio, può essere fatto risalire a problemi di relazione. Avere una buona relazione risulta, per lo più, un positivo punto di partenza e una garanzia di continuità. La relazione è davvero essenziale. Eppure, dal mio punto di vista, mi permetterei di modificare la frase del grande filosofo austriaco-israeliano con quest’altra: «In principio è la relazionalità». Con questo intendo dire che la relazione è sempre seconda, perché c’è qualcosa di più radicale: la relazionalità. È la struttura relazionale della persona che permette di entrare in relazione, ma non esige necessariamente un rapporto con l’altro per esserci. La relazionalità implica l’essere, la relazione, il fare. Relazionalità e relazione non si oppongono, ma vanno distinte perché toccano due dimensioni diverse della persona. La conclusione sembra paradossale: ci sono persone povere di relazioni ma ricche di relazionalità, e viceversa. Avere tanti rapporti, infatti, non è necessariamente indice di relazionalità. Pongo un caso estremo: una suora di clausura può essere più ricca di relazionalità di una star cinematografica, anche se infinitamente più povera di relazioni. Si può essere aperti all’infinito senza valicare il perimetro della propria stanza, così come chiusi in sé stessi mentre si gira il mondo. È una questione di quantità e qualità, allora? Sì e no. Decisiva – come criterio di qualità delle relazioni – è la misura con cui esse partono o meno dalla struttura relazionale della persona. Non è, quindi, questione di quantità o qualità, ma di profondità e reciprocità. La relazionalità proviene dal fondo dell’essere umano ed è sempre aperta. Aperta alla reciprocità, mentre non sempre le relazioni schivano la tentazione individuo-centrica. Partire dalla struttura relazionale della persona vuol dire allora essere coscienti che nelle nostre relazioni c’è sempre qualcosa che le precede e qualcosa che le eccede. Significa rinunciare a dominare le relazioni, addirittura a costruirle come se dipendessero da noi. Le relazioni non si costruiscono, si cercano. Questo vuol dire che nei nostri rapporti dobbiamo essere attenti soprattutto a ciò che ci sorprende, all’imprevisto. La “volontà di potenza” che caratterizza spesso l’uomo moderno tende non di rado a imporre le relazioni, anche per buoni fini. Può succedere, per esempio, nel rapporto padre-figli o nei rapporti di coppia. Se vogliamo rapporti carichi di relazionalità dobbiamo invece curare l’atteggiamento di attesa, di ascolto, di pazienza, anche di assenza. La relazionalità richiede amore insieme a una sorta di passività che, ben vissuta, è l’unica veramente aperta al nuovo. Le conseguenze etiche di questa distinzione, che può apparire solo accademica, sono in certi casi decisive. Un esempio: se la persona fosse primariamente relazione, intendendo con questo la capacità di costruire rapporti, l’aborto sarebbe legittimo perché l’embrione non è in grado di costruirli. Anche la persona in coma non avrebbe diritto di vivere, perché incapace di avere rapporti con gli altri. Se invece ciò che definisce alla radice la persona è la relazionalità, che per esserci non ha bisogno di rapporti perché viene prima di essi, allora le cose cambiano sostanzialmente. Fonte: Città Nuova (gennaio 2016, pag. 67) (altro…)

Giu 10, 2016 | Centro internazionale, Cultura, Focolari nel Mondo, Spiritualità

Igino Giordani (1942)

Giu 9, 2016 | Chiara Lubich, Cultura, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità
 La spaziosa aula “Centro Trasferimento della conoscenza” dell’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II, ha accolto il congresso Conflicts, Dialogue and Culture of Unity (3-4 giugno 2016). Si è svolto all’insegna della “trasmissione” di conoscenze attraverso il dialogo accademico tra i 180 partecipanti, professori e studiosi di diverse discipline dell’area delle scienze sociali, con 95 contributi. Una interazione fatta anche di domande e di sollecitazioni nel condividere lo sforzo di una ricerca. Un dono fra specializzazioni, ma anche fra generazioni e aree geografiche dell’Europa nell’apertura alle sfide del mondo. Il convegno, aperto dalla relazione di Jesús Morán, copresidente dei Focolari, dal titolo “La cultura dell’unità e alcune grandi sfide dell’umanità di oggi”, prendeva le mosse dal 20° anniversario della consegna a Chiara Lubich del Dottorato honoris causa in Scienze Sociali, da parte dell’Università Cattolica di Lublino nel giugno 1996. La Laudatio tenuta allora dal prof. Adam Biela ne precisava la motivazione: il carisma dell’unità «è un’attualizzazione concreta e pratica di una nuova visione delle strutture sociali, economiche, politiche, di educazione, dei rapporti religiosi, che consiglia, raccomanda, suggerisce, educa e promuove l’unità» fra le persone. E coglieva, nell’ispirazione rivoluzionaria di Chiara Lubich, manifestata a partire dagli anni ’40, gli elementi di un nuovo paradigma delle scienze sociali, tanto da coniare l’inedito concetto di paradigma dell’unità. Quello a Lublino, 20 anni dopo, è «un convegno complesso e interessante», secondo il prof. Italo Fiorin, Presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione, Università Lumsa, Roma. «Anzitutto per il tema, costruito su tre parole collegate. Conflitto: con la riflessione sulla situazione del mondo, non catastrofica ma problematica, stimolando la responsabilità. Dialogo: via per condurre e tradurre il conflitto in qualcosa di nuovo, con un’azione positiva. Unità: risultato di un dialogo, che non è il manifestarsi di un pensiero unico, ma la conquista di una maggiore consapevolezza della propria identità». «Da 200-300 anni il sapere si è diviso in tanti campi», afferma la neuro scienziata Catherine Belzung, Università di Tours, Francia. «Ma l’attuale frammentazione non permette di fare progressi. È arrivato il tempo del dialogo anche interdisciplinare e qui si è visto che è possibile, desiderato ed efficace. Nel mio campo ci sono già delle scoperte che mostrano che il progresso è possibile solo amplificando il sapere attraverso il dialogo interdisciplinare. Il pensiero di Chiara Lubich mi sembra il paradigma da avere davanti quando mi interesso della ricerca interdisciplinare perché “paradigma trinitario”: ogni disciplina rimane distinta, ma deve avere dentro di sé le conoscenze delle altre discipline per essere a sua volta trasformata e in questo modo continuare il dialogo. Penso che il modello di unità e distinzione, proposto già nel campo spirituale, possa essere trasferito al campo del dialogo interdisciplinare molto facilmente». Conferma il prof. Marek Rembierz, pedagogo dell’Università di Silesia, Katowice, Polonia: «Mi è risultato molto interessante pensare in una dimensione interdisciplinare. E ciò ha richiesto un cambiamento di mentalità notevole: modificare il linguaggio della scienza, della cultura, con il linguaggio del cuore. È stato fonte di ispirazione per i partecipanti e può esserlo per la vita sociale delle persone». Gianvittorio Caprara, ordinario di Psicologia e neuroscienze sociali, Università la Sapienza, Roma: «Chiara Lubich ha avuto delle intuizioni particolarmente felici e feconde. Feconde perché hanno ispirato un lavoro, un movimento; ora ispirano questo congresso e progetti di ricerca. È una riflessione che continua e che diventa ispirazione. Una scoperta particolare per me è stata la pregnanza della categoria della fratellanza, proprio in una società come la nostra, il cui grave rischio è quello di non avere più fratelli. Incoraggio i Focolari ad insistere di più ancora sulla ricerca sistematica della conoscenza perché l’azione diventi più trasformativa ed efficace». «Riguardo la fraternità – riprende Fiorin – il prof. Stefano Zamagni operava nel suo intervento una lettura molto affascinante sull’Economia di Comunione e la riferiva pure alla politica. Ritengo che tale lettura sia trasferibile anche all’educazione per ispirare il legame educativo e didattico e condurre a delle soluzioni didattiche importanti. È un terreno che merita approfondimento e al quale intendo dedicare la mia attenzione». La conclusione del congresso è affidata al prof. Biela, a Daniela Ropelato vicepreside dello IUS e a Renata Simon del Centro internazionale dei Focolari. Per dare continuità al dialogo interdisciplinare, che ha permeato il convegno, un’indicazione forte viene dal pensiero riportato di Chiara Lubich: «Per accogliere in sé il Tutto bisogna esser il nulla come Gesù Abbandonato (…). Bisogna mettersi di fronte a tutti in posizione di imparare, ché si ha da imparare realmente. E solo il nulla raccoglie tutto in sé e stringe a sé ogni cosa in unità». Un incoraggiamento raccolto a cooperare con competenza, sapienza e capacità dialogica anche e proprio sul piano accademico. (altro…)
La spaziosa aula “Centro Trasferimento della conoscenza” dell’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II, ha accolto il congresso Conflicts, Dialogue and Culture of Unity (3-4 giugno 2016). Si è svolto all’insegna della “trasmissione” di conoscenze attraverso il dialogo accademico tra i 180 partecipanti, professori e studiosi di diverse discipline dell’area delle scienze sociali, con 95 contributi. Una interazione fatta anche di domande e di sollecitazioni nel condividere lo sforzo di una ricerca. Un dono fra specializzazioni, ma anche fra generazioni e aree geografiche dell’Europa nell’apertura alle sfide del mondo. Il convegno, aperto dalla relazione di Jesús Morán, copresidente dei Focolari, dal titolo “La cultura dell’unità e alcune grandi sfide dell’umanità di oggi”, prendeva le mosse dal 20° anniversario della consegna a Chiara Lubich del Dottorato honoris causa in Scienze Sociali, da parte dell’Università Cattolica di Lublino nel giugno 1996. La Laudatio tenuta allora dal prof. Adam Biela ne precisava la motivazione: il carisma dell’unità «è un’attualizzazione concreta e pratica di una nuova visione delle strutture sociali, economiche, politiche, di educazione, dei rapporti religiosi, che consiglia, raccomanda, suggerisce, educa e promuove l’unità» fra le persone. E coglieva, nell’ispirazione rivoluzionaria di Chiara Lubich, manifestata a partire dagli anni ’40, gli elementi di un nuovo paradigma delle scienze sociali, tanto da coniare l’inedito concetto di paradigma dell’unità. Quello a Lublino, 20 anni dopo, è «un convegno complesso e interessante», secondo il prof. Italo Fiorin, Presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione, Università Lumsa, Roma. «Anzitutto per il tema, costruito su tre parole collegate. Conflitto: con la riflessione sulla situazione del mondo, non catastrofica ma problematica, stimolando la responsabilità. Dialogo: via per condurre e tradurre il conflitto in qualcosa di nuovo, con un’azione positiva. Unità: risultato di un dialogo, che non è il manifestarsi di un pensiero unico, ma la conquista di una maggiore consapevolezza della propria identità». «Da 200-300 anni il sapere si è diviso in tanti campi», afferma la neuro scienziata Catherine Belzung, Università di Tours, Francia. «Ma l’attuale frammentazione non permette di fare progressi. È arrivato il tempo del dialogo anche interdisciplinare e qui si è visto che è possibile, desiderato ed efficace. Nel mio campo ci sono già delle scoperte che mostrano che il progresso è possibile solo amplificando il sapere attraverso il dialogo interdisciplinare. Il pensiero di Chiara Lubich mi sembra il paradigma da avere davanti quando mi interesso della ricerca interdisciplinare perché “paradigma trinitario”: ogni disciplina rimane distinta, ma deve avere dentro di sé le conoscenze delle altre discipline per essere a sua volta trasformata e in questo modo continuare il dialogo. Penso che il modello di unità e distinzione, proposto già nel campo spirituale, possa essere trasferito al campo del dialogo interdisciplinare molto facilmente». Conferma il prof. Marek Rembierz, pedagogo dell’Università di Silesia, Katowice, Polonia: «Mi è risultato molto interessante pensare in una dimensione interdisciplinare. E ciò ha richiesto un cambiamento di mentalità notevole: modificare il linguaggio della scienza, della cultura, con il linguaggio del cuore. È stato fonte di ispirazione per i partecipanti e può esserlo per la vita sociale delle persone». Gianvittorio Caprara, ordinario di Psicologia e neuroscienze sociali, Università la Sapienza, Roma: «Chiara Lubich ha avuto delle intuizioni particolarmente felici e feconde. Feconde perché hanno ispirato un lavoro, un movimento; ora ispirano questo congresso e progetti di ricerca. È una riflessione che continua e che diventa ispirazione. Una scoperta particolare per me è stata la pregnanza della categoria della fratellanza, proprio in una società come la nostra, il cui grave rischio è quello di non avere più fratelli. Incoraggio i Focolari ad insistere di più ancora sulla ricerca sistematica della conoscenza perché l’azione diventi più trasformativa ed efficace». «Riguardo la fraternità – riprende Fiorin – il prof. Stefano Zamagni operava nel suo intervento una lettura molto affascinante sull’Economia di Comunione e la riferiva pure alla politica. Ritengo che tale lettura sia trasferibile anche all’educazione per ispirare il legame educativo e didattico e condurre a delle soluzioni didattiche importanti. È un terreno che merita approfondimento e al quale intendo dedicare la mia attenzione». La conclusione del congresso è affidata al prof. Biela, a Daniela Ropelato vicepreside dello IUS e a Renata Simon del Centro internazionale dei Focolari. Per dare continuità al dialogo interdisciplinare, che ha permeato il convegno, un’indicazione forte viene dal pensiero riportato di Chiara Lubich: «Per accogliere in sé il Tutto bisogna esser il nulla come Gesù Abbandonato (…). Bisogna mettersi di fronte a tutti in posizione di imparare, ché si ha da imparare realmente. E solo il nulla raccoglie tutto in sé e stringe a sé ogni cosa in unità». Un incoraggiamento raccolto a cooperare con competenza, sapienza e capacità dialogica anche e proprio sul piano accademico. (altro…)


 Un centinaio di partecipanti di 14 paesi europei (dal Portogallo alla Russia), tre giorni intensi di comunione, presenti imprenditori degli inizi dell’Economia di comunione (EdC), giovani imprenditori, studenti ed economisti. «Il convegno è iniziato con la mostra del pittore francese Michel Pochet su “Dio Misericordia” – raccontano gli organizzatori –. Le sue opere d’arte hanno fatto da cornice durante tutto l’incontro. In particolare i dipinti del “Buon Pastore” e del “Buon Samaritano” hanno ispirato gli imprenditori a voler diventare, nella loro impresa e ambienti di lavoro, ciò che quei dipinti rappresentano». «Sono venuto per sapere di più sull’EdC. Ero piuttosto critico, ma in questi giorni ho capito cosa significa: prendersi cura degli altri, anche nel lavoro. Si tratta di costruire dei rapporti fra le persone. Mi ha fatto molto bene incontrarmi con tutti voi. È forte vedere che gli imprenditori dell’Economia di comunione sono altruisti, che siete quelli che vi occupate dei bisogni degli altri. Spero di diventare in breve uno di voi». È l’impressione a caldo di Federico (Italia), studente di management.
Un centinaio di partecipanti di 14 paesi europei (dal Portogallo alla Russia), tre giorni intensi di comunione, presenti imprenditori degli inizi dell’Economia di comunione (EdC), giovani imprenditori, studenti ed economisti. «Il convegno è iniziato con la mostra del pittore francese Michel Pochet su “Dio Misericordia” – raccontano gli organizzatori –. Le sue opere d’arte hanno fatto da cornice durante tutto l’incontro. In particolare i dipinti del “Buon Pastore” e del “Buon Samaritano” hanno ispirato gli imprenditori a voler diventare, nella loro impresa e ambienti di lavoro, ciò che quei dipinti rappresentano». «Sono venuto per sapere di più sull’EdC. Ero piuttosto critico, ma in questi giorni ho capito cosa significa: prendersi cura degli altri, anche nel lavoro. Si tratta di costruire dei rapporti fra le persone. Mi ha fatto molto bene incontrarmi con tutti voi. È forte vedere che gli imprenditori dell’Economia di comunione sono altruisti, che siete quelli che vi occupate dei bisogni degli altri. Spero di diventare in breve uno di voi». È l’impressione a caldo di Federico (Italia), studente di management. 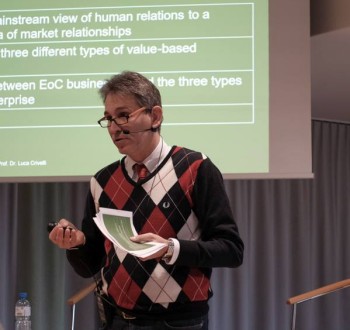 Tre giorni di intensa comunione. Tra gli interventi, quello dell’economista svizzero Luca Crivelli sulle nuove forme di Social Business, traendone spunti di interesse per l’EdC a 25 anni dal suo inizio; di Anouk Grevin, Docente all’Università di Nantes e all’Istituto Universitario Sophia, sul «dono e la gratuità nell’azienda, puntando ad avere sguardi di misericordia in grado di “vedere” il dono nel lavoro dei propri collaboratori, di “riconoscerlo”, di “ringraziarlo” per un atto libero che nessuno può comprare. Sguardi di misericordia in grado di porre ciascuno in condizione di dare il meglio di sé, perché sente la fiducia dell’altro e riesce ad esprimersi senza paura di sbagliare»; e di Herbert Lauenroth, esperto in intercultura presso il Centro ecumenico di Ottmaring (Augsburg), sulla misericordia applicata alla vita economica e politica. Un imprenditore dell’Inghilterra al suo primo incontro EdC, diceva: «Una cosa che voi avete e che potete donare a quanti lottano per un mondo migliore ma che magari non vedono la luce, è la vostra gioia. È una cosa incredibile! Un vero capitale spirituale». E Peter, giovane della Serbia: «Sono venuto pensando che poteva essere una perdita di tempo. Ma ho trovato gente aperta, ogni dialogo è stato importante per me. Porto via un grande beneficio da questo incontro».
Tre giorni di intensa comunione. Tra gli interventi, quello dell’economista svizzero Luca Crivelli sulle nuove forme di Social Business, traendone spunti di interesse per l’EdC a 25 anni dal suo inizio; di Anouk Grevin, Docente all’Università di Nantes e all’Istituto Universitario Sophia, sul «dono e la gratuità nell’azienda, puntando ad avere sguardi di misericordia in grado di “vedere” il dono nel lavoro dei propri collaboratori, di “riconoscerlo”, di “ringraziarlo” per un atto libero che nessuno può comprare. Sguardi di misericordia in grado di porre ciascuno in condizione di dare il meglio di sé, perché sente la fiducia dell’altro e riesce ad esprimersi senza paura di sbagliare»; e di Herbert Lauenroth, esperto in intercultura presso il Centro ecumenico di Ottmaring (Augsburg), sulla misericordia applicata alla vita economica e politica. Un imprenditore dell’Inghilterra al suo primo incontro EdC, diceva: «Una cosa che voi avete e che potete donare a quanti lottano per un mondo migliore ma che magari non vedono la luce, è la vostra gioia. È una cosa incredibile! Un vero capitale spirituale». E Peter, giovane della Serbia: «Sono venuto pensando che poteva essere una perdita di tempo. Ma ho trovato gente aperta, ogni dialogo è stato importante per me. Porto via un grande beneficio da questo incontro».  Il prof. Luigino Bruni, coordinatore mondiale del progetto EdC, ha ricordato i tempi della vita di Chiara Lubich a Trento, con il primo gruppo di focolarine, che invitavano i poveri a pranzo nella loro casa, «usando le tovaglie e le stoviglie più belle», sottolineando che «il nostro primo modo di curare la povertà, prima ancora di donare gli utili, è portarla dentro casa, nelle nostre aziende, e amarla con “gesti di bellezza”». Un’altra sfida individuata “per arrivare vivi al 50° dell’Economia di comunione”, riguarda le imprese. «È evidente a tutti che la comunione nelle imprese deve trovare nuove espressioni più visibili e radicali – afferma–, coinvolgendo la “governance” e soprattutto i diritti di proprietà. Finora abbiamo puntato sulla cultura e sulle motivazioni degli imprenditori, ma è sempre più evidente in un’economia in grande cambiamento che le imprese non coincidono con gli imprenditori». Ed ha aggiunto: «Uno dei punti di forza dell’EdC di questi anni, della sua resilienza, è che ha respirato con tutto il corpo. Non ha avuto delle singole persone a guidarla, ma tanti membri attivi. L’EdC è forte quando in ogni lavoratore dell’impresa c’è la stessa energia». In sintesi, ha concluso Bruni: «Abbiamo preso coscienza che l’EdC in Europa è ancora viva dopo 25 anni, che continua a portare frutto, a svilupparsi in nuovi ambienti e regioni. Significativa è stata la presenza delle prime imprese in Russia, e del nuovo incubatore di imprese in Portogallo: quell’Europa dall’Atlantico agli Urali che tutti sogniamo. Inoltre è un’EdC giovane, aperta (molti leader dell’EdC non vengono dal Movimento dei Focolari) e con tanta voglia di futuro». Servizio fotografico su Flickr: Foto gallery Il prossimo appuntamento è previsto per il 2017 in Belgio. (altro…)
Il prof. Luigino Bruni, coordinatore mondiale del progetto EdC, ha ricordato i tempi della vita di Chiara Lubich a Trento, con il primo gruppo di focolarine, che invitavano i poveri a pranzo nella loro casa, «usando le tovaglie e le stoviglie più belle», sottolineando che «il nostro primo modo di curare la povertà, prima ancora di donare gli utili, è portarla dentro casa, nelle nostre aziende, e amarla con “gesti di bellezza”». Un’altra sfida individuata “per arrivare vivi al 50° dell’Economia di comunione”, riguarda le imprese. «È evidente a tutti che la comunione nelle imprese deve trovare nuove espressioni più visibili e radicali – afferma–, coinvolgendo la “governance” e soprattutto i diritti di proprietà. Finora abbiamo puntato sulla cultura e sulle motivazioni degli imprenditori, ma è sempre più evidente in un’economia in grande cambiamento che le imprese non coincidono con gli imprenditori». Ed ha aggiunto: «Uno dei punti di forza dell’EdC di questi anni, della sua resilienza, è che ha respirato con tutto il corpo. Non ha avuto delle singole persone a guidarla, ma tanti membri attivi. L’EdC è forte quando in ogni lavoratore dell’impresa c’è la stessa energia». In sintesi, ha concluso Bruni: «Abbiamo preso coscienza che l’EdC in Europa è ancora viva dopo 25 anni, che continua a portare frutto, a svilupparsi in nuovi ambienti e regioni. Significativa è stata la presenza delle prime imprese in Russia, e del nuovo incubatore di imprese in Portogallo: quell’Europa dall’Atlantico agli Urali che tutti sogniamo. Inoltre è un’EdC giovane, aperta (molti leader dell’EdC non vengono dal Movimento dei Focolari) e con tanta voglia di futuro». Servizio fotografico su Flickr: Foto gallery Il prossimo appuntamento è previsto per il 2017 in Belgio. (altro…)

 «In principio è la relazione», scriveva nella prima metà del secolo scorso il grande Martin Buber, esponente del pensiero ebraico. Da allora, e grazie agli sviluppi compiuti dalla scuola dialogica, questa categoria è entrata con autorevolezza nella scena filosofica contemporanea, con conseguenze per la vita sociale e l’orizzonte di senso dell’esistenza. Le scienze umane, in particolare, ne hanno fatto un uso proficuo e fecondo. Sempre più tendiamo a pensare che la relazione sia quella dimensione della persona che in qualche modo la definisce. La capacità di relazione è perciò diventata importante in tutti gli ambiti dell’agire umano. Il fallimento di tante nobili imprese, per esempio, può essere fatto risalire a problemi di relazione. Avere una buona relazione risulta, per lo più, un positivo punto di partenza e una garanzia di continuità. La relazione è davvero essenziale. Eppure, dal mio punto di vista, mi permetterei di modificare la frase del grande filosofo austriaco-israeliano con quest’altra: «In principio è la relazionalità». Con questo intendo dire che la relazione è sempre seconda, perché c’è qualcosa di più radicale: la relazionalità. È la struttura relazionale della persona che permette di entrare in relazione, ma non esige necessariamente un rapporto con l’altro per esserci. La relazionalità implica l’essere, la relazione, il fare. Relazionalità e relazione non si oppongono, ma vanno distinte perché toccano due dimensioni diverse della persona. La conclusione sembra paradossale: ci sono persone povere di relazioni ma ricche di relazionalità, e viceversa. Avere tanti rapporti, infatti, non è necessariamente indice di relazionalità. Pongo un caso estremo: una suora di clausura può essere più ricca di relazionalità di una star cinematografica, anche se infinitamente più povera di relazioni. Si può essere aperti all’infinito senza valicare il perimetro della propria stanza, così come chiusi in sé stessi mentre si gira il mondo. È una questione di quantità e qualità, allora? Sì e no. Decisiva – come criterio di qualità delle relazioni – è la misura con cui esse partono o meno dalla struttura relazionale della persona. Non è, quindi, questione di quantità o qualità, ma di profondità e reciprocità. La relazionalità proviene dal fondo dell’essere umano ed è sempre aperta. Aperta alla reciprocità, mentre non sempre le relazioni schivano la tentazione individuo-centrica. Partire dalla struttura relazionale della persona vuol dire allora essere coscienti che nelle nostre relazioni c’è sempre qualcosa che le precede e qualcosa che le eccede. Significa rinunciare a dominare le relazioni, addirittura a costruirle come se dipendessero da noi. Le relazioni non si costruiscono, si cercano. Questo vuol dire che nei nostri rapporti dobbiamo essere attenti soprattutto a ciò che ci sorprende, all’imprevisto. La “volontà di potenza” che caratterizza spesso l’uomo moderno tende non di rado a imporre le relazioni, anche per buoni fini. Può succedere, per esempio, nel rapporto padre-figli o nei rapporti di coppia. Se vogliamo rapporti carichi di relazionalità dobbiamo invece curare l’atteggiamento di attesa, di ascolto, di pazienza, anche di assenza. La relazionalità richiede amore insieme a una sorta di passività che, ben vissuta, è l’unica veramente aperta al nuovo. Le conseguenze etiche di questa distinzione, che può apparire solo accademica, sono in certi casi decisive. Un esempio: se la persona fosse primariamente relazione, intendendo con questo la capacità di costruire rapporti, l’aborto sarebbe legittimo perché l’embrione non è in grado di costruirli. Anche la persona in coma non avrebbe diritto di vivere, perché incapace di avere rapporti con gli altri. Se invece ciò che definisce alla radice la persona è la relazionalità, che per esserci non ha bisogno di rapporti perché viene prima di essi, allora le cose cambiano sostanzialmente. Fonte:
«In principio è la relazione», scriveva nella prima metà del secolo scorso il grande Martin Buber, esponente del pensiero ebraico. Da allora, e grazie agli sviluppi compiuti dalla scuola dialogica, questa categoria è entrata con autorevolezza nella scena filosofica contemporanea, con conseguenze per la vita sociale e l’orizzonte di senso dell’esistenza. Le scienze umane, in particolare, ne hanno fatto un uso proficuo e fecondo. Sempre più tendiamo a pensare che la relazione sia quella dimensione della persona che in qualche modo la definisce. La capacità di relazione è perciò diventata importante in tutti gli ambiti dell’agire umano. Il fallimento di tante nobili imprese, per esempio, può essere fatto risalire a problemi di relazione. Avere una buona relazione risulta, per lo più, un positivo punto di partenza e una garanzia di continuità. La relazione è davvero essenziale. Eppure, dal mio punto di vista, mi permetterei di modificare la frase del grande filosofo austriaco-israeliano con quest’altra: «In principio è la relazionalità». Con questo intendo dire che la relazione è sempre seconda, perché c’è qualcosa di più radicale: la relazionalità. È la struttura relazionale della persona che permette di entrare in relazione, ma non esige necessariamente un rapporto con l’altro per esserci. La relazionalità implica l’essere, la relazione, il fare. Relazionalità e relazione non si oppongono, ma vanno distinte perché toccano due dimensioni diverse della persona. La conclusione sembra paradossale: ci sono persone povere di relazioni ma ricche di relazionalità, e viceversa. Avere tanti rapporti, infatti, non è necessariamente indice di relazionalità. Pongo un caso estremo: una suora di clausura può essere più ricca di relazionalità di una star cinematografica, anche se infinitamente più povera di relazioni. Si può essere aperti all’infinito senza valicare il perimetro della propria stanza, così come chiusi in sé stessi mentre si gira il mondo. È una questione di quantità e qualità, allora? Sì e no. Decisiva – come criterio di qualità delle relazioni – è la misura con cui esse partono o meno dalla struttura relazionale della persona. Non è, quindi, questione di quantità o qualità, ma di profondità e reciprocità. La relazionalità proviene dal fondo dell’essere umano ed è sempre aperta. Aperta alla reciprocità, mentre non sempre le relazioni schivano la tentazione individuo-centrica. Partire dalla struttura relazionale della persona vuol dire allora essere coscienti che nelle nostre relazioni c’è sempre qualcosa che le precede e qualcosa che le eccede. Significa rinunciare a dominare le relazioni, addirittura a costruirle come se dipendessero da noi. Le relazioni non si costruiscono, si cercano. Questo vuol dire che nei nostri rapporti dobbiamo essere attenti soprattutto a ciò che ci sorprende, all’imprevisto. La “volontà di potenza” che caratterizza spesso l’uomo moderno tende non di rado a imporre le relazioni, anche per buoni fini. Può succedere, per esempio, nel rapporto padre-figli o nei rapporti di coppia. Se vogliamo rapporti carichi di relazionalità dobbiamo invece curare l’atteggiamento di attesa, di ascolto, di pazienza, anche di assenza. La relazionalità richiede amore insieme a una sorta di passività che, ben vissuta, è l’unica veramente aperta al nuovo. Le conseguenze etiche di questa distinzione, che può apparire solo accademica, sono in certi casi decisive. Un esempio: se la persona fosse primariamente relazione, intendendo con questo la capacità di costruire rapporti, l’aborto sarebbe legittimo perché l’embrione non è in grado di costruirli. Anche la persona in coma non avrebbe diritto di vivere, perché incapace di avere rapporti con gli altri. Se invece ciò che definisce alla radice la persona è la relazionalità, che per esserci non ha bisogno di rapporti perché viene prima di essi, allora le cose cambiano sostanzialmente. Fonte: 
