Un cammino di riconciliazione in Myanmar
https://vimeo.com/192246318 Copyright 2016 © CSC Audiovisivi – All rights reserved (altro…)
https://vimeo.com/192246318 Copyright 2016 © CSC Audiovisivi – All rights reserved (altro…)

 «Abbiamo appena concluso un viaggio che da Bobo-Dioulasso ci ha portato dapprima a Dorì, città all’estremo nord del Burkina Faso e poi a Niamey, in Niger. L’obiettivo era rispondere alle attese delle comunità sorte attorno allo spirito dei Focolari di condividere le esperienze e i frutti di vita che cominciano a farsi strada anche in questi Paesi del Sahel». Così inizia il racconto di Aurora e Pascal, focolarini a Bobo Dioulasso, la seconda città del Burkina Faso, sede del Movimento per quella regione. Il Burkina, con i suoi oltre 17 milioni di abitanti (50% musulmani, 30% cristiani e 20% di religioni tradizionali) è uno dei Paesi più poveri del mondo, insieme al vicino Niger, anch’esso senza sbocco al mare. «Siamo arrivati alla città di Niamey, la capitale del Niger, dove siamo stati accolti con tanta gioia dalla comunità, a cominciare dal vescovo Mons. Laurent Lompo il quale è diventato sacerdote – come lui stesso ci tiene a dire – grazie alla partecipazione alla sua prima Mariapoli. Mons. Lompo. un pastore molto vicino alla sua gente e concreto nell’amore, ci ha raccontato tante esperienze di dialogo e amicizia con i musulmani che, in Niger, sono il 93 % della popolazione (10 milioni). Qui il rapporto dei cristiani con il mondo musulmano rappresenta una vera sfida, soprattutto dopo il 17 gennaio 2015 quando, a seguito degli attentati di Parigi alla rivista Charlie Hebdo, gli estremisti islamici hanno bruciato nel Paese più di 70 chiese cristiane».
«Abbiamo appena concluso un viaggio che da Bobo-Dioulasso ci ha portato dapprima a Dorì, città all’estremo nord del Burkina Faso e poi a Niamey, in Niger. L’obiettivo era rispondere alle attese delle comunità sorte attorno allo spirito dei Focolari di condividere le esperienze e i frutti di vita che cominciano a farsi strada anche in questi Paesi del Sahel». Così inizia il racconto di Aurora e Pascal, focolarini a Bobo Dioulasso, la seconda città del Burkina Faso, sede del Movimento per quella regione. Il Burkina, con i suoi oltre 17 milioni di abitanti (50% musulmani, 30% cristiani e 20% di religioni tradizionali) è uno dei Paesi più poveri del mondo, insieme al vicino Niger, anch’esso senza sbocco al mare. «Siamo arrivati alla città di Niamey, la capitale del Niger, dove siamo stati accolti con tanta gioia dalla comunità, a cominciare dal vescovo Mons. Laurent Lompo il quale è diventato sacerdote – come lui stesso ci tiene a dire – grazie alla partecipazione alla sua prima Mariapoli. Mons. Lompo. un pastore molto vicino alla sua gente e concreto nell’amore, ci ha raccontato tante esperienze di dialogo e amicizia con i musulmani che, in Niger, sono il 93 % della popolazione (10 milioni). Qui il rapporto dei cristiani con il mondo musulmano rappresenta una vera sfida, soprattutto dopo il 17 gennaio 2015 quando, a seguito degli attentati di Parigi alla rivista Charlie Hebdo, gli estremisti islamici hanno bruciato nel Paese più di 70 chiese cristiane». «Mons. Lompo ci ha raccomandato di andare a trovare anche Hawa, una signora che in passato aveva partecipato agli incontri del Movimento ma che per motivi familiari era diventata musulmana. Sorpresa e commossa della nostra visita, ci ha parlato della sua famiglia, dei bei momenti vissuti in Mariapoli e sentendo che presto da quelle parti ci sarà ancora una Mariapoli, ha promesso che si preparerà a parteciparvi. Era bello vedere, in lei e in tanti altri musulmani che abbiamo incontrato, la gioia di poter rivivere nella città di Maria (Mariapoli) l’esperienza dell’amore reciproco. Una gioia che abbiamo poi condiviso con il vescovo». «Ci siamo infine trovati con la piccola comunità di Niamey: persone molto profonde e con la voglia di vivere il Vangelo e di portare avanti l’esperienza dell’unità. Questa nostra visita le ha ulteriormente incoraggiate in questa strada. Una di loro, a nome di tutti, diceva: «E vero che noi in Africa ci troviamo spesso a vivere delle situazioni difficili, ma con la spiritualità di Chiara Lubich impariamo ad amare l’altro facendo nostro il suo dolore. Quanto vorrei che questo ideale di fraternità invadesse la nostra piccola Chiesa e la società del nostro Paese»! Aurora De Oliveira e Pascal Pontien Ntawuyankira (altro…)
«Mons. Lompo ci ha raccomandato di andare a trovare anche Hawa, una signora che in passato aveva partecipato agli incontri del Movimento ma che per motivi familiari era diventata musulmana. Sorpresa e commossa della nostra visita, ci ha parlato della sua famiglia, dei bei momenti vissuti in Mariapoli e sentendo che presto da quelle parti ci sarà ancora una Mariapoli, ha promesso che si preparerà a parteciparvi. Era bello vedere, in lei e in tanti altri musulmani che abbiamo incontrato, la gioia di poter rivivere nella città di Maria (Mariapoli) l’esperienza dell’amore reciproco. Una gioia che abbiamo poi condiviso con il vescovo». «Ci siamo infine trovati con la piccola comunità di Niamey: persone molto profonde e con la voglia di vivere il Vangelo e di portare avanti l’esperienza dell’unità. Questa nostra visita le ha ulteriormente incoraggiate in questa strada. Una di loro, a nome di tutti, diceva: «E vero che noi in Africa ci troviamo spesso a vivere delle situazioni difficili, ma con la spiritualità di Chiara Lubich impariamo ad amare l’altro facendo nostro il suo dolore. Quanto vorrei che questo ideale di fraternità invadesse la nostra piccola Chiesa e la società del nostro Paese»! Aurora De Oliveira e Pascal Pontien Ntawuyankira (altro…)

6 febbraio: feedback con i giovani. Contatto per la vendita dei biglietti: 091 682 3793 e 328 172 3941
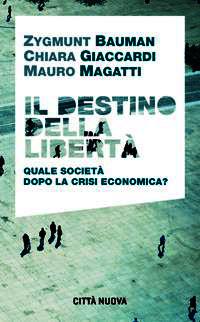
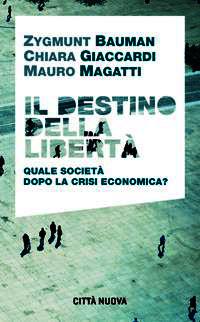 Tra i più grandi intellettuali della nostra epoca, lucido interprete della società post moderna da lui definita, con il tramonto delle grandi ideologie, “liquida”, Zygmunt Bauman (1925-2017) ci ha lasciato. Nel volume di Zygmunt Bauman, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, IL DESTINO DELLA LIBERTà. Quale società dopo la crisi economica? ( a cura di Andrea Possieri. Città Nuova, 2016), la lucida riflessione del sociologo polacco sulla libertà. Il testamento umano di un grande maestro del nostro tempo. Bauman, in dialogo con i sociologi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, si interroga sulla libertà. Una domanda che lui stesso definisce “il nostro destino […] una sorte che non può essere ignorata e non ci abbandona mai”. È partendo da questo interrogativo che Bauman riflette sull’esito paradossale che ha avuto il poderoso sviluppo economico degli ultimi 40 anni. Il progresso ha aumentato le potenzialità di scelta dell’uomo, ma lo ha ingabbiato in una concezione radicalmente individualista dell’esistenza umana, prigioniero del consumismo, degli apparati tecno-economici e della volontà di affermare se stesso. Nel corso della sua riflessione delinea così la sua personale idea di libertà: “Ritengo che l’idea più giusta di libertà, la sua concezione più genuina, sia quella che valorizzi, innanzitutto, il diritto di scegliere che detiene ogni singolo individuo; che consideri, in secondo luogo, l’assunzione di responsabilità delle proprie scelte e delle conseguenze che esse provocano; che comprenda, infine, la speranza che tutto ciò che queste scelte comportano produrrà un miglioramento per la società. Si tratta, perciò, di una concezione della libertà che è basata sul dare piuttosto che sul prendere, sull’aggiungere piuttosto che sul sottrarre”. Una visione della libertà che si coniuga in Zygmunt Bauman con la solidarietà e la condivisione, trovando in questo una straordinaria affinità con papa Francesco. _________________ Chiara Giaccardi, sociologa, è docente di Sociologia dei processi culturali presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Sociologia e Antropologia dei Media e dirige la rivista Comunicazioni Sociali. Mauro Magatti sociologo ed economista, è docente presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegnaSociologia generale. Dal 2006 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Sociologia. Città Nuova Editrice
Tra i più grandi intellettuali della nostra epoca, lucido interprete della società post moderna da lui definita, con il tramonto delle grandi ideologie, “liquida”, Zygmunt Bauman (1925-2017) ci ha lasciato. Nel volume di Zygmunt Bauman, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, IL DESTINO DELLA LIBERTà. Quale società dopo la crisi economica? ( a cura di Andrea Possieri. Città Nuova, 2016), la lucida riflessione del sociologo polacco sulla libertà. Il testamento umano di un grande maestro del nostro tempo. Bauman, in dialogo con i sociologi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, si interroga sulla libertà. Una domanda che lui stesso definisce “il nostro destino […] una sorte che non può essere ignorata e non ci abbandona mai”. È partendo da questo interrogativo che Bauman riflette sull’esito paradossale che ha avuto il poderoso sviluppo economico degli ultimi 40 anni. Il progresso ha aumentato le potenzialità di scelta dell’uomo, ma lo ha ingabbiato in una concezione radicalmente individualista dell’esistenza umana, prigioniero del consumismo, degli apparati tecno-economici e della volontà di affermare se stesso. Nel corso della sua riflessione delinea così la sua personale idea di libertà: “Ritengo che l’idea più giusta di libertà, la sua concezione più genuina, sia quella che valorizzi, innanzitutto, il diritto di scegliere che detiene ogni singolo individuo; che consideri, in secondo luogo, l’assunzione di responsabilità delle proprie scelte e delle conseguenze che esse provocano; che comprenda, infine, la speranza che tutto ciò che queste scelte comportano produrrà un miglioramento per la società. Si tratta, perciò, di una concezione della libertà che è basata sul dare piuttosto che sul prendere, sull’aggiungere piuttosto che sul sottrarre”. Una visione della libertà che si coniuga in Zygmunt Bauman con la solidarietà e la condivisione, trovando in questo una straordinaria affinità con papa Francesco. _________________ Chiara Giaccardi, sociologa, è docente di Sociologia dei processi culturali presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Sociologia e Antropologia dei Media e dirige la rivista Comunicazioni Sociali. Mauro Magatti sociologo ed economista, è docente presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegnaSociologia generale. Dal 2006 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Sociologia. Città Nuova Editrice

 Piotr, cosa ti ha condotto a scegliere di iscriverti a Sophia? «Mi hanno guidato verso Sophia molti fattori. Negli anni del liceo ho avuto la fortuna di incontrare un filosofo torinese che si chiamava Costanzo Preve, che mi ha avvicinato agli studi della filosofia a partire dalla mia preesistente curiosità per la politica. La sua impostazione filosofica hegelo-marxiana mi ha aperto uno sguardo sulla totalità sociale che al contempo ha reso ardua la scelta dell’università; ero indeciso tra economia, politica e filosofia, e un professore, al termine del liceo, mi aveva parlato di Sophia, anche se offriva solo corsi di laurea magistrale. Alla fine, anche per avere un “pezzo di carta” più “spendibile”, ho optato per la laurea triennale in economia a Genova». Scelta che però non ti ha lasciato soddisfatto… «L’insoddisfazione nei confronti dell’impostazione “mainstream” di molti corsi mi ha portato ad aderire alla rete internazionale di Rethinking Economics per promuovere il pluralismo economico, metodologico e interdisciplinare nell’insegnamento universitario dell’economia, fondandone una sede locale. In modo autonomo, parallelamente, ho continuato i miei studi musicali e filosofici. Inoltre sono diventato giornalista: faccio parte della redazione della testata Termometro Politico e da qualche mese dirigo la rivista di dibattito ecclesiale Nipoti di Maritain. Venendo più precisamente al punto, in questi anni ho letto alcuni saggi del preside Piero Coda e gli chiesi di visitare Sophia. Venni due volte, prima di iscrivermi. Ogni volta, la conferma della mia vocazione “sophiana” ne è uscita sempre più rafforzata». Quale percorso hai deciso di seguire e cosa ti stanno dando i primi mesi di frequenza? «Ho scelto il percorso di ontologia trinitaria, anche per la possibilità di usufruire dell’accordo con l’università di Perugia per il doppio titolo, così da ottenere, oltre a quello vaticano, anche una laurea magistrale italiana in filosofia con indirizzo didattico, che eventualmente mi aprirebbe anche la strada dell’insegnamento liceale. In questi primi mesi quasi tutti abbiamo frequentato gli stessi corsi filosofici, teologici, politici ed economici, il che consente di partire da una base comune. Questa interdisciplinarietà, nel mio caso, non è stata affatto una sorpresa, ma una scelta consapevole, deliberata. Dal punto di vista accademico, il livello di Sophia è molto elevato e mi ha dato la possibilità di approfondire argomenti di interesse personale durante i corsi. Da fine agosto vivo nella residenza, esattamente due piani sopra le aule universitarie, assieme a 9 ragazzi di ogni continente, dall’Argentina alla Cina, dalla Germania alla Tanzania, passando per il Libano. Ottima convivenza, ben organizzata anche nei lavori domestici: sin da subito ci siamo sentiti davvero fratelli, nelle piccole premure quotidiane». I tuoi progetti? Cosa intravedi? «Difficile dirlo, perché al momento non faccio altro che aprirmi nuove strade; l’obiettivo di medio termine è conseguire la laurea, ma per la tesi ho molte idee differenti e, come spesso accade, probabilmente nessuna di esse sarà quella definitiva. Dopo potrei pensare ad un dottorato, ma si vedrà. Vorrei comunque portare avanti l’attività giornalistica e, dal punto di vista lavorativo, non mi dispiacerebbe insegnare oppure trovare una posizione nel mondo dell’editoria. Ma non vorrei mai porre ostacoli allo Spirito che potrebbe spingermi anche altrove». Fonte: IUS online (altro…)
Piotr, cosa ti ha condotto a scegliere di iscriverti a Sophia? «Mi hanno guidato verso Sophia molti fattori. Negli anni del liceo ho avuto la fortuna di incontrare un filosofo torinese che si chiamava Costanzo Preve, che mi ha avvicinato agli studi della filosofia a partire dalla mia preesistente curiosità per la politica. La sua impostazione filosofica hegelo-marxiana mi ha aperto uno sguardo sulla totalità sociale che al contempo ha reso ardua la scelta dell’università; ero indeciso tra economia, politica e filosofia, e un professore, al termine del liceo, mi aveva parlato di Sophia, anche se offriva solo corsi di laurea magistrale. Alla fine, anche per avere un “pezzo di carta” più “spendibile”, ho optato per la laurea triennale in economia a Genova». Scelta che però non ti ha lasciato soddisfatto… «L’insoddisfazione nei confronti dell’impostazione “mainstream” di molti corsi mi ha portato ad aderire alla rete internazionale di Rethinking Economics per promuovere il pluralismo economico, metodologico e interdisciplinare nell’insegnamento universitario dell’economia, fondandone una sede locale. In modo autonomo, parallelamente, ho continuato i miei studi musicali e filosofici. Inoltre sono diventato giornalista: faccio parte della redazione della testata Termometro Politico e da qualche mese dirigo la rivista di dibattito ecclesiale Nipoti di Maritain. Venendo più precisamente al punto, in questi anni ho letto alcuni saggi del preside Piero Coda e gli chiesi di visitare Sophia. Venni due volte, prima di iscrivermi. Ogni volta, la conferma della mia vocazione “sophiana” ne è uscita sempre più rafforzata». Quale percorso hai deciso di seguire e cosa ti stanno dando i primi mesi di frequenza? «Ho scelto il percorso di ontologia trinitaria, anche per la possibilità di usufruire dell’accordo con l’università di Perugia per il doppio titolo, così da ottenere, oltre a quello vaticano, anche una laurea magistrale italiana in filosofia con indirizzo didattico, che eventualmente mi aprirebbe anche la strada dell’insegnamento liceale. In questi primi mesi quasi tutti abbiamo frequentato gli stessi corsi filosofici, teologici, politici ed economici, il che consente di partire da una base comune. Questa interdisciplinarietà, nel mio caso, non è stata affatto una sorpresa, ma una scelta consapevole, deliberata. Dal punto di vista accademico, il livello di Sophia è molto elevato e mi ha dato la possibilità di approfondire argomenti di interesse personale durante i corsi. Da fine agosto vivo nella residenza, esattamente due piani sopra le aule universitarie, assieme a 9 ragazzi di ogni continente, dall’Argentina alla Cina, dalla Germania alla Tanzania, passando per il Libano. Ottima convivenza, ben organizzata anche nei lavori domestici: sin da subito ci siamo sentiti davvero fratelli, nelle piccole premure quotidiane». I tuoi progetti? Cosa intravedi? «Difficile dirlo, perché al momento non faccio altro che aprirmi nuove strade; l’obiettivo di medio termine è conseguire la laurea, ma per la tesi ho molte idee differenti e, come spesso accade, probabilmente nessuna di esse sarà quella definitiva. Dopo potrei pensare ad un dottorato, ma si vedrà. Vorrei comunque portare avanti l’attività giornalistica e, dal punto di vista lavorativo, non mi dispiacerebbe insegnare oppure trovare una posizione nel mondo dell’editoria. Ma non vorrei mai porre ostacoli allo Spirito che potrebbe spingermi anche altrove». Fonte: IUS online (altro…)
https://vimeo.com/192490499 Copyright 2016 © CSC Audiovisivi – All rights reserved (altro…)

 Migranti Primi sbarchi nella nostra città. Oggi le operazioni di prima accoglienza sono state spostate nello spiazzo della palestra comunale accanto casa, per cui dal balcone posso osservare file lunghissime di migranti che, scalzi o in canottiera e pantaloncini, attendono di passare i controlli del caso. Di colpo si alza il vento e la temperatura si abbassa. Non riesco più a stare ferma, devo fare qualcosa per questi fratelli già così provati. Scendo in strada e, scorto tra gli addetti alla sorveglianza un conoscente, vengo a sapere da lui che il vestiario scarseggia. Torno a casa, con mio marito metto insieme quanto ci sembra utile e dopo vari andirivieni consegniamo tutto all’amico perché venga distribuito. Anche altri conoscenti, da noi avvisati, aggiungono roba. Sta iniziando a piovere forte, ma ormai quasi tutti sono forniti di vestiti. Tanti ricambiano con un sorriso e un “grazie”, forse una delle poche parole italiane che sanno. Raffaella (Italia) Raccolta di fondi Venuta a conoscere che in una famiglia numerosa e povera il papà aveva bisogno urgente di un’operazione ma non aveva di che pagare, ho sentito il richiamo di Gesù a fare qualcosa e con alcune amiche mi sono impegnata a fare una raccolta di fondi nella quale abbiamo coinvolto anche i colleghi di lavoro. Una volta raggiunta la cifra necessaria, ho accompagnato l’infermo all’ospedale pagando l’importo relativo alle cure. L’intervento è andato bene. Non so se la gioia di quella famiglia è stata maggiore della nostra. Penso che anche piccoli gesti del genere contribuiscano a costruire la pace. N. Y. (Giordania) Vicini di casa La nostra dirimpettaia era malata e bisognosa di molte cure. Per accudirla, il coniuge era andato in pensione prima del tempo. Mio marito ed io ci sentimmo spinti a fare qualcosa per entrambi e finimmo per diventare amici. Nella confidenza stabilitasi tra noi, si toccò anche l’argomento della fede. Venimmo a sapere che lei si era allontanata dalla Chiesa per il comportamento non corretto di qualche sacerdote; quanto a lui, preso dal lavoro, non aveva mai avuto tempo per altro. Quando raccontai come Dio si era fatto strada nella mia vita, la nostra vicina cominciò a porsi delle domande e ne dedusse che forse la stessa malattia poteva essere un ponte che Dio stava gettando verso di lei. L’atmosfera pesante e triste che aleggiava in quella casa svanì. Anche lei cominciò a curare di più il suo aspetto. Una sera suo marito mi confidò: «Per la serenità non ci sono medicine, e da qualche tempo noi usufruiamo di questo bene». L. M. (Francia) A cura di Oreste Paliotti (altro…)
Migranti Primi sbarchi nella nostra città. Oggi le operazioni di prima accoglienza sono state spostate nello spiazzo della palestra comunale accanto casa, per cui dal balcone posso osservare file lunghissime di migranti che, scalzi o in canottiera e pantaloncini, attendono di passare i controlli del caso. Di colpo si alza il vento e la temperatura si abbassa. Non riesco più a stare ferma, devo fare qualcosa per questi fratelli già così provati. Scendo in strada e, scorto tra gli addetti alla sorveglianza un conoscente, vengo a sapere da lui che il vestiario scarseggia. Torno a casa, con mio marito metto insieme quanto ci sembra utile e dopo vari andirivieni consegniamo tutto all’amico perché venga distribuito. Anche altri conoscenti, da noi avvisati, aggiungono roba. Sta iniziando a piovere forte, ma ormai quasi tutti sono forniti di vestiti. Tanti ricambiano con un sorriso e un “grazie”, forse una delle poche parole italiane che sanno. Raffaella (Italia) Raccolta di fondi Venuta a conoscere che in una famiglia numerosa e povera il papà aveva bisogno urgente di un’operazione ma non aveva di che pagare, ho sentito il richiamo di Gesù a fare qualcosa e con alcune amiche mi sono impegnata a fare una raccolta di fondi nella quale abbiamo coinvolto anche i colleghi di lavoro. Una volta raggiunta la cifra necessaria, ho accompagnato l’infermo all’ospedale pagando l’importo relativo alle cure. L’intervento è andato bene. Non so se la gioia di quella famiglia è stata maggiore della nostra. Penso che anche piccoli gesti del genere contribuiscano a costruire la pace. N. Y. (Giordania) Vicini di casa La nostra dirimpettaia era malata e bisognosa di molte cure. Per accudirla, il coniuge era andato in pensione prima del tempo. Mio marito ed io ci sentimmo spinti a fare qualcosa per entrambi e finimmo per diventare amici. Nella confidenza stabilitasi tra noi, si toccò anche l’argomento della fede. Venimmo a sapere che lei si era allontanata dalla Chiesa per il comportamento non corretto di qualche sacerdote; quanto a lui, preso dal lavoro, non aveva mai avuto tempo per altro. Quando raccontai come Dio si era fatto strada nella mia vita, la nostra vicina cominciò a porsi delle domande e ne dedusse che forse la stessa malattia poteva essere un ponte che Dio stava gettando verso di lei. L’atmosfera pesante e triste che aleggiava in quella casa svanì. Anche lei cominciò a curare di più il suo aspetto. Una sera suo marito mi confidò: «Per la serenità non ci sono medicine, e da qualche tempo noi usufruiamo di questo bene». L. M. (Francia) A cura di Oreste Paliotti (altro…)

 Una serata ricca di varietà: dalla musica classica e pop balletto, contemplativo e groovy, musicale e buffet condiviso. Come nelle precedenti occasioni, il concerto di beneficenza è stato un progetto realizzato da Giovani per un Mondo Unito di Vienna e dalla gioventù di Mor Efrem della comunità siro-ortodossa. Circa 200 persone sono arrivate nonostante la gelida notte di dicembre e dando generosamente il loro sostegno ai rifugiati siriani. Tra gli attori, i “Singing Voices”, un coro di giovani tra cui alcuni non udenti che hanno augurato a tutti un caloroso “Feliz Navidad” con il canto e i gesti. David Watzl ha presentato “L’Aktion Weitblick” (Azione Lungimiranza), un aiuto umanitario per i rifugiati in Europa e per quelli rimasti nelle frontiere. Egli stesso ha trascorso due settimane in un campo profughi in Turchia dove, con un gruppo di volontari di Aktion Weitblick, ha organizzato dei pomeriggi di giochi per bambini, incontri sulla formazione sanitaria e tanto altro. Il gruppo di danza siriano “Ishtar” ha concluso il concerto di beneficenza coinvolgendo l’intera sala con il ritmo di una vivace musica orientale. Durante il buffet, protagonisti, visitatori e rifugiati si sono incontrati, ed è stata l’occasione per conoscersi ed approfondire di più i progetti sostenuti da ciascuno. Così, una serata di solidarietà ha trovato la sua conclusione in una calda atmosfera di fratellanza. A cura dei Giovani per un Mondo Unito di Vienna (Austria) (altro…)
Una serata ricca di varietà: dalla musica classica e pop balletto, contemplativo e groovy, musicale e buffet condiviso. Come nelle precedenti occasioni, il concerto di beneficenza è stato un progetto realizzato da Giovani per un Mondo Unito di Vienna e dalla gioventù di Mor Efrem della comunità siro-ortodossa. Circa 200 persone sono arrivate nonostante la gelida notte di dicembre e dando generosamente il loro sostegno ai rifugiati siriani. Tra gli attori, i “Singing Voices”, un coro di giovani tra cui alcuni non udenti che hanno augurato a tutti un caloroso “Feliz Navidad” con il canto e i gesti. David Watzl ha presentato “L’Aktion Weitblick” (Azione Lungimiranza), un aiuto umanitario per i rifugiati in Europa e per quelli rimasti nelle frontiere. Egli stesso ha trascorso due settimane in un campo profughi in Turchia dove, con un gruppo di volontari di Aktion Weitblick, ha organizzato dei pomeriggi di giochi per bambini, incontri sulla formazione sanitaria e tanto altro. Il gruppo di danza siriano “Ishtar” ha concluso il concerto di beneficenza coinvolgendo l’intera sala con il ritmo di una vivace musica orientale. Durante il buffet, protagonisti, visitatori e rifugiati si sono incontrati, ed è stata l’occasione per conoscersi ed approfondire di più i progetti sostenuti da ciascuno. Così, una serata di solidarietà ha trovato la sua conclusione in una calda atmosfera di fratellanza. A cura dei Giovani per un Mondo Unito di Vienna (Austria) (altro…)

 In questo Natale, Signore, ti raccomandiamo i “lontani”: i molti che erano “vicini” ed ora non lo sono più perché i mali, i troppi mali del mondo, li hanno allontanati da Te; quelli che non ti conoscono, ma ti cercano con cuore puro e sincero, e che non sanno ancora che un giorno, un soavissimo giorno, Tu sei apparso bambino sulla terra. In questo Natale, Signore, ti raccomandiamo soprattutto coloro che sono senza una fede. Te li raccomandiamo perché, sullo sfondo della loro non rara buona volontà, faccia breccia un raggio della tua luce, sfolgori per un attimo la stella che guida a te e possano sperimentare, almeno per qualche momento, quanto piena è la gioia di chi ti riconosce e ti ama. Ti raccomandiamo i “lontani”, Signore, perché sappiamo che è soprattutto per essi che un giorno ti sei fatto bambino. Chiara Lubich, E torna Natale …, Ed. Città Nuova, Roma 2007, XI edizione, pag 59-60. (altro…)
In questo Natale, Signore, ti raccomandiamo i “lontani”: i molti che erano “vicini” ed ora non lo sono più perché i mali, i troppi mali del mondo, li hanno allontanati da Te; quelli che non ti conoscono, ma ti cercano con cuore puro e sincero, e che non sanno ancora che un giorno, un soavissimo giorno, Tu sei apparso bambino sulla terra. In questo Natale, Signore, ti raccomandiamo soprattutto coloro che sono senza una fede. Te li raccomandiamo perché, sullo sfondo della loro non rara buona volontà, faccia breccia un raggio della tua luce, sfolgori per un attimo la stella che guida a te e possano sperimentare, almeno per qualche momento, quanto piena è la gioia di chi ti riconosce e ti ama. Ti raccomandiamo i “lontani”, Signore, perché sappiamo che è soprattutto per essi che un giorno ti sei fatto bambino. Chiara Lubich, E torna Natale …, Ed. Città Nuova, Roma 2007, XI edizione, pag 59-60. (altro…)

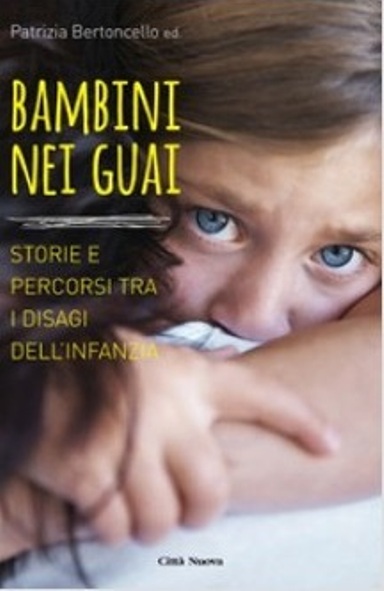 “Una lunga esperienza di maestra di scuola primaria – esordisce Patrizia Bertoncello, la curatrice del volume “Bambini nei guai” (1) – mi ha ben presto portato ad intercettare quei tipici segnali di disagio che nelle periferie sono più presenti che altrove. Spesso sono stati gli stessi alunni a raccontarli: “C’era una volta un fiore – scrive in classe Cristina, 7 anni –, il suo papà-fiore se ne era andato e anche la mamma-fiore non era con lui, perché aveva tanto da fare ed era molto preoccupata. Non aveva tempo di ascoltarlo. Il fiore era una rosa con mille spine. Le spine erano tantissime e pungevano. Il fiore voleva fare amicizia con gli animaletti del bosco o con gli altri fiori. Ma quando si avvicinavano si pungevano forte e scappavano a gambe levate, perché lui pungeva troppo. E non poteva farci niente. Alla fine il fiore, che era una rosa, era sempre da solo e molto triste”. (2) E’ la lucida spiegazione data da lei stessa di quei ripetuti dispetti in classe che la allontanavano da tutti. Come lei, con differenti problematiche, sono tanti i bambini nel disagio, seppur in questo nostro mondo che a molti appare ben vivibile e protettivo, ma che non è scevro di contraddizioni e ambivalenze a carico dei più deboli. A volte quelle istituzioni, che a parole si schierano in favore dei diritti dell’infanzia, nei fatti poco li tengono in considerazione. Specialmente quelli dei bambini che non possono contare su genitori efficaci o su legami famigliari duraturi, lasciandoli così in una specie di zona d’ombra, nell’instabilità affettiva e spesso anche in una lacerante povertà. La mancanza di protezione e di reali opportunità di crescita, non sono certo condizioni degne di una società come la nostra. Per questo, molte volte mi sono chiesta come dare voce a questi “bambini invisibili”, come contribuire alla costruzione di una cultura di tutela e pieno rispetto dell’infanzia. Ho iniziato cerca
“Una lunga esperienza di maestra di scuola primaria – esordisce Patrizia Bertoncello, la curatrice del volume “Bambini nei guai” (1) – mi ha ben presto portato ad intercettare quei tipici segnali di disagio che nelle periferie sono più presenti che altrove. Spesso sono stati gli stessi alunni a raccontarli: “C’era una volta un fiore – scrive in classe Cristina, 7 anni –, il suo papà-fiore se ne era andato e anche la mamma-fiore non era con lui, perché aveva tanto da fare ed era molto preoccupata. Non aveva tempo di ascoltarlo. Il fiore era una rosa con mille spine. Le spine erano tantissime e pungevano. Il fiore voleva fare amicizia con gli animaletti del bosco o con gli altri fiori. Ma quando si avvicinavano si pungevano forte e scappavano a gambe levate, perché lui pungeva troppo. E non poteva farci niente. Alla fine il fiore, che era una rosa, era sempre da solo e molto triste”. (2) E’ la lucida spiegazione data da lei stessa di quei ripetuti dispetti in classe che la allontanavano da tutti. Come lei, con differenti problematiche, sono tanti i bambini nel disagio, seppur in questo nostro mondo che a molti appare ben vivibile e protettivo, ma che non è scevro di contraddizioni e ambivalenze a carico dei più deboli. A volte quelle istituzioni, che a parole si schierano in favore dei diritti dell’infanzia, nei fatti poco li tengono in considerazione. Specialmente quelli dei bambini che non possono contare su genitori efficaci o su legami famigliari duraturi, lasciandoli così in una specie di zona d’ombra, nell’instabilità affettiva e spesso anche in una lacerante povertà. La mancanza di protezione e di reali opportunità di crescita, non sono certo condizioni degne di una società come la nostra. Per questo, molte volte mi sono chiesta come dare voce a questi “bambini invisibili”, come contribuire alla costruzione di una cultura di tutela e pieno rispetto dell’infanzia. Ho iniziato cerca ndo di accogliere ognuno dei miei alunni con amore, e pian piano vedevo che le loro lacrime si asciugavano. Mi sono resa conto che per “incontrare” davvero il mondo dei piccoli occorre avvicinare ogni singolo bambino con attenzione, imparando a guardare le cose con il loro sguardo, mettendo in campo ogni energia e competenza per creare relazioni significative. Con altri operatori e professionisti, animati dal medesimo stile educativo, ho poi cercato di attivare processi nei quali i bambini e le loro famiglie facciano l’esperienza di rapporti realmente educativi. Da questa sinergia è nata l’idea di un libro che narrasse non solo storie di “bambini invisibili”, ma anche buone prassi e percorsi di riscatto. “Bambini nei Guai”, scritto a 4 mani con un oncologo, un assistente sociale e un pediatra, vuole mettere in luce quei germi di speranza e di relazionalità positiva che diventano, in qualche misura, attivatori di resilienza. Quella risorsa cioè che tanti bambini, opportunamente aiutati, riescono a mettere in atto raggiungendo buoni livelli di recupero. Come avvenuto in Emma. Quando aveva 8 anni, travolta dallo sfasciarsi famigliare aveva persino tentato di togliersi la vita. Recentemente, dopo avermi rintracciata su Facebook mi scrive: “Cara maestra, che nostalgia ho di te e dei tanti momenti insieme! Ti ricordi quando leggevi le storie facendo le voci dei personaggi? E la gita al mare? Certo, quello che non si cancellerà mai dal mio cuore è il bene che mi hai voluto quando per me tutto era buio. Quando sono stata in ospedale dopo il fattaccio tu c’eri e non mi hai chiesto perché l’avevo fatto, c’eri e basta. Poi sono tornata a scuola con quelle ferite e tu hai fatto fare a tutti quei braccialetti coi fili colorati… ma io avevo capito che era per aiutarmi a nascondere le cicatrici che non volevo mostrare…”(3) Nelle presentazioni del libro presso università e convegni, sorprende l’attivarsi di attenzione e di presa in carico da parte delle persone, che iniziano ad accorgersi di quel bambino della porta accanto o di quello che chiede l’elemosina nel metrò o è in una corsia di ospedale. Bambini prima erano invisibili ed ora possono tornare ad essere protagonisti del proprio futuro”. Raccolto da Anna Friso 1) – 2) – 3) – Patrizia Bertoncello – Bambini nei guai – Città Nuova 2015, pag. 11 e pag. 66 (altro…)
ndo di accogliere ognuno dei miei alunni con amore, e pian piano vedevo che le loro lacrime si asciugavano. Mi sono resa conto che per “incontrare” davvero il mondo dei piccoli occorre avvicinare ogni singolo bambino con attenzione, imparando a guardare le cose con il loro sguardo, mettendo in campo ogni energia e competenza per creare relazioni significative. Con altri operatori e professionisti, animati dal medesimo stile educativo, ho poi cercato di attivare processi nei quali i bambini e le loro famiglie facciano l’esperienza di rapporti realmente educativi. Da questa sinergia è nata l’idea di un libro che narrasse non solo storie di “bambini invisibili”, ma anche buone prassi e percorsi di riscatto. “Bambini nei Guai”, scritto a 4 mani con un oncologo, un assistente sociale e un pediatra, vuole mettere in luce quei germi di speranza e di relazionalità positiva che diventano, in qualche misura, attivatori di resilienza. Quella risorsa cioè che tanti bambini, opportunamente aiutati, riescono a mettere in atto raggiungendo buoni livelli di recupero. Come avvenuto in Emma. Quando aveva 8 anni, travolta dallo sfasciarsi famigliare aveva persino tentato di togliersi la vita. Recentemente, dopo avermi rintracciata su Facebook mi scrive: “Cara maestra, che nostalgia ho di te e dei tanti momenti insieme! Ti ricordi quando leggevi le storie facendo le voci dei personaggi? E la gita al mare? Certo, quello che non si cancellerà mai dal mio cuore è il bene che mi hai voluto quando per me tutto era buio. Quando sono stata in ospedale dopo il fattaccio tu c’eri e non mi hai chiesto perché l’avevo fatto, c’eri e basta. Poi sono tornata a scuola con quelle ferite e tu hai fatto fare a tutti quei braccialetti coi fili colorati… ma io avevo capito che era per aiutarmi a nascondere le cicatrici che non volevo mostrare…”(3) Nelle presentazioni del libro presso università e convegni, sorprende l’attivarsi di attenzione e di presa in carico da parte delle persone, che iniziano ad accorgersi di quel bambino della porta accanto o di quello che chiede l’elemosina nel metrò o è in una corsia di ospedale. Bambini prima erano invisibili ed ora possono tornare ad essere protagonisti del proprio futuro”. Raccolto da Anna Friso 1) – 2) – 3) – Patrizia Bertoncello – Bambini nei guai – Città Nuova 2015, pag. 11 e pag. 66 (altro…)