


La speranza a Erbil, nel Kurdistan iracheno
 «Abito a Erbil, nel nord dell’Iraq, dove, nel 2010, ho iniziato una scuola per i bambini kurdi – racconta Malu Villafane, nata nelle Filippine –. In questi anni, ho lavorato nel santuario locale, organizzando varie attività. Nell’agosto scorso, il santuario è diventato un campo profughi. Le città di Sinjar e Mosul con i villaggi adiacenti, come Qaraqosh, Qaramlesh, Bartalla e altri, sono stati invasi dall’ISIS. Gli abitanti sono scappati lasciando tutto e si sono rifugiati in Kurdistan, da noi. Nel campo c’era un’aria pesantissima, di grande pessimismo, i bambini erano smarriti… Insieme ai responsabili del centro abbiamo iniziato alcune attività per i ragazzi, coinvolgendo anche alcuni colleghi della mia scuola». In questi anni com’è stata la convivenza tra i cristiani, musulmani, gli Yazidi e le altre etnie come kurdi, turkmeni, ecc.? «C’era rispetto tra loro, facevano le cose insieme. Lavoro con i kurdi, con i turkmeni, arabi e altri stranieri. Quando c’è stata la crisi, tanti kurdi hanno dato la loro disponibilità per ospitare i profughi in casa loro. Il popolo del Kurdistan non condivide questo massacro». Quando è iniziata la crisi dei profughi a Erbil? Dove si sono sistemati? Quali prospettive possono avere per i prossimi mesi? «La crisi che ha causato queste forzate migrazioni è iniziata già da giugno del 2014 e si è aggravata agli inizi di agosto. La gente ha perso tutto: casa, lavoro, scuola ; tanti di loro si sono rifugiati inizialmente nei palazzi vuoti, nelle chiese, lungo la strada e quando hanno potuto, presso i parenti a Erbil. Molte ONG, insieme alla Chiesa, hanno dovuto affrontare l’emergenza senza nessuna preparazione. Avevano bisogno di tutto! Insieme abbiamo raccolto tante cose di prima necessità. In quel periodo la temperatura di giorno saliva quasi a 50°C, un inferno, e ora durante l’inverno fa tanto freddo. Le tende non bastano per accudire migliaia di famiglie. Ci sono campi che non hanno acqua e cibo per alcuni periodi di tempo. Eppure, dopo un po’ di mesi, i bambini hanno iniziato a sorridere, a giocare, a provare altre esperienze fuori dal campo, come andare in piscina o nel parco pubblico. I genitori, vedendo la gioia dei loro figli, hanno ritrovato la speranza. Hanno iniziato a pulire il campo, a cucinare e a darci una mano. Dopo aver vissuto con loro questa drammatica situazione, la mia vita si è capovolta. Il mio soggiorno qui in Iraq ha trovato un senso profondo: ho vissuto per la fratellanza universale». Ma ha senso lavorare per la fraternità? Cosa ti spinge a continuare a lavorare nel campo? «Se guardo alle circostanze dal punto di vista umano, mi scoraggio e scapperei via. Invece, se guardo tutto quello che accade attraverso l’occhio di una speranza fondata sulla fede, riesco ad andare al di là delle sofferenze che vedo. Ho pensato alla frase del Vangelo: “Quando ho avuto fame, mi hai dato da mangiare; quando ero triste mi hai consolato…”. Queste parole mi danno la forza di affrontare le difficoltà quotidiane che incontro nel campo. È difficile spiegare o descrivere il dolore che c’è. Tanti di loro hanno perso la speranza perché hanno perso tutto. Questa esperienza mi ha spalancato il cuore per accogliere l’altro come un fratello, come una sorella. Mi ha dato la possibilità di uscire dal mio mondo “comodo” per mettermi a servizio degli altri. Voglio vivere per la fratellanza universale non perché posso risolvere i problemi ma perché, con piccoli passi, si può lasciare un seme. La pace cresce soprattutto dalle piccole cose che facciamo tutti i giorni per gli altri». Cosa possiamo fare noi da qui per aiutarvi e per essere vicini a queste persone? «Credo che bisogna affrontare il tema della “disinformazione”. Nonostante l’emergenza sia tuttora in corso, quasi non se ne parla. Diffondere una cultura che accoglie, che ascolta, soprattutto fra popoli e religioni diverse nelle vostre città; promuovere iniziative e progetti che abbattono le barriere. Vi ringrazio per il vostro aiuto e continuiamo a credere che la Pace è possibile». Fonte: Umanità Nuova online (altro…)
«Abito a Erbil, nel nord dell’Iraq, dove, nel 2010, ho iniziato una scuola per i bambini kurdi – racconta Malu Villafane, nata nelle Filippine –. In questi anni, ho lavorato nel santuario locale, organizzando varie attività. Nell’agosto scorso, il santuario è diventato un campo profughi. Le città di Sinjar e Mosul con i villaggi adiacenti, come Qaraqosh, Qaramlesh, Bartalla e altri, sono stati invasi dall’ISIS. Gli abitanti sono scappati lasciando tutto e si sono rifugiati in Kurdistan, da noi. Nel campo c’era un’aria pesantissima, di grande pessimismo, i bambini erano smarriti… Insieme ai responsabili del centro abbiamo iniziato alcune attività per i ragazzi, coinvolgendo anche alcuni colleghi della mia scuola». In questi anni com’è stata la convivenza tra i cristiani, musulmani, gli Yazidi e le altre etnie come kurdi, turkmeni, ecc.? «C’era rispetto tra loro, facevano le cose insieme. Lavoro con i kurdi, con i turkmeni, arabi e altri stranieri. Quando c’è stata la crisi, tanti kurdi hanno dato la loro disponibilità per ospitare i profughi in casa loro. Il popolo del Kurdistan non condivide questo massacro». Quando è iniziata la crisi dei profughi a Erbil? Dove si sono sistemati? Quali prospettive possono avere per i prossimi mesi? «La crisi che ha causato queste forzate migrazioni è iniziata già da giugno del 2014 e si è aggravata agli inizi di agosto. La gente ha perso tutto: casa, lavoro, scuola ; tanti di loro si sono rifugiati inizialmente nei palazzi vuoti, nelle chiese, lungo la strada e quando hanno potuto, presso i parenti a Erbil. Molte ONG, insieme alla Chiesa, hanno dovuto affrontare l’emergenza senza nessuna preparazione. Avevano bisogno di tutto! Insieme abbiamo raccolto tante cose di prima necessità. In quel periodo la temperatura di giorno saliva quasi a 50°C, un inferno, e ora durante l’inverno fa tanto freddo. Le tende non bastano per accudire migliaia di famiglie. Ci sono campi che non hanno acqua e cibo per alcuni periodi di tempo. Eppure, dopo un po’ di mesi, i bambini hanno iniziato a sorridere, a giocare, a provare altre esperienze fuori dal campo, come andare in piscina o nel parco pubblico. I genitori, vedendo la gioia dei loro figli, hanno ritrovato la speranza. Hanno iniziato a pulire il campo, a cucinare e a darci una mano. Dopo aver vissuto con loro questa drammatica situazione, la mia vita si è capovolta. Il mio soggiorno qui in Iraq ha trovato un senso profondo: ho vissuto per la fratellanza universale». Ma ha senso lavorare per la fraternità? Cosa ti spinge a continuare a lavorare nel campo? «Se guardo alle circostanze dal punto di vista umano, mi scoraggio e scapperei via. Invece, se guardo tutto quello che accade attraverso l’occhio di una speranza fondata sulla fede, riesco ad andare al di là delle sofferenze che vedo. Ho pensato alla frase del Vangelo: “Quando ho avuto fame, mi hai dato da mangiare; quando ero triste mi hai consolato…”. Queste parole mi danno la forza di affrontare le difficoltà quotidiane che incontro nel campo. È difficile spiegare o descrivere il dolore che c’è. Tanti di loro hanno perso la speranza perché hanno perso tutto. Questa esperienza mi ha spalancato il cuore per accogliere l’altro come un fratello, come una sorella. Mi ha dato la possibilità di uscire dal mio mondo “comodo” per mettermi a servizio degli altri. Voglio vivere per la fratellanza universale non perché posso risolvere i problemi ma perché, con piccoli passi, si può lasciare un seme. La pace cresce soprattutto dalle piccole cose che facciamo tutti i giorni per gli altri». Cosa possiamo fare noi da qui per aiutarvi e per essere vicini a queste persone? «Credo che bisogna affrontare il tema della “disinformazione”. Nonostante l’emergenza sia tuttora in corso, quasi non se ne parla. Diffondere una cultura che accoglie, che ascolta, soprattutto fra popoli e religioni diverse nelle vostre città; promuovere iniziative e progetti che abbattono le barriere. Vi ringrazio per il vostro aiuto e continuiamo a credere che la Pace è possibile». Fonte: Umanità Nuova online (altro…)

Medio Oriente: la forza dell’amore contro il terrorismo

Lara Abou Moussa e George Zahm

Dal Marocco: diario di viaggio
 La cosiddetta “Regola d’oro” che il Vangelo propone, “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” (Mt 7,12), è presente anche nell’Islam e nelle altre religioni, e quando viene messa alla base di ogni rapporto, genera – come è successo in queste terre – quell’amore che suscita un fecondo “dialogo della vita” con ogni persona che si incontra. Un dialogo intessuto di piccoli gesti, di attenzione all’altro, di rispetto, di ascolto. È stato quest’amore concreto al fratello che ha contributo alla formazione di alcune comunità dei Focolari in Marocco, nella quale l’amore e il rispetto prevalgono sulle differenze di cultura, tradizioni e religione. Di seguito, alcuni stralci del Journal de bord (diario di viaggio), scritto da due focolarini in visita a queste comunità, tra la fine di gennaio inizio febbraio 2015. «Ci troviamo a Fez, città imperiale molto fiera della sua tradizione altamente spirituale. Numerosi studenti provenienti dall’Africa sub sahariana vengono per fare gli studi superiori. Frequentano volentieri la parrocchia francofona ed il parroco, don Matteo, ci ha chiesto di fare la catechesi sui sacramenti ad una ventina di giovani; un’occasione per vivere insieme uno scambio profondo e gradevole. Il gruppo della Parola di vita della parrocchia ha riunito una trentina di studenti di medicina, chimica, informatica, più altri cinque arrivati da Rabat.A cena siamo dalle piccole sorelle di Foucauld. Lucile racconta come cerca di vivere la Parola nell’ospedale pubblico dove lavora.
La cosiddetta “Regola d’oro” che il Vangelo propone, “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” (Mt 7,12), è presente anche nell’Islam e nelle altre religioni, e quando viene messa alla base di ogni rapporto, genera – come è successo in queste terre – quell’amore che suscita un fecondo “dialogo della vita” con ogni persona che si incontra. Un dialogo intessuto di piccoli gesti, di attenzione all’altro, di rispetto, di ascolto. È stato quest’amore concreto al fratello che ha contributo alla formazione di alcune comunità dei Focolari in Marocco, nella quale l’amore e il rispetto prevalgono sulle differenze di cultura, tradizioni e religione. Di seguito, alcuni stralci del Journal de bord (diario di viaggio), scritto da due focolarini in visita a queste comunità, tra la fine di gennaio inizio febbraio 2015. «Ci troviamo a Fez, città imperiale molto fiera della sua tradizione altamente spirituale. Numerosi studenti provenienti dall’Africa sub sahariana vengono per fare gli studi superiori. Frequentano volentieri la parrocchia francofona ed il parroco, don Matteo, ci ha chiesto di fare la catechesi sui sacramenti ad una ventina di giovani; un’occasione per vivere insieme uno scambio profondo e gradevole. Il gruppo della Parola di vita della parrocchia ha riunito una trentina di studenti di medicina, chimica, informatica, più altri cinque arrivati da Rabat.A cena siamo dalle piccole sorelle di Foucauld. Lucile racconta come cerca di vivere la Parola nell’ospedale pubblico dove lavora.  Arriviamo a Tangeri per trovare una quindicina di persone, musulmani e cristiani, che vivono la spiritualità dell’unità. Alla sera ci fermiamo con una coppia che ci considera come fratelli di sangue. Lui è stato trasferito per lavoro a 24 ore di strada, ma questo allontanamento dalla moglie è diventato un’occasione per riscoprire il positivo dell’uno e dell’altra. Colazione da Mohamed. Sua moglie desidera approfondire la spiritualità dell’unità. Ci racconta che il custode del palazzo dove lavora non le rivolgeva il saluto da quando si era rifiutata di portargli l’olio della padrona di casa spagnola, approfittando della sua assenza, come lui pretendeva. Quando poi ha ricevuto un litro d’olio dalla mamma, l’ha offerto al custode, spiegando che questa volta era suo, perciò poteva disporne come meglio credeva. L’uomo, un po’ spiazzato, l’ha ringraziata, scusandosi. La riconciliazione è stata fatta. Un bel pomeriggio con il gruppo delle famiglie della comunità: Ahmed ci invita a restare da lui. Trascorriamo la serata con la sua famiglia. Per cena ci offrono un piatto tipico.
Arriviamo a Tangeri per trovare una quindicina di persone, musulmani e cristiani, che vivono la spiritualità dell’unità. Alla sera ci fermiamo con una coppia che ci considera come fratelli di sangue. Lui è stato trasferito per lavoro a 24 ore di strada, ma questo allontanamento dalla moglie è diventato un’occasione per riscoprire il positivo dell’uno e dell’altra. Colazione da Mohamed. Sua moglie desidera approfondire la spiritualità dell’unità. Ci racconta che il custode del palazzo dove lavora non le rivolgeva il saluto da quando si era rifiutata di portargli l’olio della padrona di casa spagnola, approfittando della sua assenza, come lui pretendeva. Quando poi ha ricevuto un litro d’olio dalla mamma, l’ha offerto al custode, spiegando che questa volta era suo, perciò poteva disporne come meglio credeva. L’uomo, un po’ spiazzato, l’ha ringraziata, scusandosi. La riconciliazione è stata fatta. Un bel pomeriggio con il gruppo delle famiglie della comunità: Ahmed ci invita a restare da lui. Trascorriamo la serata con la sua famiglia. Per cena ci offrono un piatto tipico.  Visita alla piccola scuola di periferia fondata da Fawzia. Il quartiere è pieno di bambini che giocano sulla strade fangose e caotiche. Le case sorgono dappertutto come funghi. Felice, ci racconta che due bambini hanno chiesto di iscriversi da lei, nonostante da tempo un vicino si fosse messo all’entrata della sua scuola per convincere i genitori a iscrivere i bambini da un’altra parte. Fawzia, dopo aver chiesto spiegazioni, ha continuato ad amare e a fare bene il suo lavoro con ottimi risultati nel rendimento scolastico. Sei giorni dopo, grazie alla buona fama che la scuola si è guadagnata nel quartiere, ecco altre tre nuove iscrizioni! Viaggio a Casablanca a trovare Susana e alla sera con Mohammed e Nadedj ad un ristorante giapponese. Parliamo di Loppiano, della recente Mariapoli in Algeria, degli incontri avuti in questi giorni. Domani si rientra, in Algeria e Italia rispettivamente, con la gioia di aver costruito e rinforzato tanti rapporti di unità, arricchiti dall’incontro con questa gente impegnata a vivere, nel loro quotidiano, per un mondo più unito». Claude e Ivano (Marocco, Gennaio/Febbraio 2015) (altro…)
Visita alla piccola scuola di periferia fondata da Fawzia. Il quartiere è pieno di bambini che giocano sulla strade fangose e caotiche. Le case sorgono dappertutto come funghi. Felice, ci racconta che due bambini hanno chiesto di iscriversi da lei, nonostante da tempo un vicino si fosse messo all’entrata della sua scuola per convincere i genitori a iscrivere i bambini da un’altra parte. Fawzia, dopo aver chiesto spiegazioni, ha continuato ad amare e a fare bene il suo lavoro con ottimi risultati nel rendimento scolastico. Sei giorni dopo, grazie alla buona fama che la scuola si è guadagnata nel quartiere, ecco altre tre nuove iscrizioni! Viaggio a Casablanca a trovare Susana e alla sera con Mohammed e Nadedj ad un ristorante giapponese. Parliamo di Loppiano, della recente Mariapoli in Algeria, degli incontri avuti in questi giorni. Domani si rientra, in Algeria e Italia rispettivamente, con la gioia di aver costruito e rinforzato tanti rapporti di unità, arricchiti dall’incontro con questa gente impegnata a vivere, nel loro quotidiano, per un mondo più unito». Claude e Ivano (Marocco, Gennaio/Febbraio 2015) (altro…)

Filippine: la profezia della S.O.R.
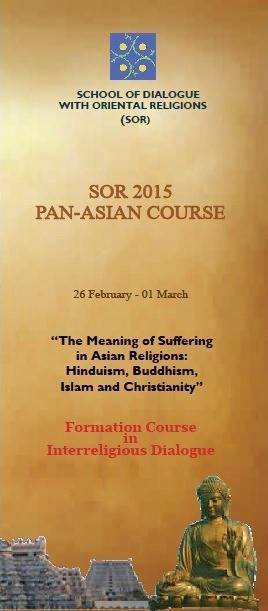 SOR sta per School for Oriental Religions (Scuola per le religioni orientali). «È stata una delle idee tipiche della genialità del carisma di Chiara Lubich» scrive Roberto Catalano, co-responsabile del Centro per il Dialogo Interreligioso del Movimento dei Focolari, nel suo blog. Giunta quasi al termine del suo primo viaggio in Asia nel gennaio del 1982, la fondatrice dei Focolari lanciò un’idea che pareva un sogno. Si trattava di avviare, nella cittadella delle Filippine, Tagaytay, punto di riferimento per i Focolari in Asia, corsi di formazione che permettessero ai cattolici di aprirsi, adeguatamente preparati, al dialogo con fedeli di altre religioni. Chiara Lubich arrivava dal Giappone dove aveva avuto l’occasione, su invito del rev. Nikkyo Niwano, fondatore della Rissho Kosei-kai, movimento di rinnovamento buddhista giapponese, di parlare della sua esperienza cristiana a migliaia di buddhisti. L’impatto era stato forte non solo nei buddhisti che ascoltavano una donna cattolica parlare nell’Aula Sacra di fronte alla grande statua del Buddha, ma per Chiara stessa. All’arrivo nelle Filippine, nazione cristiana dell’Asia, aveva intuito la necessità di lanciare il Movimento dei Focolari, particolarmente quello di quel continente, a dialogare con buddhisti, musulmani e indù. Ma aveva colto anche la necessità di prepararsi adeguatamente per un compito impegnativo che non doveva andare a scapito delle identità religiose di ciascuno. Dopo aver confidato il suo sogno ad alcuni dei dirigenti del Movimento, una persona aveva offerto una casa che poteva ospitare professori e piccoli corsi. È così che è nata la SOR che, nel corso di questi tre decenni, ha svolto week-end di formazione a cristiani dell’Asia su argomenti che riguardano le varie religioni. A partire dal 2009, poi, con il diffondersi di tensioni religiose e del fondamentalismo, si è pensato di affrontare temi specifici, trasversali: Dio nelle tradizioni asiatiche, il comandamento dell’amore, il ruolo delle Sacre Scritture e, quest’anno, il posto ed il significato della sofferenza.
SOR sta per School for Oriental Religions (Scuola per le religioni orientali). «È stata una delle idee tipiche della genialità del carisma di Chiara Lubich» scrive Roberto Catalano, co-responsabile del Centro per il Dialogo Interreligioso del Movimento dei Focolari, nel suo blog. Giunta quasi al termine del suo primo viaggio in Asia nel gennaio del 1982, la fondatrice dei Focolari lanciò un’idea che pareva un sogno. Si trattava di avviare, nella cittadella delle Filippine, Tagaytay, punto di riferimento per i Focolari in Asia, corsi di formazione che permettessero ai cattolici di aprirsi, adeguatamente preparati, al dialogo con fedeli di altre religioni. Chiara Lubich arrivava dal Giappone dove aveva avuto l’occasione, su invito del rev. Nikkyo Niwano, fondatore della Rissho Kosei-kai, movimento di rinnovamento buddhista giapponese, di parlare della sua esperienza cristiana a migliaia di buddhisti. L’impatto era stato forte non solo nei buddhisti che ascoltavano una donna cattolica parlare nell’Aula Sacra di fronte alla grande statua del Buddha, ma per Chiara stessa. All’arrivo nelle Filippine, nazione cristiana dell’Asia, aveva intuito la necessità di lanciare il Movimento dei Focolari, particolarmente quello di quel continente, a dialogare con buddhisti, musulmani e indù. Ma aveva colto anche la necessità di prepararsi adeguatamente per un compito impegnativo che non doveva andare a scapito delle identità religiose di ciascuno. Dopo aver confidato il suo sogno ad alcuni dei dirigenti del Movimento, una persona aveva offerto una casa che poteva ospitare professori e piccoli corsi. È così che è nata la SOR che, nel corso di questi tre decenni, ha svolto week-end di formazione a cristiani dell’Asia su argomenti che riguardano le varie religioni. A partire dal 2009, poi, con il diffondersi di tensioni religiose e del fondamentalismo, si è pensato di affrontare temi specifici, trasversali: Dio nelle tradizioni asiatiche, il comandamento dell’amore, il ruolo delle Sacre Scritture e, quest’anno, il posto ed il significato della sofferenza.  Dal 26 febbraio al 1° marzo la Cittadella Pace (Tagaytay) ha così ospitato circa 300 persone provenienti per la maggior parte dalle Filippine, ma con delegazioni anche da Pakistan, India, Myanmar, Thailandia, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Giappone e Corea. Sono quasi tutti cattolici, ma tre buddhisti membri attivi dei Focolari hanno voluto essere presenti, provenienti da Giappone e Thailandia. L’argomento: Il senso della sofferenza nelle religioni asiatiche: induismo, buddhismo, islam e cristianesimo. L’obiettivo: mettere in evidenza il valore e il significato che le rispettive tradizioni danno al dolore in generale, quello fisico, come quello spirituale e psichico o quello provocato dai disastri naturali. I relatori erano esperti dei vari settori, presenti anche tre vescovi (Roberto Mallari, di S. José Nueva Ecija nelle Filippine, Brenan Leahy, di Limerick in Irlanda, e Felix Anthony Machado di Vasai in India) e un professore americano esperto di buddhismo (Donald Mitchell della Purdue University) collegato via skype. La scuola ha, poi, offerto l’occasione di condividere esperienze di dialogo in Paesi dove i cristiani sono una sparuta minoranza, come India, Thailandia, Giappone, Taiwan. «Sono venuti per imparare a dialogare con le altre religioni, ma quello che hanno riscoperto è stato il cristianesimo nella sua dimensione più profonda e, allo stesso tempo, aperto a tutti coloro che si incontrano a qualsiasi credo appartengano» conclude Catalano. Chiara ha capito la necessità di formare cristiani al dialogo in un continente che vive in un caleidoscopio di fedi. Un dialogo che non relativizza né appiattisce, dove ognuno deve essere se stesso ed incontrando l’altro riscoprire le sue radici. (altro…)
Dal 26 febbraio al 1° marzo la Cittadella Pace (Tagaytay) ha così ospitato circa 300 persone provenienti per la maggior parte dalle Filippine, ma con delegazioni anche da Pakistan, India, Myanmar, Thailandia, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Giappone e Corea. Sono quasi tutti cattolici, ma tre buddhisti membri attivi dei Focolari hanno voluto essere presenti, provenienti da Giappone e Thailandia. L’argomento: Il senso della sofferenza nelle religioni asiatiche: induismo, buddhismo, islam e cristianesimo. L’obiettivo: mettere in evidenza il valore e il significato che le rispettive tradizioni danno al dolore in generale, quello fisico, come quello spirituale e psichico o quello provocato dai disastri naturali. I relatori erano esperti dei vari settori, presenti anche tre vescovi (Roberto Mallari, di S. José Nueva Ecija nelle Filippine, Brenan Leahy, di Limerick in Irlanda, e Felix Anthony Machado di Vasai in India) e un professore americano esperto di buddhismo (Donald Mitchell della Purdue University) collegato via skype. La scuola ha, poi, offerto l’occasione di condividere esperienze di dialogo in Paesi dove i cristiani sono una sparuta minoranza, come India, Thailandia, Giappone, Taiwan. «Sono venuti per imparare a dialogare con le altre religioni, ma quello che hanno riscoperto è stato il cristianesimo nella sua dimensione più profonda e, allo stesso tempo, aperto a tutti coloro che si incontrano a qualsiasi credo appartengano» conclude Catalano. Chiara ha capito la necessità di formare cristiani al dialogo in un continente che vive in un caleidoscopio di fedi. Un dialogo che non relativizza né appiattisce, dove ognuno deve essere se stesso ed incontrando l’altro riscoprire le sue radici. (altro…)

Studentesse sciite iraniane a Loppiano
 «In tempi di odio e paura ringrazio Dio perché ci ha scelte per farci conoscere una spiritualità come quella di Chiara Lubich, capace di far gustare all’umanità la pace e la vera gioia dell’unità. Qui a Loppiano stiamo sperimentando un anticipo di come sarà la vita nel regno di Dio». Sono le parole di una delle sei studentesse musulmane iraniane che stanno trascorrendo un mese a Loppiano, partecipando alla vita della cittadella 24 ore su 24. «Un’esperienza nuova per tutti noi – afferma Rita Moussallem, co-responsabile, con Roberto Catalano, del Centro del Dialogo Interreligioso dei Focolari – un segno profetico portatore di speranza che ci dice che è l’amore che vince». Le studentesse provengono dal seminario femminile Jami’at al-Zahra della città di Qum (Iran), a circa 200 Km dalla capitale, Teheran. Si tratta di un centro accademico d’eccellenza per l’Islam sciita ed è il più grande al mondo con circa 6.000 studentesse, un migliaio delle quali proveniente da altri paesi. Per la presenza di importanti santuari, Qum è una delle città sante sciite, meta di decine di migliaia di pellegrini ogni anno e sede di numerose università; si calcola la presenza di circa 100.000 studenti. Questa visita fa seguito al rapporto fraterno e di dialogo iniziato da diversi anni fra il Centro del Dialogo Interreligioso dei Focolari e il dr. Mohammad Ali Shomali, docente presso la sezione internazionale del seminario femminile di Qum e fondatore e direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Islamici (sempre a Qum), nonché membro di consigli di varie istituzioni accademiche. Attualmente risiede a Londra ed è alla guida del Centro Islamico della Gran Bretagna. «Nell’aprile scorso con alcuni focolarini siamo andati a Qum, dietro invito del dr. Shomali – spiega Roberto Catalano – per visitare diversi istituti universitari e approfondire la conoscenza reciproca. È stata in quell’occasione che ha iniziato a concretizzarsi la possibilità per un gruppo di studentesse di fare esperienza della spiritualità dell’unità». A Loppiano, il dr. Shomali insieme alla moglie e alle studentesse hanno visitato le diverse Scuole e ambienti di lavoro, conosciuto i suoi abitanti con le loro esperienze e quindi si sono immersi nella vita e nelle attività della cittadella. Rilevante il momento d’incontro del dr. Shomali con i docenti e gli studenti dell’Istituto Universitario Sophia. Facendo riferimento al termine che dà nome all’Istituto, ha sottolineato come il concetto di sapienza significhi molto più che conoscenza: «Possiamo ascoltare parole di conoscenza da tanti, ma la qualità della sapienza può venire solo da Dio». Ora per le studentesse l’esperienza continua, con l’approfondimento della spiritualità dell’unità e dei suoi aspetti concreti. (altro…)
«In tempi di odio e paura ringrazio Dio perché ci ha scelte per farci conoscere una spiritualità come quella di Chiara Lubich, capace di far gustare all’umanità la pace e la vera gioia dell’unità. Qui a Loppiano stiamo sperimentando un anticipo di come sarà la vita nel regno di Dio». Sono le parole di una delle sei studentesse musulmane iraniane che stanno trascorrendo un mese a Loppiano, partecipando alla vita della cittadella 24 ore su 24. «Un’esperienza nuova per tutti noi – afferma Rita Moussallem, co-responsabile, con Roberto Catalano, del Centro del Dialogo Interreligioso dei Focolari – un segno profetico portatore di speranza che ci dice che è l’amore che vince». Le studentesse provengono dal seminario femminile Jami’at al-Zahra della città di Qum (Iran), a circa 200 Km dalla capitale, Teheran. Si tratta di un centro accademico d’eccellenza per l’Islam sciita ed è il più grande al mondo con circa 6.000 studentesse, un migliaio delle quali proveniente da altri paesi. Per la presenza di importanti santuari, Qum è una delle città sante sciite, meta di decine di migliaia di pellegrini ogni anno e sede di numerose università; si calcola la presenza di circa 100.000 studenti. Questa visita fa seguito al rapporto fraterno e di dialogo iniziato da diversi anni fra il Centro del Dialogo Interreligioso dei Focolari e il dr. Mohammad Ali Shomali, docente presso la sezione internazionale del seminario femminile di Qum e fondatore e direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Islamici (sempre a Qum), nonché membro di consigli di varie istituzioni accademiche. Attualmente risiede a Londra ed è alla guida del Centro Islamico della Gran Bretagna. «Nell’aprile scorso con alcuni focolarini siamo andati a Qum, dietro invito del dr. Shomali – spiega Roberto Catalano – per visitare diversi istituti universitari e approfondire la conoscenza reciproca. È stata in quell’occasione che ha iniziato a concretizzarsi la possibilità per un gruppo di studentesse di fare esperienza della spiritualità dell’unità». A Loppiano, il dr. Shomali insieme alla moglie e alle studentesse hanno visitato le diverse Scuole e ambienti di lavoro, conosciuto i suoi abitanti con le loro esperienze e quindi si sono immersi nella vita e nelle attività della cittadella. Rilevante il momento d’incontro del dr. Shomali con i docenti e gli studenti dell’Istituto Universitario Sophia. Facendo riferimento al termine che dà nome all’Istituto, ha sottolineato come il concetto di sapienza significhi molto più che conoscenza: «Possiamo ascoltare parole di conoscenza da tanti, ma la qualità della sapienza può venire solo da Dio». Ora per le studentesse l’esperienza continua, con l’approfondimento della spiritualità dell’unità e dei suoi aspetti concreti. (altro…)
