
Apr 20, 2015 | Focolari nel Mondo, Senza categoria
 Uno sguardo vivo, un sorriso dolce che, velandosi di tristezza, permane anche quando racconta le tragiche vicende nel Paese diventato ora la sua patria di elezione. Ghada, cosa ti ha spinto a tornare in Siria? «A 20 anni ho lasciato famiglia e patria per seguire Dio. Nel settembre 2013, quando ho deciso di tornare in Siria, lo slancio era lo stesso, intatto. Non mi spaventava l’idea che avrei potuto anche morire. Di più mi attraeva l’andare a vivere accanto alle persone che anni prima avevo conosciuto e far sentire loro che non sono abbandonate. Mi ha spinto il desiderio di condividere la loro vita, le loro paure, la precarietà del loro quotidiano. Qui infatti le bombe fioccano quando meno te l’aspetti». Ma non c’è nessun preavviso ai bombardamenti per potersi proteggere in qualche modo? «Non ci sono sirene che annuncino i raid e neppure ci si può basare su una strategia che faccia supporre quando e dove i razzi colpiranno. D’altra parte è ormai il 5° anno di guerra e non si può restare barricati per sempre. Ci si può fermare un giorno, un mese ma poi, anche se tuonano i mortai, la vita deve continuare: i bambini vanno a scuola e i genitori a lavorare per mantenere la famiglia. Tutto va avanti, nella precarietà e nel rischio più assoluti. Avevo vissuto lo stesso dramma quando ero in focolare in Libano, ma qui è tutto più aggravato, tutto più difficile. Qui si respira terrore e violenza da ogni angolo».
Uno sguardo vivo, un sorriso dolce che, velandosi di tristezza, permane anche quando racconta le tragiche vicende nel Paese diventato ora la sua patria di elezione. Ghada, cosa ti ha spinto a tornare in Siria? «A 20 anni ho lasciato famiglia e patria per seguire Dio. Nel settembre 2013, quando ho deciso di tornare in Siria, lo slancio era lo stesso, intatto. Non mi spaventava l’idea che avrei potuto anche morire. Di più mi attraeva l’andare a vivere accanto alle persone che anni prima avevo conosciuto e far sentire loro che non sono abbandonate. Mi ha spinto il desiderio di condividere la loro vita, le loro paure, la precarietà del loro quotidiano. Qui infatti le bombe fioccano quando meno te l’aspetti». Ma non c’è nessun preavviso ai bombardamenti per potersi proteggere in qualche modo? «Non ci sono sirene che annuncino i raid e neppure ci si può basare su una strategia che faccia supporre quando e dove i razzi colpiranno. D’altra parte è ormai il 5° anno di guerra e non si può restare barricati per sempre. Ci si può fermare un giorno, un mese ma poi, anche se tuonano i mortai, la vita deve continuare: i bambini vanno a scuola e i genitori a lavorare per mantenere la famiglia. Tutto va avanti, nella precarietà e nel rischio più assoluti. Avevo vissuto lo stesso dramma quando ero in focolare in Libano, ma qui è tutto più aggravato, tutto più difficile. Qui si respira terrore e violenza da ogni angolo».  Tu eri già stata in Siria nel passato. Puoi dirci qualcosa del cambiamento che hai trovato? «Quando ero in focolare in Libano, mi recavo ad Aleppo, a Homs e anche a Damasco perché già allora tante persone desideravano mantenersi in contatto coi Focolari. Per la sensibilità e la profondità interiore del popolo siriano, era spontaneo stringere rapporti significativi. Si condividevano i valori cristiani, qui tanto sentiti. Pur nella pluralità di Chiese e riti diversi, tipica di questa terra, c’era e c’è ancora grande armonia tra tutti. Quando nel ’94 si è progettato il focolare ad Aleppo, sono stata mandata ad aprirlo con altre due focolarine. Ci sono rimasta per 9 anni. Per la Siria erano tempi di prosperità: il Paese non aveva debito pubblico e il PIL era in continua ascesa. Di sera anche noi ragazze potevamo uscire liberamente. Ora c’è la bufera. Ma il peggio è l’assenza della prospettiva che questa guerra possa cessare. Sono tornata per dire, con gli altri focolarini, che siamo in Siria, che non l’abbiamo dimenticata, che Gesù ci ha plasmati un’unica famiglia e per questo vogliamo correre gli stessi rischi. Anche noi infatti, come tutti, andiamo al lavoro, in chiesa, al mercato, senza sapere se torneremo a casa. Siamo lì per l’amore che ci lega e la comunità in Siria sa che siamo disposti anche a dare la vita per loro. Come lo sono anche loro per noi. Questa reciprocità è davvero eccezionale. Fanno a gara per farci stare bene, per condividere con noi tutto quello che hanno». Voi focolarine siete a Damasco, una città affascinante, ricca di arte, di storia, una famosa meta turistica. Come si vive lì, oggi? «In città, ma anche nei villaggi, ogni giorno si sfida la morte. I trasporti sono spesso in tilt per mancanza di gasolio e continui posti di blocco. Si sa quando si esce ma non si sa quando si arriverà. Nelle case l’elettricità manca per ore, come pure l’acqua. Si rischia l’esasperazione. Tanto che l’esodo – per chi può lasciare il Paese – è in continua ascesa. Si calcola che l’emigrazione, anch’essa non priva di rischi gravissimi, abbia superato i 6 milioni di persone. Ma la religiosità è sempre molto sentita. Alla Via Crucis del venerdì santo, pur consapevoli che le bombe potevano esplodere da un momento all’altro, i cristiani erano tutti alla processione, portando con sé anche i bambini. Recentemente i ragazzi che seguiamo hanno parlato via skype con un gruppo di coetanei portoghesi. Questi volevano organizzarsi per mandare aiuti e chiedevano di che cosa avessero più bisogno. E loro, pur avendo necessità di tante cose materiali, continuavano a ripetere: «Pregate per noi, pregate per la pace, pregate che si fermi questa spirale di odio».
Tu eri già stata in Siria nel passato. Puoi dirci qualcosa del cambiamento che hai trovato? «Quando ero in focolare in Libano, mi recavo ad Aleppo, a Homs e anche a Damasco perché già allora tante persone desideravano mantenersi in contatto coi Focolari. Per la sensibilità e la profondità interiore del popolo siriano, era spontaneo stringere rapporti significativi. Si condividevano i valori cristiani, qui tanto sentiti. Pur nella pluralità di Chiese e riti diversi, tipica di questa terra, c’era e c’è ancora grande armonia tra tutti. Quando nel ’94 si è progettato il focolare ad Aleppo, sono stata mandata ad aprirlo con altre due focolarine. Ci sono rimasta per 9 anni. Per la Siria erano tempi di prosperità: il Paese non aveva debito pubblico e il PIL era in continua ascesa. Di sera anche noi ragazze potevamo uscire liberamente. Ora c’è la bufera. Ma il peggio è l’assenza della prospettiva che questa guerra possa cessare. Sono tornata per dire, con gli altri focolarini, che siamo in Siria, che non l’abbiamo dimenticata, che Gesù ci ha plasmati un’unica famiglia e per questo vogliamo correre gli stessi rischi. Anche noi infatti, come tutti, andiamo al lavoro, in chiesa, al mercato, senza sapere se torneremo a casa. Siamo lì per l’amore che ci lega e la comunità in Siria sa che siamo disposti anche a dare la vita per loro. Come lo sono anche loro per noi. Questa reciprocità è davvero eccezionale. Fanno a gara per farci stare bene, per condividere con noi tutto quello che hanno». Voi focolarine siete a Damasco, una città affascinante, ricca di arte, di storia, una famosa meta turistica. Come si vive lì, oggi? «In città, ma anche nei villaggi, ogni giorno si sfida la morte. I trasporti sono spesso in tilt per mancanza di gasolio e continui posti di blocco. Si sa quando si esce ma non si sa quando si arriverà. Nelle case l’elettricità manca per ore, come pure l’acqua. Si rischia l’esasperazione. Tanto che l’esodo – per chi può lasciare il Paese – è in continua ascesa. Si calcola che l’emigrazione, anch’essa non priva di rischi gravissimi, abbia superato i 6 milioni di persone. Ma la religiosità è sempre molto sentita. Alla Via Crucis del venerdì santo, pur consapevoli che le bombe potevano esplodere da un momento all’altro, i cristiani erano tutti alla processione, portando con sé anche i bambini. Recentemente i ragazzi che seguiamo hanno parlato via skype con un gruppo di coetanei portoghesi. Questi volevano organizzarsi per mandare aiuti e chiedevano di che cosa avessero più bisogno. E loro, pur avendo necessità di tante cose materiali, continuavano a ripetere: «Pregate per noi, pregate per la pace, pregate che si fermi questa spirale di odio».  Il vostro restare in Siria è una scelta forte, coraggiosa… «Non ci sentiamo degli eroi. Come non siamo qui a titolo personale. Prima di partire avevo potuto incontrare papa Francesco: nel suo incoraggiamento ho sentito tutto l’amore della Chiesa che si fa vicina a questo popolo così provato. Ci sentiamo sostenuti anche dall’amore di tutto il Movimento dei Focolari sparso nel mondo. Ne abbiamo bisogno per continuare a sperare, impotenti di fronte alla supremazia degli interessi economici e al proliferare del mercato internazionale di armi. La nostra mission è partecipare e condividere le vicende quotidiane della gente. Festeggiamo insieme le ricorrenze, creiamo momenti distensivi fra adulti e bambini per cercare di alleviare lo stress. Organizziamo momenti di spiritualità, preghiamo insieme per la pace. A Natale i nostri giovani hanno organizzato un concerto: vi hanno partecipato 300 persone, fra cui anche amici musulmani. Recentemente abbiamo festeggiato un matrimonio. Nella famiglia erano stati uccisi due figli e per via del lutto la ragazza non poteva uscire da casa vestita da sposa. Allora è uscita dal focolare, accompagnata in chiesa da tutte noi. Cerchiamo di inserirci nelle iniziative della Chiesa locale e con le altre espressioni ecclesiali che sono qui ci aiutiamo a prosciugare le sofferenze e le privazioni della gente. Per continuare insieme a sperare e a credere, sostenendo ogni sforzo per l’avvento della pace». (altro…)
Il vostro restare in Siria è una scelta forte, coraggiosa… «Non ci sentiamo degli eroi. Come non siamo qui a titolo personale. Prima di partire avevo potuto incontrare papa Francesco: nel suo incoraggiamento ho sentito tutto l’amore della Chiesa che si fa vicina a questo popolo così provato. Ci sentiamo sostenuti anche dall’amore di tutto il Movimento dei Focolari sparso nel mondo. Ne abbiamo bisogno per continuare a sperare, impotenti di fronte alla supremazia degli interessi economici e al proliferare del mercato internazionale di armi. La nostra mission è partecipare e condividere le vicende quotidiane della gente. Festeggiamo insieme le ricorrenze, creiamo momenti distensivi fra adulti e bambini per cercare di alleviare lo stress. Organizziamo momenti di spiritualità, preghiamo insieme per la pace. A Natale i nostri giovani hanno organizzato un concerto: vi hanno partecipato 300 persone, fra cui anche amici musulmani. Recentemente abbiamo festeggiato un matrimonio. Nella famiglia erano stati uccisi due figli e per via del lutto la ragazza non poteva uscire da casa vestita da sposa. Allora è uscita dal focolare, accompagnata in chiesa da tutte noi. Cerchiamo di inserirci nelle iniziative della Chiesa locale e con le altre espressioni ecclesiali che sono qui ci aiutiamo a prosciugare le sofferenze e le privazioni della gente. Per continuare insieme a sperare e a credere, sostenendo ogni sforzo per l’avvento della pace». (altro…)

Apr 20, 2015 | Cultura, Ecumenismo, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità
 Nel distretto di Rotorua (Nuova Zelanda) lo spessore della crosta terrestre è di soli 4 km. Qui si possono ammirare spettacolari geyser zampillanti e, addirittura nella città, fumanti pozzanghere con tanto di bollicine che ne agitano la superficie. Dal suolo esce un calore che arriva anche a 120°C. È qui che i colonizzatori inglesi avevano tentato di ricreare i bagni romani. Ancora oggi l’attività termale è al centro dell’interesse turistico per Rotorua, una città immersa nel verde e circondata da colline. Sulle rive del lago omonimo sorge il Keswick Christian Camp, una struttura estiva. Lì, per il meeting promosso dai Focolari, si sono date appuntamento 156 persone provenienti da varie città delle due isole principali che compongono la Nuova Zelanda. Obiettivo: trascorrere tre giorni insieme, lontano dalla routine, per approfondire la spiritualità dell’unità.
Nel distretto di Rotorua (Nuova Zelanda) lo spessore della crosta terrestre è di soli 4 km. Qui si possono ammirare spettacolari geyser zampillanti e, addirittura nella città, fumanti pozzanghere con tanto di bollicine che ne agitano la superficie. Dal suolo esce un calore che arriva anche a 120°C. È qui che i colonizzatori inglesi avevano tentato di ricreare i bagni romani. Ancora oggi l’attività termale è al centro dell’interesse turistico per Rotorua, una città immersa nel verde e circondata da colline. Sulle rive del lago omonimo sorge il Keswick Christian Camp, una struttura estiva. Lì, per il meeting promosso dai Focolari, si sono date appuntamento 156 persone provenienti da varie città delle due isole principali che compongono la Nuova Zelanda. Obiettivo: trascorrere tre giorni insieme, lontano dalla routine, per approfondire la spiritualità dell’unità.  Maori, filippini, cinesi, coreani, olandesi, anglosassoni, italiani, maltesi, singaporiani, taiwanesi, futunesi, francesi, tokelauani, indiani, pakistani…: una sorprendente varietà etnica nel bozzetto di umanità venuto a crearsi. Nonostante tale diversità, fin dal primo momento si respirava un clima di famiglia. Oltre a momenti di spiritualità e di attività ricreative, il programma prevedeva ampi spazi per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio fra tutti. Molto toccante il racconto della famiglia Pitcaithly, di Christchurch, la seconda città del Paese, recentemente devastata da due forti terremoti. Una tragedia che ha unito la popolazione in un coro di solidarietà con lo slogan “Kia kaha, stay strong Christchurch!”, cui hanno contribuito anche offerte raccolte dai Focolari in varie parti del mondo. Da Gisborne, la città che ha il privilegio di vedere per prima il sole che sorge, si è presentata l’attività di “Fish & Chips Club”. Fra le finalità, raccogliere fondi a favore di attività formative per i giovani, portata avanti da persone di varie Chiese cristiane con altre di convinzioni non religiose: insieme si cerca di fare qualcosa di utile per gli altri. Nonostante la pluralità, giovani e adulti si riuniscono una volta al mese per riflettere sul Vangelo e condividere le esperienze che scaturiscono dal cercare di metterlo in pratica. Un modo davvero significativo per crescere come persone e trarre forza per portare avanti le diverse attività artigianali e sportive di un club dove ognuno può essere sé stesso e dove si cerca di sottolineare non tanto ciò che distingue, ma i valori che si possono condividere. A
Maori, filippini, cinesi, coreani, olandesi, anglosassoni, italiani, maltesi, singaporiani, taiwanesi, futunesi, francesi, tokelauani, indiani, pakistani…: una sorprendente varietà etnica nel bozzetto di umanità venuto a crearsi. Nonostante tale diversità, fin dal primo momento si respirava un clima di famiglia. Oltre a momenti di spiritualità e di attività ricreative, il programma prevedeva ampi spazi per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio fra tutti. Molto toccante il racconto della famiglia Pitcaithly, di Christchurch, la seconda città del Paese, recentemente devastata da due forti terremoti. Una tragedia che ha unito la popolazione in un coro di solidarietà con lo slogan “Kia kaha, stay strong Christchurch!”, cui hanno contribuito anche offerte raccolte dai Focolari in varie parti del mondo. Da Gisborne, la città che ha il privilegio di vedere per prima il sole che sorge, si è presentata l’attività di “Fish & Chips Club”. Fra le finalità, raccogliere fondi a favore di attività formative per i giovani, portata avanti da persone di varie Chiese cristiane con altre di convinzioni non religiose: insieme si cerca di fare qualcosa di utile per gli altri. Nonostante la pluralità, giovani e adulti si riuniscono una volta al mese per riflettere sul Vangelo e condividere le esperienze che scaturiscono dal cercare di metterlo in pratica. Un modo davvero significativo per crescere come persone e trarre forza per portare avanti le diverse attività artigianali e sportive di un club dove ognuno può essere sé stesso e dove si cerca di sottolineare non tanto ciò che distingue, ma i valori che si possono condividere. A nche se la Nuova Zelanda può apparire una terra benestante e accogliente, una famiglia indiana-pakistana ha raccontato quanto è stato difficile il loro inserimento in questa società. Martis, papà di due figli, lavorava in una casa di cura per anziani e la moglie Antoneta in una piccola azienda di lavorazione della carne. Ad un tratto ambedue hanno perso il lavoro. La ricerca di una nuova occupazione si protraeva senza risultato, tanto da decidere il ritorno in patria. A soli dieci giorni dalla scadenza del visto, da una città vicina qualcuno è riuscito a procurare un’intervista di lavoro per Martins e quindi la possibilità di rinnovare il permesso di residenza. Grande la gioia di tutti e di questa famiglia che ha dato una forte testimonianza dell’amore di Dio che si manifesta attraverso la comunità. Teresa, riassumendo la voce dei giovani presenti, ha detto: «L’esperienza di questi giorni ci ha dato la carica per tornare nelle nostre rispettive città e ricominciare daccapo». Anne, una signora anziana Maori, tanto stimata dalla sua tribù, ha concluso: «Aroha te mea nui o te ao Katoa»; che nella sua lingua significa: «L’amore è il dono più grande di tutto il mondo». (altro…)
nche se la Nuova Zelanda può apparire una terra benestante e accogliente, una famiglia indiana-pakistana ha raccontato quanto è stato difficile il loro inserimento in questa società. Martis, papà di due figli, lavorava in una casa di cura per anziani e la moglie Antoneta in una piccola azienda di lavorazione della carne. Ad un tratto ambedue hanno perso il lavoro. La ricerca di una nuova occupazione si protraeva senza risultato, tanto da decidere il ritorno in patria. A soli dieci giorni dalla scadenza del visto, da una città vicina qualcuno è riuscito a procurare un’intervista di lavoro per Martins e quindi la possibilità di rinnovare il permesso di residenza. Grande la gioia di tutti e di questa famiglia che ha dato una forte testimonianza dell’amore di Dio che si manifesta attraverso la comunità. Teresa, riassumendo la voce dei giovani presenti, ha detto: «L’esperienza di questi giorni ci ha dato la carica per tornare nelle nostre rispettive città e ricominciare daccapo». Anne, una signora anziana Maori, tanto stimata dalla sua tribù, ha concluso: «Aroha te mea nui o te ao Katoa»; che nella sua lingua significa: «L’amore è il dono più grande di tutto il mondo». (altro…)

Apr 18, 2015 | Centro internazionale, Focolari nel Mondo, Spiritualità
 «Non si può dire qui chi è stato Igino Giordani per il Movimento dei Focolari. Basti pensare che egli è un cofondatore del Movimento stesso. Ora essere fondatori o anche cofondatori di un’Opera che la Chiesa riconosce sua, comporta un’azione così molteplice e complessa della grazia di Dio, impulsi così vari e validi dello Spirito Santo, comportamenti, da parte del soggetto, così decisivi per l’Opera ed il più delle volte imprevisti perché suggeriti dall’Alto, richiesta di sofferenze spesso penetranti e prolungate nel tempo, elargizioni di grazie di luce e di amore, non ordinarie, che è meglio affidare alla storia della Chiesa e dei Movimenti spirituali che l’abbelliscono di secolo in secolo, la rivelazione di questa figura. Si può dire qualcosa, anche se non è facile, di Igino Giordani focolarino. Il focolarino fa ogni cosa, prega, lavora, soffre, per arrivare a questo traguardo: esser perfetto nell’amore. Ebbene ci sembra proprio di dover affermare che Giordani ha raggiunto questa mèta. Per quanto noi possiamo giudicare, egli è stato perfetto nell’amore. Ha impersonato quindi il nome di battaglia col quale era chiamato nel Movimento: Foco, fuoco, e cioè quel amore verso Dio e il prossimo, soprannaturale e naturale, che sta alla base ed al vertice della vita cristiana, contribuendo in maniera unica a mantener viva in mezzo a tutti noi la realtà della “parola di vita” che gli era stata indicata al suo ingresso nel Movimento: “Amatevi a vicenda come io ho amato voi”. Quelli che hanno conosciuto a fondo Igino Giordani, sono concordi nel costatare e nell’affermare che egli ha vissuto le beatitudini. “Puro di cuore” in maniera eccezionale, ha aperto a persone coniugate di ambo i sessi, di varie parti del mondo, la possibilità d’una originale consacrazione a Dio, pur nello stato matrimoniale, mediante una verginità spirituale, effetto della più ardente carità. Questa purezza di cuore gli affinò i sentimenti più sacri e li potenziò. Aveva un tenerissimo amore per la sua sposa. Ed alla fine della vita commuoveva ed impressionava l’intensità dell’affetto verso i suoi quattro figlioli. Così per i suoi nipoti. Era un padre perfetto, un nonno perfetto e un uomo tutto di Dio. E’ stato “povero in spirito” con un distacco completo non solo da tutto ciò che possedeva, ma soprattutto da tutto ciò che era. Era carico di misericordia. Vicino a lui anche il più misero peccatore si sentiva perdonato ed il più povero si sentiva re. Una delle caratteristiche più spiccate, come documenta anche la sua storia di uomo politico, è stata quella di “operatore di pace”. Ed era arrivato a possedere tale mitezza da far capire come il Vangelo dica che chi ha questa virtù possiede la terra: egli con la più nobile gentilezza, con quel modo di trattare, con quelle parole tutte sue che aveva per ognuno, conquistava tutti quelli che avvicinava. Chiunque si sentiva a suo agio, considerato con dignità, anche i giovani riuscivano a stabilire con lui un rapporto da pari a pari. E si costatava come, soprattutto negli ultimi anni, irradiasse, parlando, qualcosa di soprannaturale. “Aveva fame e sete della giustizia” per la quale ha combattuto tutta la vita. Ed ha subìto persecuzioni per il nome di Dio, per cui oggi lo crediamo in possesso del Suo Regno. Ma molte altre parole del Vangelo fanno ricordare la sua figura. Da lui si comprende cosa significhi quella conversione che Gesù chiede, per cui occorre farsi bambini. Cristiano di prim’ordine, dotto, apologeta, apostolo, quando gli è parso d’incontrare una polla d’acqua genuina, che sgorgava dalla Chiesa, ha saputo “vendere tutto” per seguire Gesù che lo chiamava a dissetarsi di quell’acqua. Avendo molto sofferto per quell’emarginazione spirituale in cui gli sembrava di scorgere ai suoi tempi il laicato, ambiva con tutto il suo grande cuore ad abbattere pareti divisorie fra persone che stavano nello stato di perfezione ed altri – aggiungeva scherzando – in quello di imperfezione. In pratica, egli era sensibilissimo ai segni dei tempi, anzi era lui stesso un segno dei tempi, di questi tempi in cui lo Spirito Santo chiama tutto il popolo di Dio alla santità. Quando Igino Giordani aveva incontrato il Movimento era formato soltanto da persone vergini. È stato lui a spalancarlo ai coniugati, che al suo seguito hanno avvertito la fame di santità e di consacrazione, mandando ad effetto quel progetto, prima soltanto intravisto, d’una convivenza di vergini e coniugati, per quanto è a questi consentito, sull’immagine della famiglia di Nazareth. Giordani è stato uno dei più grandi doni che il cielo abbia fatto al Movimento dei Focolari». (tratto da: Chiara Lubich, Igino Giordani focolarino, «Città Nuova» n. 9-10 maggio 1980) (altro…)
«Non si può dire qui chi è stato Igino Giordani per il Movimento dei Focolari. Basti pensare che egli è un cofondatore del Movimento stesso. Ora essere fondatori o anche cofondatori di un’Opera che la Chiesa riconosce sua, comporta un’azione così molteplice e complessa della grazia di Dio, impulsi così vari e validi dello Spirito Santo, comportamenti, da parte del soggetto, così decisivi per l’Opera ed il più delle volte imprevisti perché suggeriti dall’Alto, richiesta di sofferenze spesso penetranti e prolungate nel tempo, elargizioni di grazie di luce e di amore, non ordinarie, che è meglio affidare alla storia della Chiesa e dei Movimenti spirituali che l’abbelliscono di secolo in secolo, la rivelazione di questa figura. Si può dire qualcosa, anche se non è facile, di Igino Giordani focolarino. Il focolarino fa ogni cosa, prega, lavora, soffre, per arrivare a questo traguardo: esser perfetto nell’amore. Ebbene ci sembra proprio di dover affermare che Giordani ha raggiunto questa mèta. Per quanto noi possiamo giudicare, egli è stato perfetto nell’amore. Ha impersonato quindi il nome di battaglia col quale era chiamato nel Movimento: Foco, fuoco, e cioè quel amore verso Dio e il prossimo, soprannaturale e naturale, che sta alla base ed al vertice della vita cristiana, contribuendo in maniera unica a mantener viva in mezzo a tutti noi la realtà della “parola di vita” che gli era stata indicata al suo ingresso nel Movimento: “Amatevi a vicenda come io ho amato voi”. Quelli che hanno conosciuto a fondo Igino Giordani, sono concordi nel costatare e nell’affermare che egli ha vissuto le beatitudini. “Puro di cuore” in maniera eccezionale, ha aperto a persone coniugate di ambo i sessi, di varie parti del mondo, la possibilità d’una originale consacrazione a Dio, pur nello stato matrimoniale, mediante una verginità spirituale, effetto della più ardente carità. Questa purezza di cuore gli affinò i sentimenti più sacri e li potenziò. Aveva un tenerissimo amore per la sua sposa. Ed alla fine della vita commuoveva ed impressionava l’intensità dell’affetto verso i suoi quattro figlioli. Così per i suoi nipoti. Era un padre perfetto, un nonno perfetto e un uomo tutto di Dio. E’ stato “povero in spirito” con un distacco completo non solo da tutto ciò che possedeva, ma soprattutto da tutto ciò che era. Era carico di misericordia. Vicino a lui anche il più misero peccatore si sentiva perdonato ed il più povero si sentiva re. Una delle caratteristiche più spiccate, come documenta anche la sua storia di uomo politico, è stata quella di “operatore di pace”. Ed era arrivato a possedere tale mitezza da far capire come il Vangelo dica che chi ha questa virtù possiede la terra: egli con la più nobile gentilezza, con quel modo di trattare, con quelle parole tutte sue che aveva per ognuno, conquistava tutti quelli che avvicinava. Chiunque si sentiva a suo agio, considerato con dignità, anche i giovani riuscivano a stabilire con lui un rapporto da pari a pari. E si costatava come, soprattutto negli ultimi anni, irradiasse, parlando, qualcosa di soprannaturale. “Aveva fame e sete della giustizia” per la quale ha combattuto tutta la vita. Ed ha subìto persecuzioni per il nome di Dio, per cui oggi lo crediamo in possesso del Suo Regno. Ma molte altre parole del Vangelo fanno ricordare la sua figura. Da lui si comprende cosa significhi quella conversione che Gesù chiede, per cui occorre farsi bambini. Cristiano di prim’ordine, dotto, apologeta, apostolo, quando gli è parso d’incontrare una polla d’acqua genuina, che sgorgava dalla Chiesa, ha saputo “vendere tutto” per seguire Gesù che lo chiamava a dissetarsi di quell’acqua. Avendo molto sofferto per quell’emarginazione spirituale in cui gli sembrava di scorgere ai suoi tempi il laicato, ambiva con tutto il suo grande cuore ad abbattere pareti divisorie fra persone che stavano nello stato di perfezione ed altri – aggiungeva scherzando – in quello di imperfezione. In pratica, egli era sensibilissimo ai segni dei tempi, anzi era lui stesso un segno dei tempi, di questi tempi in cui lo Spirito Santo chiama tutto il popolo di Dio alla santità. Quando Igino Giordani aveva incontrato il Movimento era formato soltanto da persone vergini. È stato lui a spalancarlo ai coniugati, che al suo seguito hanno avvertito la fame di santità e di consacrazione, mandando ad effetto quel progetto, prima soltanto intravisto, d’una convivenza di vergini e coniugati, per quanto è a questi consentito, sull’immagine della famiglia di Nazareth. Giordani è stato uno dei più grandi doni che il cielo abbia fatto al Movimento dei Focolari». (tratto da: Chiara Lubich, Igino Giordani focolarino, «Città Nuova» n. 9-10 maggio 1980) (altro…)

Apr 17, 2015 | Famiglie, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo
 «Nel 2014 l’impresa per cui lavoravo – racconta Rosette – mi ha assegnata alla regione del Kurdistan iracheno (KRI). Per facilitare l’inserimento lavorativo di mio marito Eric, anch’egli con un ottimo curriculum, abbiamo pensato di sistemarci a Dubai, un ricco emirato arabo dove si vive in modo piacevole con tutti i comfort. A causa di questa ricchezza molti stranieri vengono a Dubai per perseguire una vita migliore per sé stessi e per le loro famiglie, anche se questo significa lasciare i propri cari nei Paesi d’origine. In uno dei miei viaggi in Kurdistan, pur essendo in aeroporto con due ore di anticipo, sono stata cancellata dalla lista dei passeggeri. Ero agitata perché significava prendere un aereo più piccolo che partiva soltanto all’una di notte. Mancava ancora tanto tempo all’imbarco, ma ugualmente sono andata al nuovo terminal: non si sa mai. Qui stranamente vedo già tante persone, fra cui molte che dormono sul pavimento. Chiedo loro quanto si doveva aspettare. Una signora mi dice: “Dipende: può essere subito ma può richiedere giorni”. Infatti lei era lì da quasi due giorni a causa di un errore di ortografia sul suo visto. E non la facevano uscire. Per avviare una conversazione le chiedo se avesse da mangiare: “Sì, ho ancora qualche cracker e un po’ d’acqua”. La invito per un pasto con me e dopo molte resistenze finalmente accetta. Mentre stiamo chiacchierando, la chiama il suo datore di lavoro per controllare come stava e per sapere se aveva soldi per rimanere lì. Lei non aveva denaro. Aveva inviato tutto il suo stipendio al figlio affinché pagasse le tasse universitarie. Finita la telefonata mi racconta la sua storia: separata dal marito, i due figli vivono con la nonna al paese d’origine. È venuta a lavorare a Dubai perché anche la figlia sta finendo la scuola superiore e occorrono soldi per l’università. Poco dopo sento annunciare il mio volo. Ma chissà lei fino a quando dovrà aspettare. La incoraggio a prendere i soldi che le sto dando. Le prometto che avrei pregato per la sua famiglia. La sua è solo una delle tante storie di come vivono gli immigrati. Alcune famiglie sono a Dubai perché nella loro terra c’è la guerra (palestinesi, siriani, iracheni): Dubai si presenta come un rifugio sicuro dove poter vivere una vita normale. Per loro il lavoro è tutto, inizio e fine, perché senza lavoro non avranno visto e senza il visto non potranno rimanere a Dubai. Specialmente per quelli che sono qui da soli, a lungo andare la distanza fisica e la solitudine di un paese straniero arrivano spesso ad offuscare anche la più pura delle intenzioni. Conosciamo persone che hanno avviato relazioni extra coniugali, distruggendo così quella stessa famiglia per la quale sono venuti qui, riducendosi a fornire ai propri cari non già la loro presenza ma solo il denaro. Purtroppo la maggioranza di queste persone accetta tale soluzione come un fatto ineluttabile, anche se il prezzo è molto alto da pagare. Questo stesso “prezzo” è venuto a bussare anche da noi. I miei frequenti viaggi in Dubai mi portavano ad essere sempre meno con Eric. Così abbiamo deciso di trasferirci in Kurdistan, anche se questo significava rinunciare al buon lavoro che Eric aveva a Dubai. Inizialmente la mia azienda ha accettato, ma nel corso di ulteriori colloqui e alcuni episodi violenti in Kurdistan, ci è stato detto che l’azienda non poteva garantire la sicurezza di Eric e quindi che lui non poteva trasferirsi lì. Uno dei miei responsabili mi ha ventilato: “…vi abituerete ad essere separati…”. Di fronte a questa prospettiva abbiamo deciso immediatamente di dare le dimissioni. In nessun caso dovevamo vivere separati, anche se questo significava rinunciare ad un lavoro ben pagato e ad una carriera per la quale avevo tanto studiato. Confesso che è stata una scelta per niente facile. Nel cuore però tutti e due sentivamo che era quella giusta. Il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 31 dicembre 2014. Lo scorso gennaio il Papa è venuto nelle Filippine, e nell’incontro con le famiglie ha affermato con forza il valore della famiglia: “Dobbiamo essere forti nel dire no a qualsiasi intento di colonizzazione ideologica che vuole distruggere la famiglia”. Sembrava detto su misura per noi, a conferma della scelta controcorrente che avevamo fatto». (altro…)
«Nel 2014 l’impresa per cui lavoravo – racconta Rosette – mi ha assegnata alla regione del Kurdistan iracheno (KRI). Per facilitare l’inserimento lavorativo di mio marito Eric, anch’egli con un ottimo curriculum, abbiamo pensato di sistemarci a Dubai, un ricco emirato arabo dove si vive in modo piacevole con tutti i comfort. A causa di questa ricchezza molti stranieri vengono a Dubai per perseguire una vita migliore per sé stessi e per le loro famiglie, anche se questo significa lasciare i propri cari nei Paesi d’origine. In uno dei miei viaggi in Kurdistan, pur essendo in aeroporto con due ore di anticipo, sono stata cancellata dalla lista dei passeggeri. Ero agitata perché significava prendere un aereo più piccolo che partiva soltanto all’una di notte. Mancava ancora tanto tempo all’imbarco, ma ugualmente sono andata al nuovo terminal: non si sa mai. Qui stranamente vedo già tante persone, fra cui molte che dormono sul pavimento. Chiedo loro quanto si doveva aspettare. Una signora mi dice: “Dipende: può essere subito ma può richiedere giorni”. Infatti lei era lì da quasi due giorni a causa di un errore di ortografia sul suo visto. E non la facevano uscire. Per avviare una conversazione le chiedo se avesse da mangiare: “Sì, ho ancora qualche cracker e un po’ d’acqua”. La invito per un pasto con me e dopo molte resistenze finalmente accetta. Mentre stiamo chiacchierando, la chiama il suo datore di lavoro per controllare come stava e per sapere se aveva soldi per rimanere lì. Lei non aveva denaro. Aveva inviato tutto il suo stipendio al figlio affinché pagasse le tasse universitarie. Finita la telefonata mi racconta la sua storia: separata dal marito, i due figli vivono con la nonna al paese d’origine. È venuta a lavorare a Dubai perché anche la figlia sta finendo la scuola superiore e occorrono soldi per l’università. Poco dopo sento annunciare il mio volo. Ma chissà lei fino a quando dovrà aspettare. La incoraggio a prendere i soldi che le sto dando. Le prometto che avrei pregato per la sua famiglia. La sua è solo una delle tante storie di come vivono gli immigrati. Alcune famiglie sono a Dubai perché nella loro terra c’è la guerra (palestinesi, siriani, iracheni): Dubai si presenta come un rifugio sicuro dove poter vivere una vita normale. Per loro il lavoro è tutto, inizio e fine, perché senza lavoro non avranno visto e senza il visto non potranno rimanere a Dubai. Specialmente per quelli che sono qui da soli, a lungo andare la distanza fisica e la solitudine di un paese straniero arrivano spesso ad offuscare anche la più pura delle intenzioni. Conosciamo persone che hanno avviato relazioni extra coniugali, distruggendo così quella stessa famiglia per la quale sono venuti qui, riducendosi a fornire ai propri cari non già la loro presenza ma solo il denaro. Purtroppo la maggioranza di queste persone accetta tale soluzione come un fatto ineluttabile, anche se il prezzo è molto alto da pagare. Questo stesso “prezzo” è venuto a bussare anche da noi. I miei frequenti viaggi in Dubai mi portavano ad essere sempre meno con Eric. Così abbiamo deciso di trasferirci in Kurdistan, anche se questo significava rinunciare al buon lavoro che Eric aveva a Dubai. Inizialmente la mia azienda ha accettato, ma nel corso di ulteriori colloqui e alcuni episodi violenti in Kurdistan, ci è stato detto che l’azienda non poteva garantire la sicurezza di Eric e quindi che lui non poteva trasferirsi lì. Uno dei miei responsabili mi ha ventilato: “…vi abituerete ad essere separati…”. Di fronte a questa prospettiva abbiamo deciso immediatamente di dare le dimissioni. In nessun caso dovevamo vivere separati, anche se questo significava rinunciare ad un lavoro ben pagato e ad una carriera per la quale avevo tanto studiato. Confesso che è stata una scelta per niente facile. Nel cuore però tutti e due sentivamo che era quella giusta. Il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 31 dicembre 2014. Lo scorso gennaio il Papa è venuto nelle Filippine, e nell’incontro con le famiglie ha affermato con forza il valore della famiglia: “Dobbiamo essere forti nel dire no a qualsiasi intento di colonizzazione ideologica che vuole distruggere la famiglia”. Sembrava detto su misura per noi, a conferma della scelta controcorrente che avevamo fatto». (altro…)

Apr 16, 2015 | Chiesa, Focolari nel Mondo

Antonette, la giovane collaboratrice di una ONG, nel villaggio di Rosanda.

Case in quarantena nel villaggio di Rosanda
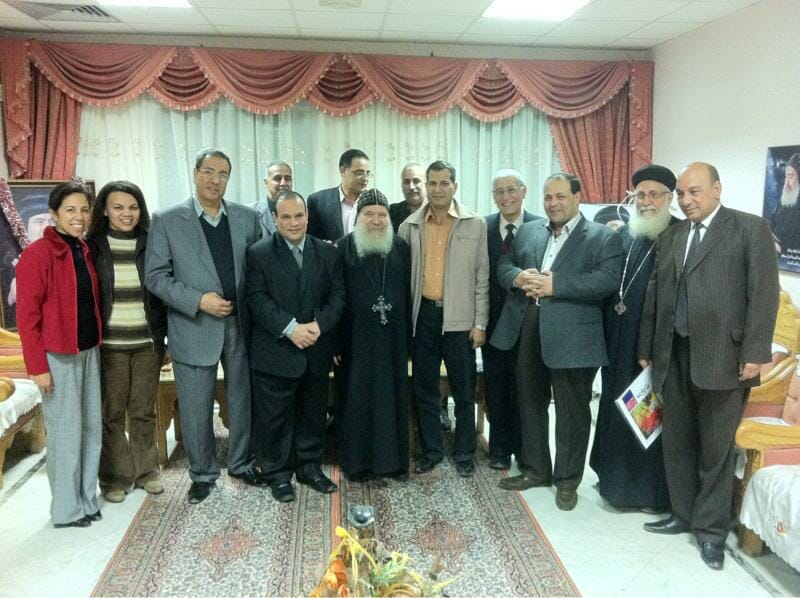
Apr 15, 2015 | Chiesa, Ecumenismo, Focolare Worldwide, Focolari nel Mondo, Spiritualità
 «Tanti hanno provato a spiegare le radici e le ragioni degli inizi della vita monastica, ma i detti dei Padri e la loro esperienza di vita ci mostrano che il monaco è “il martire vivente”, e che “hanno lasciato il mondo per l’unica realtà che ha valore: Dio”. È come voler rispondere all’amore di Dio, espresso bene in un versetto della Santa Messa Copta, che noi chiamiamo Divina Liturgia, che si rivolge a Dio dicendo: “Non c’è niente delle parole dette che potrà delineare il Tuo amore per gli uomini”. San Gerolamo dice che attraverso la loro ascetica e la loro vita eremitica è come se dicessero: “L’amore divino ci ha colpito con le sue frecce”; e ognuno ripetesse: “Ho trovato quello che la mia anima anela, lo terrò forte e non lo lascerò mai”. Il desiderio di questi monaci era, quindi, di darsi completamente a questo amore, e per consacrarsi a Lui non hanno trovato altro che lasciare le città. San Basilio annuncia chiaramente: “Chi ama Dio lascia tutto e va verso di Lui”. E si dice del discepolo di San Pacomio, San Tawadros, che “il suo unico interesse nel mondo era di amare Dio con tutto il cuore seguendo il comando di Gesù Cristo”. Si intuisce che la radice della vita ascetica è somigliare a Cristo: la completa spogliazione di sé, seguire la volontà del Padre, la verginità, in contatto continuo con Dio Padre attraverso la preghiera. Padre Matta El Meskin lo spiega bene: “La garanzia della nostra consacrazione (l’essere monaci) sta nell’aggrapparsi a Cristo personalmente, e attenersi bene alla Bibbia. E così, con Cristo e la Bibbia, potremo camminare nella nostra via, in continua crescita, fino alla fine”. La scelta del consacrato è quella di seguire Gesù “Via, Verità e Vita”. Vivere in Cristo e per Lui solo. Seguirlo nello stile di vita che ha vissuto. Lui ha scelto di vivere povero, vergine ed obbediente. Allora il monaco non sceglie la povertà, ma Cristo il povero. La scelta è della persona stessa di Gesù, e perciò di quello che ha vissuto Cristo, come l’ha vissuto e perché l’ha vissuto così. Per quanto riguarda l’aspetto comunitario nella vita ascetica dei monaci del deserto, possiamo ricordare come – ad esempio nei monasteri che seguono San Pacomio – la vita di comunione diventava l’estensione della Chiesa primitiva del tempo degli apostoli. Guardando alla vita dei Padri, possiamo tracciare alcune caratteristiche comunitarie: l’amore reciproco (San Pacomio sollecita sempre i suoi ad amarsi, ed è per la carità fra i monaci che questa vita si è diffusa e continua fino ad oggi); la vita insieme (il “tutto era fra loro comune” delle prime comunità cristiane è caratteristica dominante in tutti gli aspetti della convivenza dei monaci). Gli insegnamenti dei Padri del deserto mi ricordano la meditazione di Chiara Lubich “L’attrattiva del tempo moderno”, che esprime bene quello che provo: “Penetrare nella più alta contemplazione, rimanendo mescolati fra tutti, uomo accanto a uomo”. Una contemplazione che attualizza la vita dei Padri in questo secolo, ma in mezzo al mondo. La presenza spirituale di Gesù tra noi con le focolarine cattoliche con cui vivo nel focolare di Sohag, l’impegno a volerci bene, ci ha reso veramente sorelle e ci fa sperimentare la gioia del Risorto, al di là delle nostre differenze. Nella vita quotidiana tutto è fra noi in comune: preghiamo, lavoriamo, gioiamo e condividiamo i momenti di sofferenza delle persone che ci circondano. Cerchiamo di testimoniare a tutti, con la nostra vita, che Dio è amore.
«Tanti hanno provato a spiegare le radici e le ragioni degli inizi della vita monastica, ma i detti dei Padri e la loro esperienza di vita ci mostrano che il monaco è “il martire vivente”, e che “hanno lasciato il mondo per l’unica realtà che ha valore: Dio”. È come voler rispondere all’amore di Dio, espresso bene in un versetto della Santa Messa Copta, che noi chiamiamo Divina Liturgia, che si rivolge a Dio dicendo: “Non c’è niente delle parole dette che potrà delineare il Tuo amore per gli uomini”. San Gerolamo dice che attraverso la loro ascetica e la loro vita eremitica è come se dicessero: “L’amore divino ci ha colpito con le sue frecce”; e ognuno ripetesse: “Ho trovato quello che la mia anima anela, lo terrò forte e non lo lascerò mai”. Il desiderio di questi monaci era, quindi, di darsi completamente a questo amore, e per consacrarsi a Lui non hanno trovato altro che lasciare le città. San Basilio annuncia chiaramente: “Chi ama Dio lascia tutto e va verso di Lui”. E si dice del discepolo di San Pacomio, San Tawadros, che “il suo unico interesse nel mondo era di amare Dio con tutto il cuore seguendo il comando di Gesù Cristo”. Si intuisce che la radice della vita ascetica è somigliare a Cristo: la completa spogliazione di sé, seguire la volontà del Padre, la verginità, in contatto continuo con Dio Padre attraverso la preghiera. Padre Matta El Meskin lo spiega bene: “La garanzia della nostra consacrazione (l’essere monaci) sta nell’aggrapparsi a Cristo personalmente, e attenersi bene alla Bibbia. E così, con Cristo e la Bibbia, potremo camminare nella nostra via, in continua crescita, fino alla fine”. La scelta del consacrato è quella di seguire Gesù “Via, Verità e Vita”. Vivere in Cristo e per Lui solo. Seguirlo nello stile di vita che ha vissuto. Lui ha scelto di vivere povero, vergine ed obbediente. Allora il monaco non sceglie la povertà, ma Cristo il povero. La scelta è della persona stessa di Gesù, e perciò di quello che ha vissuto Cristo, come l’ha vissuto e perché l’ha vissuto così. Per quanto riguarda l’aspetto comunitario nella vita ascetica dei monaci del deserto, possiamo ricordare come – ad esempio nei monasteri che seguono San Pacomio – la vita di comunione diventava l’estensione della Chiesa primitiva del tempo degli apostoli. Guardando alla vita dei Padri, possiamo tracciare alcune caratteristiche comunitarie: l’amore reciproco (San Pacomio sollecita sempre i suoi ad amarsi, ed è per la carità fra i monaci che questa vita si è diffusa e continua fino ad oggi); la vita insieme (il “tutto era fra loro comune” delle prime comunità cristiane è caratteristica dominante in tutti gli aspetti della convivenza dei monaci). Gli insegnamenti dei Padri del deserto mi ricordano la meditazione di Chiara Lubich “L’attrattiva del tempo moderno”, che esprime bene quello che provo: “Penetrare nella più alta contemplazione, rimanendo mescolati fra tutti, uomo accanto a uomo”. Una contemplazione che attualizza la vita dei Padri in questo secolo, ma in mezzo al mondo. La presenza spirituale di Gesù tra noi con le focolarine cattoliche con cui vivo nel focolare di Sohag, l’impegno a volerci bene, ci ha reso veramente sorelle e ci fa sperimentare la gioia del Risorto, al di là delle nostre differenze. Nella vita quotidiana tutto è fra noi in comune: preghiamo, lavoriamo, gioiamo e condividiamo i momenti di sofferenza delle persone che ci circondano. Cerchiamo di testimoniare a tutti, con la nostra vita, che Dio è amore. 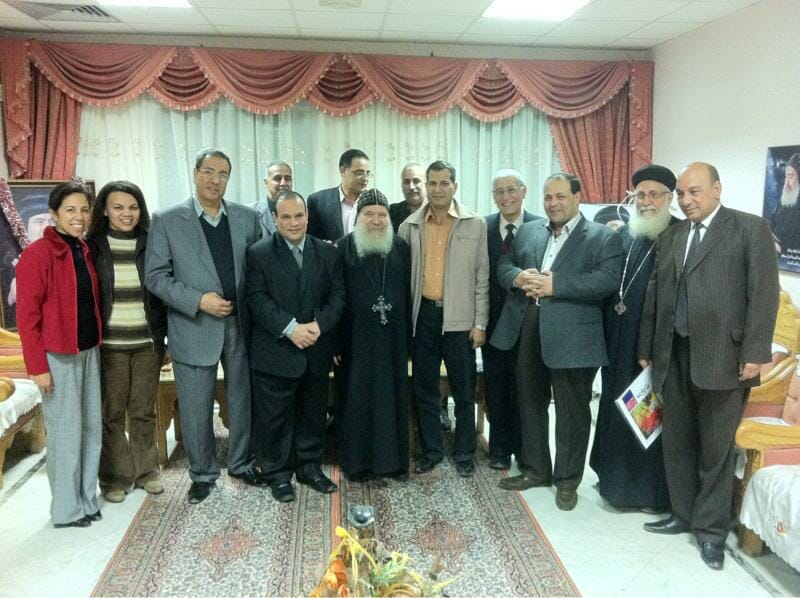 Vivere per l’unità piena nella Chiesa di Cristo “che tutti siano una cosa sola”, mi affascina sempre di più. Godo della bellezza e la varietà dei doni di Dio che ritrovo nelle diverse Chiese, e l’aspirazione e l’emozione di vedere che siamo uniti in Cristo fra noi e nel futuro della Chiesa nel disegno di Dio. Ne sono testimonianza i piccoli e grandi passi nel cammino ecumenico, anche nel mio Paese. Da qualche anno, ad esempio, è stata costituita una commissione ecumenica con persone di ogni confessione cristiana esistente a Sohag. Ogni volta ci si incontra in una chiesa diversa: quest’anno in quella copta ortodossa. Il 5 marzo erano presenti quasi tutti i responsabili locali delle chiese. Il tema principale era “la vittoria sul male”, a partire dalla situazione di persecuzione dei cristiani in Libia, e ripercorrendo le tappe del popolo d’Israele che lascia l’Egitto. «La bandiera che vola su di noi è l’amore di Dio», ha affermato il vescovo copto ortodosso Mons. Bakhoum, augurando ai presenti «che ci troviamo sempre nell’Amore». (altro…)
Vivere per l’unità piena nella Chiesa di Cristo “che tutti siano una cosa sola”, mi affascina sempre di più. Godo della bellezza e la varietà dei doni di Dio che ritrovo nelle diverse Chiese, e l’aspirazione e l’emozione di vedere che siamo uniti in Cristo fra noi e nel futuro della Chiesa nel disegno di Dio. Ne sono testimonianza i piccoli e grandi passi nel cammino ecumenico, anche nel mio Paese. Da qualche anno, ad esempio, è stata costituita una commissione ecumenica con persone di ogni confessione cristiana esistente a Sohag. Ogni volta ci si incontra in una chiesa diversa: quest’anno in quella copta ortodossa. Il 5 marzo erano presenti quasi tutti i responsabili locali delle chiese. Il tema principale era “la vittoria sul male”, a partire dalla situazione di persecuzione dei cristiani in Libia, e ripercorrendo le tappe del popolo d’Israele che lascia l’Egitto. «La bandiera che vola su di noi è l’amore di Dio», ha affermato il vescovo copto ortodosso Mons. Bakhoum, augurando ai presenti «che ci troviamo sempre nell’Amore». (altro…)

 Uno sguardo vivo, un sorriso dolce che, velandosi di tristezza, permane anche quando racconta le tragiche vicende nel Paese diventato ora la sua patria di elezione. Ghada, cosa ti ha spinto a tornare in Siria? «A 20 anni ho lasciato famiglia e patria per seguire Dio. Nel settembre 2013, quando ho deciso di tornare in Siria, lo slancio era lo stesso, intatto. Non mi spaventava l’idea che avrei potuto anche morire. Di più mi attraeva l’andare a vivere accanto alle persone che anni prima avevo conosciuto e far sentire loro che non sono abbandonate. Mi ha spinto il desiderio di condividere la loro vita, le loro paure, la precarietà del loro quotidiano. Qui infatti le bombe fioccano quando meno te l’aspetti». Ma non c’è nessun preavviso ai bombardamenti per potersi proteggere in qualche modo? «Non ci sono sirene che annuncino i raid e neppure ci si può basare su una strategia che faccia supporre quando e dove i razzi colpiranno. D’altra parte è ormai il 5° anno di guerra e non si può restare barricati per sempre. Ci si può fermare un giorno, un mese ma poi, anche se tuonano i mortai, la vita deve continuare: i bambini vanno a scuola e i genitori a lavorare per mantenere la famiglia. Tutto va avanti, nella precarietà e nel rischio più assoluti. Avevo vissuto lo stesso dramma quando ero in focolare in Libano, ma qui è tutto più aggravato, tutto più difficile. Qui si respira terrore e violenza da ogni angolo».
Uno sguardo vivo, un sorriso dolce che, velandosi di tristezza, permane anche quando racconta le tragiche vicende nel Paese diventato ora la sua patria di elezione. Ghada, cosa ti ha spinto a tornare in Siria? «A 20 anni ho lasciato famiglia e patria per seguire Dio. Nel settembre 2013, quando ho deciso di tornare in Siria, lo slancio era lo stesso, intatto. Non mi spaventava l’idea che avrei potuto anche morire. Di più mi attraeva l’andare a vivere accanto alle persone che anni prima avevo conosciuto e far sentire loro che non sono abbandonate. Mi ha spinto il desiderio di condividere la loro vita, le loro paure, la precarietà del loro quotidiano. Qui infatti le bombe fioccano quando meno te l’aspetti». Ma non c’è nessun preavviso ai bombardamenti per potersi proteggere in qualche modo? «Non ci sono sirene che annuncino i raid e neppure ci si può basare su una strategia che faccia supporre quando e dove i razzi colpiranno. D’altra parte è ormai il 5° anno di guerra e non si può restare barricati per sempre. Ci si può fermare un giorno, un mese ma poi, anche se tuonano i mortai, la vita deve continuare: i bambini vanno a scuola e i genitori a lavorare per mantenere la famiglia. Tutto va avanti, nella precarietà e nel rischio più assoluti. Avevo vissuto lo stesso dramma quando ero in focolare in Libano, ma qui è tutto più aggravato, tutto più difficile. Qui si respira terrore e violenza da ogni angolo».  Tu eri già stata in Siria nel passato. Puoi dirci qualcosa del cambiamento che hai trovato? «Quando ero in focolare in Libano, mi recavo ad Aleppo, a Homs e anche a Damasco perché già allora tante persone desideravano mantenersi in contatto coi Focolari. Per la sensibilità e la profondità interiore del popolo siriano, era spontaneo stringere rapporti significativi. Si condividevano i valori cristiani, qui tanto sentiti. Pur nella pluralità di Chiese e riti diversi, tipica di questa terra, c’era e c’è ancora grande armonia tra tutti. Quando nel ’94 si è progettato il focolare ad Aleppo, sono stata mandata ad aprirlo con altre due focolarine. Ci sono rimasta per 9 anni. Per la Siria erano tempi di prosperità: il Paese non aveva debito pubblico e il PIL era in continua ascesa. Di sera anche noi ragazze potevamo uscire liberamente. Ora c’è la bufera. Ma il peggio è l’assenza della prospettiva che questa guerra possa cessare. Sono tornata per dire, con gli altri focolarini, che siamo in Siria, che non l’abbiamo dimenticata, che Gesù ci ha plasmati un’unica famiglia e per questo vogliamo correre gli stessi rischi. Anche noi infatti, come tutti, andiamo al lavoro, in chiesa, al mercato, senza sapere se torneremo a casa. Siamo lì per l’amore che ci lega e la comunità in Siria sa che siamo disposti anche a dare la vita per loro. Come lo sono anche loro per noi. Questa reciprocità è davvero eccezionale. Fanno a gara per farci stare bene, per condividere con noi tutto quello che hanno». Voi focolarine siete a Damasco, una città affascinante, ricca di arte, di storia, una famosa meta turistica. Come si vive lì, oggi? «In città, ma anche nei villaggi, ogni giorno si sfida la morte. I trasporti sono spesso in tilt per mancanza di gasolio e continui posti di blocco. Si sa quando si esce ma non si sa quando si arriverà. Nelle case l’elettricità manca per ore, come pure l’acqua. Si rischia l’esasperazione. Tanto che l’esodo – per chi può lasciare il Paese – è in continua ascesa. Si calcola che l’emigrazione, anch’essa non priva di rischi gravissimi, abbia superato i 6 milioni di persone. Ma la religiosità è sempre molto sentita. Alla Via Crucis del venerdì santo, pur consapevoli che le bombe potevano esplodere da un momento all’altro, i cristiani erano tutti alla processione, portando con sé anche i bambini. Recentemente i ragazzi che seguiamo hanno parlato via skype con un gruppo di coetanei portoghesi. Questi volevano organizzarsi per mandare aiuti e chiedevano di che cosa avessero più bisogno. E loro, pur avendo necessità di tante cose materiali, continuavano a ripetere: «Pregate per noi, pregate per la pace, pregate che si fermi questa spirale di odio».
Tu eri già stata in Siria nel passato. Puoi dirci qualcosa del cambiamento che hai trovato? «Quando ero in focolare in Libano, mi recavo ad Aleppo, a Homs e anche a Damasco perché già allora tante persone desideravano mantenersi in contatto coi Focolari. Per la sensibilità e la profondità interiore del popolo siriano, era spontaneo stringere rapporti significativi. Si condividevano i valori cristiani, qui tanto sentiti. Pur nella pluralità di Chiese e riti diversi, tipica di questa terra, c’era e c’è ancora grande armonia tra tutti. Quando nel ’94 si è progettato il focolare ad Aleppo, sono stata mandata ad aprirlo con altre due focolarine. Ci sono rimasta per 9 anni. Per la Siria erano tempi di prosperità: il Paese non aveva debito pubblico e il PIL era in continua ascesa. Di sera anche noi ragazze potevamo uscire liberamente. Ora c’è la bufera. Ma il peggio è l’assenza della prospettiva che questa guerra possa cessare. Sono tornata per dire, con gli altri focolarini, che siamo in Siria, che non l’abbiamo dimenticata, che Gesù ci ha plasmati un’unica famiglia e per questo vogliamo correre gli stessi rischi. Anche noi infatti, come tutti, andiamo al lavoro, in chiesa, al mercato, senza sapere se torneremo a casa. Siamo lì per l’amore che ci lega e la comunità in Siria sa che siamo disposti anche a dare la vita per loro. Come lo sono anche loro per noi. Questa reciprocità è davvero eccezionale. Fanno a gara per farci stare bene, per condividere con noi tutto quello che hanno». Voi focolarine siete a Damasco, una città affascinante, ricca di arte, di storia, una famosa meta turistica. Come si vive lì, oggi? «In città, ma anche nei villaggi, ogni giorno si sfida la morte. I trasporti sono spesso in tilt per mancanza di gasolio e continui posti di blocco. Si sa quando si esce ma non si sa quando si arriverà. Nelle case l’elettricità manca per ore, come pure l’acqua. Si rischia l’esasperazione. Tanto che l’esodo – per chi può lasciare il Paese – è in continua ascesa. Si calcola che l’emigrazione, anch’essa non priva di rischi gravissimi, abbia superato i 6 milioni di persone. Ma la religiosità è sempre molto sentita. Alla Via Crucis del venerdì santo, pur consapevoli che le bombe potevano esplodere da un momento all’altro, i cristiani erano tutti alla processione, portando con sé anche i bambini. Recentemente i ragazzi che seguiamo hanno parlato via skype con un gruppo di coetanei portoghesi. Questi volevano organizzarsi per mandare aiuti e chiedevano di che cosa avessero più bisogno. E loro, pur avendo necessità di tante cose materiali, continuavano a ripetere: «Pregate per noi, pregate per la pace, pregate che si fermi questa spirale di odio».  Il vostro restare in Siria è una scelta forte, coraggiosa… «Non ci sentiamo degli eroi. Come non siamo qui a titolo personale. Prima di partire avevo potuto incontrare papa Francesco: nel suo incoraggiamento ho sentito tutto l’amore della Chiesa che si fa vicina a questo popolo così provato. Ci sentiamo sostenuti anche dall’amore di tutto il Movimento dei Focolari sparso nel mondo. Ne abbiamo bisogno per continuare a sperare, impotenti di fronte alla supremazia degli interessi economici e al proliferare del mercato internazionale di armi. La nostra mission è partecipare e condividere le vicende quotidiane della gente. Festeggiamo insieme le ricorrenze, creiamo momenti distensivi fra adulti e bambini per cercare di alleviare lo stress. Organizziamo momenti di spiritualità, preghiamo insieme per la pace. A Natale i nostri giovani hanno organizzato un concerto: vi hanno partecipato 300 persone, fra cui anche amici musulmani. Recentemente abbiamo festeggiato un matrimonio. Nella famiglia erano stati uccisi due figli e per via del lutto la ragazza non poteva uscire da casa vestita da sposa. Allora è uscita dal focolare, accompagnata in chiesa da tutte noi. Cerchiamo di inserirci nelle iniziative della Chiesa locale e con le altre espressioni ecclesiali che sono qui ci aiutiamo a prosciugare le sofferenze e le privazioni della gente. Per continuare insieme a sperare e a credere, sostenendo ogni sforzo per l’avvento della pace». (altro…)
Il vostro restare in Siria è una scelta forte, coraggiosa… «Non ci sentiamo degli eroi. Come non siamo qui a titolo personale. Prima di partire avevo potuto incontrare papa Francesco: nel suo incoraggiamento ho sentito tutto l’amore della Chiesa che si fa vicina a questo popolo così provato. Ci sentiamo sostenuti anche dall’amore di tutto il Movimento dei Focolari sparso nel mondo. Ne abbiamo bisogno per continuare a sperare, impotenti di fronte alla supremazia degli interessi economici e al proliferare del mercato internazionale di armi. La nostra mission è partecipare e condividere le vicende quotidiane della gente. Festeggiamo insieme le ricorrenze, creiamo momenti distensivi fra adulti e bambini per cercare di alleviare lo stress. Organizziamo momenti di spiritualità, preghiamo insieme per la pace. A Natale i nostri giovani hanno organizzato un concerto: vi hanno partecipato 300 persone, fra cui anche amici musulmani. Recentemente abbiamo festeggiato un matrimonio. Nella famiglia erano stati uccisi due figli e per via del lutto la ragazza non poteva uscire da casa vestita da sposa. Allora è uscita dal focolare, accompagnata in chiesa da tutte noi. Cerchiamo di inserirci nelle iniziative della Chiesa locale e con le altre espressioni ecclesiali che sono qui ci aiutiamo a prosciugare le sofferenze e le privazioni della gente. Per continuare insieme a sperare e a credere, sostenendo ogni sforzo per l’avvento della pace». (altro…)








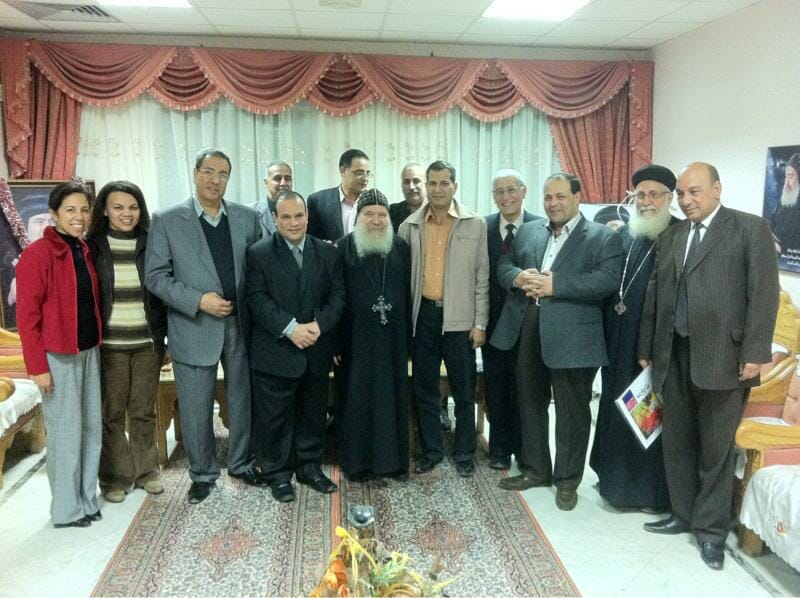
 «Tanti hanno provato a spiegare le radici e le ragioni degli inizi della vita monastica, ma i detti dei Padri e la loro esperienza di vita ci mostrano che il monaco è “il martire vivente”, e che “hanno lasciato il mondo per l’unica realtà che ha valore: Dio”. È come voler rispondere all’amore di Dio, espresso bene in un versetto della Santa Messa Copta, che noi chiamiamo Divina Liturgia, che si rivolge a Dio dicendo: “Non c’è niente delle parole dette che potrà delineare il Tuo amore per gli uomini”. San Gerolamo dice che attraverso la loro ascetica e la loro vita eremitica è come se dicessero: “L’amore divino ci ha colpito con le sue frecce”; e ognuno ripetesse: “Ho trovato quello che la mia anima anela, lo terrò forte e non lo lascerò mai”. Il desiderio di questi monaci era, quindi, di darsi completamente a questo amore, e per consacrarsi a Lui non hanno trovato altro che lasciare le città. San Basilio annuncia chiaramente: “Chi ama Dio lascia tutto e va verso di Lui”. E si dice del discepolo di San Pacomio, San Tawadros, che “il suo unico interesse nel mondo era di amare Dio con tutto il cuore seguendo il comando di Gesù Cristo”. Si intuisce che la radice della vita ascetica è somigliare a Cristo: la completa spogliazione di sé, seguire la volontà del Padre, la verginità, in contatto continuo con Dio Padre attraverso la preghiera. Padre Matta El Meskin lo spiega bene: “La garanzia della nostra consacrazione (l’essere monaci) sta nell’aggrapparsi a Cristo personalmente, e attenersi bene alla Bibbia. E così, con Cristo e la Bibbia, potremo camminare nella nostra via, in continua crescita, fino alla fine”. La scelta del consacrato è quella di seguire Gesù “Via, Verità e Vita”. Vivere in Cristo e per Lui solo. Seguirlo nello stile di vita che ha vissuto. Lui ha scelto di vivere povero, vergine ed obbediente. Allora il monaco non sceglie la povertà, ma Cristo il povero. La scelta è della persona stessa di Gesù, e perciò di quello che ha vissuto Cristo, come l’ha vissuto e perché l’ha vissuto così. Per quanto riguarda l’aspetto comunitario nella vita ascetica dei monaci del deserto, possiamo ricordare come – ad esempio nei monasteri che seguono San Pacomio – la vita di comunione diventava l’estensione della Chiesa primitiva del tempo degli apostoli. Guardando alla vita dei Padri, possiamo tracciare alcune caratteristiche comunitarie: l’amore reciproco (San Pacomio sollecita sempre i suoi ad amarsi, ed è per la carità fra i monaci che questa vita si è diffusa e continua fino ad oggi); la vita insieme (il “tutto era fra loro comune” delle prime comunità cristiane è caratteristica dominante in tutti gli aspetti della convivenza dei monaci). Gli insegnamenti dei Padri del deserto mi ricordano la meditazione di
«Tanti hanno provato a spiegare le radici e le ragioni degli inizi della vita monastica, ma i detti dei Padri e la loro esperienza di vita ci mostrano che il monaco è “il martire vivente”, e che “hanno lasciato il mondo per l’unica realtà che ha valore: Dio”. È come voler rispondere all’amore di Dio, espresso bene in un versetto della Santa Messa Copta, che noi chiamiamo Divina Liturgia, che si rivolge a Dio dicendo: “Non c’è niente delle parole dette che potrà delineare il Tuo amore per gli uomini”. San Gerolamo dice che attraverso la loro ascetica e la loro vita eremitica è come se dicessero: “L’amore divino ci ha colpito con le sue frecce”; e ognuno ripetesse: “Ho trovato quello che la mia anima anela, lo terrò forte e non lo lascerò mai”. Il desiderio di questi monaci era, quindi, di darsi completamente a questo amore, e per consacrarsi a Lui non hanno trovato altro che lasciare le città. San Basilio annuncia chiaramente: “Chi ama Dio lascia tutto e va verso di Lui”. E si dice del discepolo di San Pacomio, San Tawadros, che “il suo unico interesse nel mondo era di amare Dio con tutto il cuore seguendo il comando di Gesù Cristo”. Si intuisce che la radice della vita ascetica è somigliare a Cristo: la completa spogliazione di sé, seguire la volontà del Padre, la verginità, in contatto continuo con Dio Padre attraverso la preghiera. Padre Matta El Meskin lo spiega bene: “La garanzia della nostra consacrazione (l’essere monaci) sta nell’aggrapparsi a Cristo personalmente, e attenersi bene alla Bibbia. E così, con Cristo e la Bibbia, potremo camminare nella nostra via, in continua crescita, fino alla fine”. La scelta del consacrato è quella di seguire Gesù “Via, Verità e Vita”. Vivere in Cristo e per Lui solo. Seguirlo nello stile di vita che ha vissuto. Lui ha scelto di vivere povero, vergine ed obbediente. Allora il monaco non sceglie la povertà, ma Cristo il povero. La scelta è della persona stessa di Gesù, e perciò di quello che ha vissuto Cristo, come l’ha vissuto e perché l’ha vissuto così. Per quanto riguarda l’aspetto comunitario nella vita ascetica dei monaci del deserto, possiamo ricordare come – ad esempio nei monasteri che seguono San Pacomio – la vita di comunione diventava l’estensione della Chiesa primitiva del tempo degli apostoli. Guardando alla vita dei Padri, possiamo tracciare alcune caratteristiche comunitarie: l’amore reciproco (San Pacomio sollecita sempre i suoi ad amarsi, ed è per la carità fra i monaci che questa vita si è diffusa e continua fino ad oggi); la vita insieme (il “tutto era fra loro comune” delle prime comunità cristiane è caratteristica dominante in tutti gli aspetti della convivenza dei monaci). Gli insegnamenti dei Padri del deserto mi ricordano la meditazione di