


In ricordo di Chiara sulle rive del Bosforo
 Istanbul: il Patriarca Bartolomeo fa gli onori di casa nella chiesa ortodossa di Aya Strati Taksiarhi per l’appuntamento che coinvolge oltre un centinaio di rappresentanti del mondo ortodosso e cattolico, in occasione del 7° anniversario della fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich. Ci sono i metropoliti Ireneos, Apostolos ed Elpidoforos; due archimandriti, Patera Vangeli, che ha tradotto in simultanea dal greco al turco e il Grande Archimandrita Vissarion. Presenti anche l’arcivescovo degli Armeno Cattolici, Levon Zekiyan e il vescovo cattolico, Louis Palâtre, oltre a religiose e religiosi. Da Roma, per addentrarsi nella presentazione dei volumi di Chiara tradotti in greco, la linguista Maria Caterina Atzori, del Centro studi dei Focolari. A moderare gli interventi, da Atene, il giornalista Nikos Papachristou. «Nel corso dei secoli, la divina epifania del Signore si è manifestata in tanti modi, per far comprendere all’umanità le cose di Dio», ha esordito il Patriarca, dopo aver aperto l’incontro con una preghiera per Chiara, intonando l’inno allo Spirito Santo. «Egli non si è stancato di far sorgere tra noi santi uomini e sante donne, che con il loro esempio, con il loro amore poggiato sulla filantropia divina e con la parola ispirata dallo Spirito Santo, continuamente sollecitano una “metanoia”, una conversione del cuore per tutta l’umanità sofferente».
Istanbul: il Patriarca Bartolomeo fa gli onori di casa nella chiesa ortodossa di Aya Strati Taksiarhi per l’appuntamento che coinvolge oltre un centinaio di rappresentanti del mondo ortodosso e cattolico, in occasione del 7° anniversario della fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich. Ci sono i metropoliti Ireneos, Apostolos ed Elpidoforos; due archimandriti, Patera Vangeli, che ha tradotto in simultanea dal greco al turco e il Grande Archimandrita Vissarion. Presenti anche l’arcivescovo degli Armeno Cattolici, Levon Zekiyan e il vescovo cattolico, Louis Palâtre, oltre a religiose e religiosi. Da Roma, per addentrarsi nella presentazione dei volumi di Chiara tradotti in greco, la linguista Maria Caterina Atzori, del Centro studi dei Focolari. A moderare gli interventi, da Atene, il giornalista Nikos Papachristou. «Nel corso dei secoli, la divina epifania del Signore si è manifestata in tanti modi, per far comprendere all’umanità le cose di Dio», ha esordito il Patriarca, dopo aver aperto l’incontro con una preghiera per Chiara, intonando l’inno allo Spirito Santo. «Egli non si è stancato di far sorgere tra noi santi uomini e sante donne, che con il loro esempio, con il loro amore poggiato sulla filantropia divina e con la parola ispirata dallo Spirito Santo, continuamente sollecitano una “metanoia”, una conversione del cuore per tutta l’umanità sofferente».
 «Chiara Lubich inizia il suo percorso di vita, dedicata al Signore, nelle sofferenze della guerra. In questa sofferenza vive il Cristo crocifisso e abbandonato e comprende che non c’è Resurrezione senza passare attraverso la caduta. E la sofferenza di Cristo diviene la sua personale sofferenza, mai però disperazione». «La sua vita è contraddistinta da una passione per la Santa Scrittura, la Parola di Dio che in lei diviene Parola fondante, viva, esaltante. Ha vissuto fino in fondo il comandamento del Signore. “(…) come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv. 13,34) E questo comandamento si è personificato in lei fino a contagiare un numero sempre maggiore di persone, diverse tra loro, anche di diversa fede, ma unite in un ideale concreto di comunione. Chiara è sempre stata anche figlia fedele della sua Chiesa, condividendo e vivendo in se stessa la via della sua Chiesa. E in questa convinta partecipazione, ha sentito il dramma della divisione, il dramma della impossibilità di partecipare allo stesso Calice. In lei fanno eco le parole ancora del nostro venerabile Predecessore, inviatele nel 1969: “Dov’è il Cristo Salvatore? Divisi gli uni dagli altri, noi l’abbiamo cacciato. È Da qui che provengono le nostre disgrazie”. E che fanno le Chiese? Stanno mercanteggiando su Colui che non ha presso e da qui il loro triste frazionamento” (Messaggio del 21 febbraio 1969). Percependo il grido di dolore per la lacerazione, offre tutta se stessa per il carisma dell’unità, facendosi strumento nelle mani di Dio per incontrare i capi delle Chiese, come i semplici fedeli. Ma non si ferma a questo: sollecita, sprona, invita, propone di trovare vie di comunione nuove». «Chiara ha anche un amore tutto particolare per la Santa e Divina Eucarestia del Signore. In essa percepisce il dono d’amore di Colui che si è offerto una volta e per sempre, per attrarre a sé l’uomo. Potremmo affermare che in lei si forma una coscienza eucaristica dell’unità». «Ancora un altro aspetto possiamo scorgere nell’opera di Chiara: l’unità dalla Trinità, attraverso l’Eucarestia, passa sulla famiglia. (…) Il luogo dove può splendere l’amore scambievole che lega naturalmente i suoi membri. (…) È in questo contesto che l’unità della famiglia umana si intravede in tutti i suoi aspetti, nella società, nella politica, nell’economia, nel rispetto dell’opera di Dio per ciascuno di noi singolarmente e in tutta la sua meravigliosa creazione. Il messaggio e l’opera di Chiara pertanto risultano essere sempre più attuali, soprattutto nel contesto mondiale in cui stiamo vivendo». Risulta così particolarmente apprezzato «il dono che il Movimento dei Focolari offre oggi nel presentare la traduzione in Lingua Greca dell’opera di Chiara Lubich. La accogliamo come un dono tra fratelli, dono che sicuramente farà apprezzare anche al pubblico greco, al fedele greco-ortodosso, questo meraviglioso messaggio di unità e d’amore». E prima di impartire la sua benedizione, si rivolge a Chiara perché interceda «perché l’alba di un nuovo giorno per questa umanità ferita e divisa possa sorgere presto e che i sentimenti per i quali Ella ha speso tutta la sua vita, diano abbondanti frutti, lì dove oggi non scorgiamo altro se non tenebre e martirio di sangue». (altro…)
«Chiara Lubich inizia il suo percorso di vita, dedicata al Signore, nelle sofferenze della guerra. In questa sofferenza vive il Cristo crocifisso e abbandonato e comprende che non c’è Resurrezione senza passare attraverso la caduta. E la sofferenza di Cristo diviene la sua personale sofferenza, mai però disperazione». «La sua vita è contraddistinta da una passione per la Santa Scrittura, la Parola di Dio che in lei diviene Parola fondante, viva, esaltante. Ha vissuto fino in fondo il comandamento del Signore. “(…) come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv. 13,34) E questo comandamento si è personificato in lei fino a contagiare un numero sempre maggiore di persone, diverse tra loro, anche di diversa fede, ma unite in un ideale concreto di comunione. Chiara è sempre stata anche figlia fedele della sua Chiesa, condividendo e vivendo in se stessa la via della sua Chiesa. E in questa convinta partecipazione, ha sentito il dramma della divisione, il dramma della impossibilità di partecipare allo stesso Calice. In lei fanno eco le parole ancora del nostro venerabile Predecessore, inviatele nel 1969: “Dov’è il Cristo Salvatore? Divisi gli uni dagli altri, noi l’abbiamo cacciato. È Da qui che provengono le nostre disgrazie”. E che fanno le Chiese? Stanno mercanteggiando su Colui che non ha presso e da qui il loro triste frazionamento” (Messaggio del 21 febbraio 1969). Percependo il grido di dolore per la lacerazione, offre tutta se stessa per il carisma dell’unità, facendosi strumento nelle mani di Dio per incontrare i capi delle Chiese, come i semplici fedeli. Ma non si ferma a questo: sollecita, sprona, invita, propone di trovare vie di comunione nuove». «Chiara ha anche un amore tutto particolare per la Santa e Divina Eucarestia del Signore. In essa percepisce il dono d’amore di Colui che si è offerto una volta e per sempre, per attrarre a sé l’uomo. Potremmo affermare che in lei si forma una coscienza eucaristica dell’unità». «Ancora un altro aspetto possiamo scorgere nell’opera di Chiara: l’unità dalla Trinità, attraverso l’Eucarestia, passa sulla famiglia. (…) Il luogo dove può splendere l’amore scambievole che lega naturalmente i suoi membri. (…) È in questo contesto che l’unità della famiglia umana si intravede in tutti i suoi aspetti, nella società, nella politica, nell’economia, nel rispetto dell’opera di Dio per ciascuno di noi singolarmente e in tutta la sua meravigliosa creazione. Il messaggio e l’opera di Chiara pertanto risultano essere sempre più attuali, soprattutto nel contesto mondiale in cui stiamo vivendo». Risulta così particolarmente apprezzato «il dono che il Movimento dei Focolari offre oggi nel presentare la traduzione in Lingua Greca dell’opera di Chiara Lubich. La accogliamo come un dono tra fratelli, dono che sicuramente farà apprezzare anche al pubblico greco, al fedele greco-ortodosso, questo meraviglioso messaggio di unità e d’amore». E prima di impartire la sua benedizione, si rivolge a Chiara perché interceda «perché l’alba di un nuovo giorno per questa umanità ferita e divisa possa sorgere presto e che i sentimenti per i quali Ella ha speso tutta la sua vita, diano abbondanti frutti, lì dove oggi non scorgiamo altro se non tenebre e martirio di sangue». (altro…)

Cuando los adolescentes “se meten” en política
 Son adolescentes, forman parte del mismo grupo Gen 3. Comparten sus experiencias, anhelos, sueños como todo joven de esa edad. Una de ellas comenta: “Voy a empezar a militar en política, en una organización juvenil”. Continúa la conversación y cada vez se pone más caliente. Quien está a favor de esa organización juvenil y quienes están en contra. Un reflejo de la Argentina de hoy: dos posiciones enfrentadas e irreconciliables. Pero no se quedan en el “de eso mejor no hablar porque nos divide”. Deciden hacer un taller para entender más lo que es la fraternidad en política.
Son adolescentes, forman parte del mismo grupo Gen 3. Comparten sus experiencias, anhelos, sueños como todo joven de esa edad. Una de ellas comenta: “Voy a empezar a militar en política, en una organización juvenil”. Continúa la conversación y cada vez se pone más caliente. Quien está a favor de esa organización juvenil y quienes están en contra. Un reflejo de la Argentina de hoy: dos posiciones enfrentadas e irreconciliables. Pero no se quedan en el “de eso mejor no hablar porque nos divide”. Deciden hacer un taller para entender más lo que es la fraternidad en política. 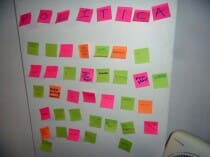 Son 40 adolescentes los que se dieron cita para reflexionar sobre la fraternidad, la política y el diálogo. En primer lugar compartieron qué era la política para ellos: gobierno, presidente, propaganda, mentiras, corrupción, decisiones y, por medio de un juego de roles, respondieron a la siguiente pregunta: ¿Qué harían si se encuentran perdidos en una isla? A través de la puesta en común se observó como cada grupo se organizó en forma diversa, lo que a su vez podía compararse con las distintas formas de organización social. En un segundo momento trabajaron sobre los distintos conflictos, desde los suyos más cotidianos hasta reflexionar sobre como hacen los políticos para tomar decisiones. Al terminar este momento sonaban fuerte palabras como respeto, escucha, tolerancia, apertura, diálogo. Al terminar la actividad volvieron a reflexionar sobre la palabra política y encontraron que no les decía lo mismo que antes y que existe otro horizonte que muchas veces no se logra vislumbrar, fruto de las dísputas que escuchamos a diario en los medios de comunicación. Pero también pudieron conocer que
Son 40 adolescentes los que se dieron cita para reflexionar sobre la fraternidad, la política y el diálogo. En primer lugar compartieron qué era la política para ellos: gobierno, presidente, propaganda, mentiras, corrupción, decisiones y, por medio de un juego de roles, respondieron a la siguiente pregunta: ¿Qué harían si se encuentran perdidos en una isla? A través de la puesta en común se observó como cada grupo se organizó en forma diversa, lo que a su vez podía compararse con las distintas formas de organización social. En un segundo momento trabajaron sobre los distintos conflictos, desde los suyos más cotidianos hasta reflexionar sobre como hacen los políticos para tomar decisiones. Al terminar este momento sonaban fuerte palabras como respeto, escucha, tolerancia, apertura, diálogo. Al terminar la actividad volvieron a reflexionar sobre la palabra política y encontraron que no les decía lo mismo que antes y que existe otro horizonte que muchas veces no se logra vislumbrar, fruto de las dísputas que escuchamos a diario en los medios de comunicación. Pero también pudieron conocer que  existe otra cara de la medalla, la de muchos políticos, funcionarios y ciudadanos en distintos ángulos del planeta que deciden jugarse por la fraternidad y el bien común por sobre todas las cosas. Casi un juego, pero en cada uno se fortalece una visión distinta de la política, descubriendo valores como la tolerancia, la participación, el compromiso social, el escuchar al otro, como decía uno de ellos: “pudimos darnos cuenta que la política no es algo para mirar de lejos, ni para tenerle miedo, sino que tiene que ser otra herramienta para llegar a la fraternidad”. “¡Ahora a ponerlo en práctica!”, decía a modo de conclusión una chica.
existe otra cara de la medalla, la de muchos políticos, funcionarios y ciudadanos en distintos ángulos del planeta que deciden jugarse por la fraternidad y el bien común por sobre todas las cosas. Casi un juego, pero en cada uno se fortalece una visión distinta de la política, descubriendo valores como la tolerancia, la participación, el compromiso social, el escuchar al otro, como decía uno de ellos: “pudimos darnos cuenta que la política no es algo para mirar de lejos, ni para tenerle miedo, sino que tiene que ser otra herramienta para llegar a la fraternidad”. “¡Ahora a ponerlo en práctica!”, decía a modo de conclusión una chica.

La speranza a Erbil, nel Kurdistan iracheno
 «Abito a Erbil, nel nord dell’Iraq, dove, nel 2010, ho iniziato una scuola per i bambini kurdi – racconta Malu Villafane, nata nelle Filippine –. In questi anni, ho lavorato nel santuario locale, organizzando varie attività. Nell’agosto scorso, il santuario è diventato un campo profughi. Le città di Sinjar e Mosul con i villaggi adiacenti, come Qaraqosh, Qaramlesh, Bartalla e altri, sono stati invasi dall’ISIS. Gli abitanti sono scappati lasciando tutto e si sono rifugiati in Kurdistan, da noi. Nel campo c’era un’aria pesantissima, di grande pessimismo, i bambini erano smarriti… Insieme ai responsabili del centro abbiamo iniziato alcune attività per i ragazzi, coinvolgendo anche alcuni colleghi della mia scuola». In questi anni com’è stata la convivenza tra i cristiani, musulmani, gli Yazidi e le altre etnie come kurdi, turkmeni, ecc.? «C’era rispetto tra loro, facevano le cose insieme. Lavoro con i kurdi, con i turkmeni, arabi e altri stranieri. Quando c’è stata la crisi, tanti kurdi hanno dato la loro disponibilità per ospitare i profughi in casa loro. Il popolo del Kurdistan non condivide questo massacro». Quando è iniziata la crisi dei profughi a Erbil? Dove si sono sistemati? Quali prospettive possono avere per i prossimi mesi? «La crisi che ha causato queste forzate migrazioni è iniziata già da giugno del 2014 e si è aggravata agli inizi di agosto. La gente ha perso tutto: casa, lavoro, scuola ; tanti di loro si sono rifugiati inizialmente nei palazzi vuoti, nelle chiese, lungo la strada e quando hanno potuto, presso i parenti a Erbil. Molte ONG, insieme alla Chiesa, hanno dovuto affrontare l’emergenza senza nessuna preparazione. Avevano bisogno di tutto! Insieme abbiamo raccolto tante cose di prima necessità. In quel periodo la temperatura di giorno saliva quasi a 50°C, un inferno, e ora durante l’inverno fa tanto freddo. Le tende non bastano per accudire migliaia di famiglie. Ci sono campi che non hanno acqua e cibo per alcuni periodi di tempo. Eppure, dopo un po’ di mesi, i bambini hanno iniziato a sorridere, a giocare, a provare altre esperienze fuori dal campo, come andare in piscina o nel parco pubblico. I genitori, vedendo la gioia dei loro figli, hanno ritrovato la speranza. Hanno iniziato a pulire il campo, a cucinare e a darci una mano. Dopo aver vissuto con loro questa drammatica situazione, la mia vita si è capovolta. Il mio soggiorno qui in Iraq ha trovato un senso profondo: ho vissuto per la fratellanza universale». Ma ha senso lavorare per la fraternità? Cosa ti spinge a continuare a lavorare nel campo? «Se guardo alle circostanze dal punto di vista umano, mi scoraggio e scapperei via. Invece, se guardo tutto quello che accade attraverso l’occhio di una speranza fondata sulla fede, riesco ad andare al di là delle sofferenze che vedo. Ho pensato alla frase del Vangelo: “Quando ho avuto fame, mi hai dato da mangiare; quando ero triste mi hai consolato…”. Queste parole mi danno la forza di affrontare le difficoltà quotidiane che incontro nel campo. È difficile spiegare o descrivere il dolore che c’è. Tanti di loro hanno perso la speranza perché hanno perso tutto. Questa esperienza mi ha spalancato il cuore per accogliere l’altro come un fratello, come una sorella. Mi ha dato la possibilità di uscire dal mio mondo “comodo” per mettermi a servizio degli altri. Voglio vivere per la fratellanza universale non perché posso risolvere i problemi ma perché, con piccoli passi, si può lasciare un seme. La pace cresce soprattutto dalle piccole cose che facciamo tutti i giorni per gli altri». Cosa possiamo fare noi da qui per aiutarvi e per essere vicini a queste persone? «Credo che bisogna affrontare il tema della “disinformazione”. Nonostante l’emergenza sia tuttora in corso, quasi non se ne parla. Diffondere una cultura che accoglie, che ascolta, soprattutto fra popoli e religioni diverse nelle vostre città; promuovere iniziative e progetti che abbattono le barriere. Vi ringrazio per il vostro aiuto e continuiamo a credere che la Pace è possibile». Fonte: Umanità Nuova online (altro…)
«Abito a Erbil, nel nord dell’Iraq, dove, nel 2010, ho iniziato una scuola per i bambini kurdi – racconta Malu Villafane, nata nelle Filippine –. In questi anni, ho lavorato nel santuario locale, organizzando varie attività. Nell’agosto scorso, il santuario è diventato un campo profughi. Le città di Sinjar e Mosul con i villaggi adiacenti, come Qaraqosh, Qaramlesh, Bartalla e altri, sono stati invasi dall’ISIS. Gli abitanti sono scappati lasciando tutto e si sono rifugiati in Kurdistan, da noi. Nel campo c’era un’aria pesantissima, di grande pessimismo, i bambini erano smarriti… Insieme ai responsabili del centro abbiamo iniziato alcune attività per i ragazzi, coinvolgendo anche alcuni colleghi della mia scuola». In questi anni com’è stata la convivenza tra i cristiani, musulmani, gli Yazidi e le altre etnie come kurdi, turkmeni, ecc.? «C’era rispetto tra loro, facevano le cose insieme. Lavoro con i kurdi, con i turkmeni, arabi e altri stranieri. Quando c’è stata la crisi, tanti kurdi hanno dato la loro disponibilità per ospitare i profughi in casa loro. Il popolo del Kurdistan non condivide questo massacro». Quando è iniziata la crisi dei profughi a Erbil? Dove si sono sistemati? Quali prospettive possono avere per i prossimi mesi? «La crisi che ha causato queste forzate migrazioni è iniziata già da giugno del 2014 e si è aggravata agli inizi di agosto. La gente ha perso tutto: casa, lavoro, scuola ; tanti di loro si sono rifugiati inizialmente nei palazzi vuoti, nelle chiese, lungo la strada e quando hanno potuto, presso i parenti a Erbil. Molte ONG, insieme alla Chiesa, hanno dovuto affrontare l’emergenza senza nessuna preparazione. Avevano bisogno di tutto! Insieme abbiamo raccolto tante cose di prima necessità. In quel periodo la temperatura di giorno saliva quasi a 50°C, un inferno, e ora durante l’inverno fa tanto freddo. Le tende non bastano per accudire migliaia di famiglie. Ci sono campi che non hanno acqua e cibo per alcuni periodi di tempo. Eppure, dopo un po’ di mesi, i bambini hanno iniziato a sorridere, a giocare, a provare altre esperienze fuori dal campo, come andare in piscina o nel parco pubblico. I genitori, vedendo la gioia dei loro figli, hanno ritrovato la speranza. Hanno iniziato a pulire il campo, a cucinare e a darci una mano. Dopo aver vissuto con loro questa drammatica situazione, la mia vita si è capovolta. Il mio soggiorno qui in Iraq ha trovato un senso profondo: ho vissuto per la fratellanza universale». Ma ha senso lavorare per la fraternità? Cosa ti spinge a continuare a lavorare nel campo? «Se guardo alle circostanze dal punto di vista umano, mi scoraggio e scapperei via. Invece, se guardo tutto quello che accade attraverso l’occhio di una speranza fondata sulla fede, riesco ad andare al di là delle sofferenze che vedo. Ho pensato alla frase del Vangelo: “Quando ho avuto fame, mi hai dato da mangiare; quando ero triste mi hai consolato…”. Queste parole mi danno la forza di affrontare le difficoltà quotidiane che incontro nel campo. È difficile spiegare o descrivere il dolore che c’è. Tanti di loro hanno perso la speranza perché hanno perso tutto. Questa esperienza mi ha spalancato il cuore per accogliere l’altro come un fratello, come una sorella. Mi ha dato la possibilità di uscire dal mio mondo “comodo” per mettermi a servizio degli altri. Voglio vivere per la fratellanza universale non perché posso risolvere i problemi ma perché, con piccoli passi, si può lasciare un seme. La pace cresce soprattutto dalle piccole cose che facciamo tutti i giorni per gli altri». Cosa possiamo fare noi da qui per aiutarvi e per essere vicini a queste persone? «Credo che bisogna affrontare il tema della “disinformazione”. Nonostante l’emergenza sia tuttora in corso, quasi non se ne parla. Diffondere una cultura che accoglie, che ascolta, soprattutto fra popoli e religioni diverse nelle vostre città; promuovere iniziative e progetti che abbattono le barriere. Vi ringrazio per il vostro aiuto e continuiamo a credere che la Pace è possibile». Fonte: Umanità Nuova online (altro…)

Vangelo vissuto: il paradosso della Croce
 Lavorare qui «Medici qui nelle Filippine, dove la povertà è dilagante, mio marito ed io abbiamo ricavato un modesto ambulatorio privato nella nostra già piccola abitazione. Certo, non è facile: pensando a nostri colleghi che hanno fatto carriera in Occidente, ci chiediamo talvolta se abbiamo fatto bene a restare. Ma ci trattiene il pensiero dei tanti bisogni della nostra gente: bambini da far crescere sani, coppie da formare, anziani e malati terminali da assistere… Dal Vangelo ci viene la spinta a dare anche noi un contributo per rendere migliore la società, cominciando nel nostro Paese». L. R. – Filippine Mosé della strada «Una famiglia numerosa: sei figli e uno in arrivo, che muore prima di nascere. La mamma si è salvata, ma per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte. Proprio in quel periodo dei militari avevano portato nell’ospedale dov’era ricoverata, un neonato, che era stato abbandonato per strada. Dopo le cure s’era ripreso, ma ora gli occorreva una famiglia. Subito l’ha trovata nell’altra, prendendo il posto del bambino morto. Dai nuovi genitori è stato chiamato Giuseppe-Mosé: Giuseppe perché l’ospedale era intitolato a san Giuseppe, Mosé perché abbandonato e poi ritrovato». H. E. – Congo Volevo vendicarmi «Solo otto giorni dopo il mio matrimonio ho perso mia madre, investita da un’auto. Deciso a vendicarmi, ho preso un pullman per raggiungere il paese di residenza dell’investitore. Lungo il tragitto però mi sono tornate in mente certe parole sull’amore di Dio e del prossimo, e pian piano il rancore si è sciolto. Quando l’altro ha saputo chi ero l’ho visto impallidire, ma l’ho tranquillizzato: ero lì solo per capire la dinamica dell’incidente. Dopo aver ascoltato il suo racconto, fatto tra le lacrime, ho cercato di dargli pace. La gioia promessa dal Vangelo mi ha accompagnato nel ritorno». F.A. – Roma Fonte: Il Vangelo del giorno – marzo 2015 – Città Nuova editrice (altro…)
Lavorare qui «Medici qui nelle Filippine, dove la povertà è dilagante, mio marito ed io abbiamo ricavato un modesto ambulatorio privato nella nostra già piccola abitazione. Certo, non è facile: pensando a nostri colleghi che hanno fatto carriera in Occidente, ci chiediamo talvolta se abbiamo fatto bene a restare. Ma ci trattiene il pensiero dei tanti bisogni della nostra gente: bambini da far crescere sani, coppie da formare, anziani e malati terminali da assistere… Dal Vangelo ci viene la spinta a dare anche noi un contributo per rendere migliore la società, cominciando nel nostro Paese». L. R. – Filippine Mosé della strada «Una famiglia numerosa: sei figli e uno in arrivo, che muore prima di nascere. La mamma si è salvata, ma per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte. Proprio in quel periodo dei militari avevano portato nell’ospedale dov’era ricoverata, un neonato, che era stato abbandonato per strada. Dopo le cure s’era ripreso, ma ora gli occorreva una famiglia. Subito l’ha trovata nell’altra, prendendo il posto del bambino morto. Dai nuovi genitori è stato chiamato Giuseppe-Mosé: Giuseppe perché l’ospedale era intitolato a san Giuseppe, Mosé perché abbandonato e poi ritrovato». H. E. – Congo Volevo vendicarmi «Solo otto giorni dopo il mio matrimonio ho perso mia madre, investita da un’auto. Deciso a vendicarmi, ho preso un pullman per raggiungere il paese di residenza dell’investitore. Lungo il tragitto però mi sono tornate in mente certe parole sull’amore di Dio e del prossimo, e pian piano il rancore si è sciolto. Quando l’altro ha saputo chi ero l’ho visto impallidire, ma l’ho tranquillizzato: ero lì solo per capire la dinamica dell’incidente. Dopo aver ascoltato il suo racconto, fatto tra le lacrime, ho cercato di dargli pace. La gioia promessa dal Vangelo mi ha accompagnato nel ritorno». F.A. – Roma Fonte: Il Vangelo del giorno – marzo 2015 – Città Nuova editrice (altro…)

Movimenti: transizione e fedeltà creativa
150 responsabili di movimenti evangelici e chiese libere, nella variegata realtà del mondo evangelico, e alcuni rappresentanti di movimenti cattolici, si son posti una domanda: come rimanere fedeli al proprio carisma nei momenti di forte cambiamento? È la situazione in cui si trovano diversi movimenti, sorti nel secolo scorso per rispondere all’una o all’altra delle sfide dell’ideale cristiano, e alla ricerca oggi di nuove risposte, adatte ai tempi che viviamo, sempre fedeli alla radice che li ha originati. All’appuntamento di quest’anno del “Convegno di responsabili”, Gerhard Pross, moderatore e tra i volti più conosciuti di Insieme per l’Europa (la rete di movimenti cristiani che lavora insieme per il continente europeo) ha fortemente voluto la presenza di Maria Voce, presidente dei Focolari, e prima a succedere a Chiara Lubich alla guida del Movimento dopo la sua scomparsa nel 2008. La riflessione di Maria Voce ha aiutato a comprendere la differenza tra la fase di fondazione, il “periodo carismatico”, “pieno di sorprese, nuovo, dinamico, luminoso” e la fase della maturità, il “periodo della fedeltà creativa” di un movimento, in cui “far crescere, sviluppare, moltiplicare” quanto intuito e fatto nascere dalla fondatrice/fondatore, con originalità. Ha continuato raccontando l’impegno dei Focolari a vivere un protagonismo diffuso di quanti ne vivono la spiritualità e ne condividono i fini, e soprattutto a “uscire” sempre più fuori “nei vari ambienti della vita e della società”, senza limitarsi a vivere e testimoniare l’unità al suo interno, ma portando lo spirito e l’esperienza di unità in tutto il mondo, “perché tutti siano una cosa sola” (Gv. 17,21), il fine specifico dei Focolari. «Non possiamo perciò pensare a noi – afferma Maria Voce – dobbiamo “uscire”, donarci per essere noi stessi». Fondamentale per andare oltre se stessi, la scelta di Gesù che, nel suo abbandono, va oltre se stesso per ricomporre l’unità fra gli uomini e con Dio, uno dei punti cardine della spiritualità dell’unità. C’erano evangelicali, pentecostali, carismatici, ciascuno impegnato in modo diverso o in opere sociali, o sul fronte dell’evangelizzazione, della formazione, dell’impegno politico. Il “Convegno di responsabili” esiste già dal 1974, ben prima che nella chiesa cattolica Giovanni Paolo II desse il via, nella Pentecoste 1998, alla comunione tra i movimenti. C’è quindi un’esperienza di condivisione che va avanti da anni. Momento importante, nella memoria di tutti i presenti, è stato però nel 2000, quando con Chiara Lubich a Rothenburg si è fatto un passo avanti nella riconciliazione. Si erano infatti depositati dissapori e incomprensioni che sono stati resettati nel «momento sacro del perdono reciproco», così ne parla Maria Voce, «esperienza fondante della comunione tra movimenti e comunità di Chiese diverse, da cui più tardi è emerso l’”Insieme per l’Europa». Una tappa comune a cui si guarda adesso insieme è Monaco 2016, quando la rete di Insieme per l’Europa si ritroverà per un congresso e una manifestazione pubblica, a sua volta tappa verso il cinquecentenario della Riforma di Lutero, offrendosi come segno profetico di un’Europa riconciliata e unita. Di ritorno dalla Germania, il 4 marzo, Maria Voce si è recata poi in udienza da papa Francesco insieme ai Vescovi amici dei Focolari, e ha portato il saluto dei 150 rappresentanti di movimenti evangelici e la loro speranza nel comune impegno verso l’unità. «Bene», ha affermato papa Francesco nel ringraziare. «Molto importante il lavoro ecumenico che portate avanti». (altro…)
Congo: una guerra dimenticata
La Repubblica Democratica del Congo: un grande Paese con immense risorse naturali. 72 milioni di abitanti, alcune centinaia di etnie diverse. Le difficili relazioni con l’Occidente, la guerra per lo sfruttamento dei minerali, il dramma di una popolazione dimenticata. Abbiamo intervistato il biologo congolese Pierre Kabeza, sindacalista, padre di famiglia, che da tre anni ha dovuto lasciare la sua città, Bukavu, nella regione dei Grandi Laghi, e adesso frequenta l’Istituto Universitario Sophia. Lei ha dovuto espatriare, lasciando moglie e figlie. Quali i motivi? «A volte ci sono cose che non si possono capire e vedere bene se non con gli occhi che hanno pianto, diceva Mons. Munzihirwa, vescovo di Bukavu ucciso per la sua lotta per la giustizia. Dopo la sua morte eravamo tutti scoraggiati, ma è arrivato Mons. Kataliko che ha scelto di seguire la sua stessa strada: parlare per i senza voce. Kataliko ha asciugato le lacrime di un popolo che non era più ascoltato. Il 24 dicembre 1999 ha scritto un messaggio nel quale denunciava la guerra ingiusta, l’occupazione del Congo da parte dei paesi vicini, lo sfruttamento e il saccheggio delle risorse minerarie. Per questo gli è stato impedito di fare il suo lavoro pastorale per 7 mesi e 20 giorni. Le campane non hanno più suonato. Facevamo sit-in di protesta ogni giorno, finché non è rientrato in diocesi. Musulmani e cristiani di Bukavu, siamo andati insieme in cattedrale, dove Mons. Kataliko ha celebrato una messa di perdono per quelli che l’avevano fatto soffrire. È morto in Italia poche settimane dopo. Per continuare l’opera dei nostri vescovi – difesa della verità, lotta per la giustizia e per la libertà -è nato il gruppo “Dauphin Munzihirwa Kataliko” (DMK). Le iniziative per onorarli davano fastidio ai loro nemici. Con il gruppo DMK, di cui ero responsabili, ci siamo impegnati nell’ambito dell’educazione, a cominciare dalla scolarizzazione dei bambini. I docenti, infatti, non vengono pagati dallo Stato e sono sostenuti dai genitori. Ci siamo adoperati perché il governo congolese si assumesse le proprie responsabilità. Manifestazioni, sit-in, scioperi… prigione: eravamo considerati persone che disturbano l’ordine pubblico. Ho incontrato tutti i responsabili del Paese, perfino il presidente della Repubblica al quale ho ricordato l’articolo 43 della nostra costituzione che riconosce la gratuità e l’obbligo per i bambini di frequentare la scuola elementare. Mi ha ascoltato, ma purtroppo finora niente è cambiato. Per il mio impegno, però, sono stato minacciato, arrestato e torturato. La mia casa è stata attaccata due volte. Hanno distrutto tutto. È cosi che ho dovuto andare via per salvare la vita». Un guerra dimenticata. 6 milioni di morti, 2 milioni di donne e bambini in fuga dai loro villaggi e città. Ci può raccontare di più? «Sì. Anche Maria Voce, presidente dei Focolari, ha detto che sembra che i morti in “terre lontane dall’Occidente” abbiano meno valore in termini di umanità e “meno peso politico sulla coscienza della comunità internazionale”. È il caso del Congo. I nostri morti non interessano la comunità internazionale perché siamo nelle periferie del mondo. Eppure, oggi, la guerra è il nemico comune di tutti. Mandela ci ha insegnato che “siamo nati per essere fratelli”. Della guerra del Congo si parla poco qui in Europa, e senza dire tutta la verità. Non si tratta solo di guerre etniche. È vero che abbiamo tanti problemi in Africa, ma mi domando: perché il fuoco si accende solo nei paesi ricchi, dove ci sono minerali e petrolio? C’è sempre il fuoco dove si trovano coltan, oro, diamanti. E dove vanno a finire questi minerali insanguinati? Vengono usati per fare smartphone, air bag, navigatori e così via. Si calcola che per ogni chilo di coltan estratto in Congo muoiono due bambini. Altri sono obbligati a divenire “bambini e bambine soldati”. Sarebbe importante che i nostri bambini sappiano che usando il video-gioco c’è un altro bambino che perde la vita nelle periferie del mondo». Che significa per lei fare quest’esperienza intellettuale e umana presso l’Istituto Universitario Sophia? Quali sono le attese personali e in vista del bene del suo Paese? «Sophia è stata uno dei doni che ho avuto in Italia. Penso che sarebbe stato meglio fare l’esperienza di Sophia prima di impegnarmi come sindacalista, perché qui ho capito l’importanza della fraternità. Credo che il fallimento della nostra società congolese stia nel fatto che abbiamo dimenticato il principio della fraternità, una forza che unisce tutti, che non esclude nessuno. Oggi ho capito che l’altro è parte di me, che i suoi problemi sono i miei. L’impegno politico ci dovrebbe aiutare a capire che siamo responsabili gli uni degli altri. A Sophia ho compreso anche il senso della diversità tra noi. Siamo uguali ma diversi e che, se gli uomini sfruttassero questa ricchezza, sarebbe un bene. Sophia mi ha insegnato anche a capire il cammino del dialogo. Il vero dialogo è quello che dà spazio all’altro, dove c’è sempre una parte di verità». Video (altro…)A piccoli passi
 Quando Papa Francesco li ha incontrati, nel settembre scorso, ha ricordato Chiara Lubich come «straordinaria testimone» dell’unità che «ha portato il profumo di Gesù in tante realtà umane e in tante parti del mondo». E oggi, a sette anni dalla morte della fondatrice, il Movimento dei Focolari riconferma la sua vocazione a essere scuola di comunione e fucina di unità per tutta la Chiesa, come ribadisce la presidente Maria Voce in questa intervista al nostro giornale. Crede che il carisma dell’unità di Chiara sia destinato a realizzarsi? Lei pensa che se non lo credessi avrei dato la vita al Movimento? Crediamo si realizzerà perché coincide con la preghiera che Gesù ha rivolto al Padre: che tutti siano una cosa sola. E non possiamo pensare che una preghiera del Figlio di Dio non si debba realizzare. Certo, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma diamo la vita perché si realizzi. Vogliamo che si realizzi e facciamo quei piccoli passi che oggi possiamo compiere per affrettare il momento del suo compimento totale. Cosa significa «essere famiglia» secondo il testamento lasciato da Chiara? In occasione della mia prima elezione ho detto che il mio desiderio era che il Focolare privilegiasse i rapporti umani. Credo che questo è in fondo quello che abbiamo cercato di fare, anche se si è sempre tentati dall’individualismo. Costruire rapporti con le persone all’interno del Movimento significa veramente interessarsi degli altri e avere quell’amore capace di comprendere, di perdonare, di accogliere, di aiutare quando c’è bisogno: tutto quello che si fa all’interno della famiglia. Una vita di famiglia, quindi, ma integra, perché fatta di rapporti veri, autentici. […] Quale ruolo hanno oggi nella Chiesa i movimenti? Il ruolo è duplice: da un lato i movimenti sono portatori di carismi, doni dello Spirito Santo per la Chiesa e l’umanità. Hanno quindi un’influenza su tutta la Chiesa, perché vengono messi a disposizione di tutti per la costruzione del corpo ecclesiale. Oltre a questa grazia, proprio perché depositari di un carisma, i membri di un Movimento sono capaci di comprendere i carismi degli altri. Quindi capaci di rendersi conto che la Chiesa è ricca di carismi che possono essere messi in comune. Nell’ambito dei singoli movimenti poi c’è questa spinta a una vita evangelica più radicale. C’è il desiderio di un maggior impegno, di un’apertura al mondo che ci circonda. Sono caratteristiche che i movimenti cercano di vivere, ma che dovrebbero vivere tutti i cristiani. I membri dei movimenti sentono di avere una grazia, che è anche una responsabilità, e sentono di poter vivere queste cose in comunione tra di loro, per aiutarsi reciprocamente. Nelle associazioni, nei movimenti ci si può aiutare: si può scoprire il valore di essere l’uno accanto all’altra, per darsi una mano, incoraggiarsi, sostenersi e anche rialzarsi qualora si cada. […] Nell’ultima assemblea Papa Francesco vi ha affidato tre verbi: contemplare, uscire, fare scuola. Come li state realizzando? Papa Francesco ha citato una frase di Chiara Lubich: questa è la grande attrattiva del tempo moderno, cioè penetrare nella più alta contemplazione e rimanere in mezzo agli uomini, uomo accanto all’uomo. Chiara ci ha sempre insegnato che bisogna diventare Gesù. E quindi contemplare significa essere Gesù, diventare Gesù, vivendo il Vangelo integralmente, riuscendo a scoprire quello che Gesù sta operando nella storia, quello che vuole dirci attraverso ogni uomo che incontriamo. Vuol dire, quindi, essere in continuo contatto con Gesù. Ricordo una volta che a Chiara venne chiesto come si fa a vivere l’invito del Vangelo a pregare sempre. Lei rispose che occorre essere sempre Gesù, occorre amare sempre. È perfino semplice questa contemplazione che si svolge nelle attività quotidiane, anche presi da mille cose. In quella quotidianità possiamo vedere Dio che ci viene incontro con la sua volontà e con la richiesta di amore del fratello che ci passa accanto. Questa è la contemplazione che vogliamo vivere e che cerchiamo insieme di realizzare. Riguardo all’uscire, è una delle nostre priorità. L’abbiamo sentita particolarmente nostra quando Papa Francesco l’ha sottolineata e abbiamo sentito la gioia di essere in sintonia con quello che il Papa ci chiede oggi. Il fare scuola ci sembra sia soprattutto essere attenti a rivisitare continuamente il nostro carisma: non per trasformarlo, ma per vedere come risponde oggi ai segni dei tempi, cogliendo i linguaggi, gli stili, le domande nuove che l’umanità impone. Facciamo nostro tutto questo per esprimere il carisma di sempre adeguandolo all’oggi. Come presidente quali priorità indica per il futuro del Movimento? Non scelgo io le priorità. Devo cogliere quelle che vengono espresse dal Movimento in tutto il mondo. L’esigenza emersa nell’ultima assemblea è quella di essere molto aperti e in uscita verso le periferie, che non sono solo quelle geografiche, ma dovunque manchi l’amore e le divisioni impediscano di realizzare lo spirito di unità del carisma che Chiara ci ha lasciato. Significa per noi avere una grande apertura a tutti i dialoghi, che è uno stile di vita del Movimento: essere aperti verso tutti, accogliere chiunque, senza distinzione etnica, religiosa, culturale, sociale, anagrafica. Questo porta come conseguenza un’attenzione particolare verso i luoghi dove più si manifestano queste divisioni. Pensiamo a quei Paesi dove c’è un’enorme differenza tra le classi sociali, oppure dove le differenze religiose diventano motivo di lotte, di guerra, di terrorismo. Guardando a questi Paesi, in particolare, vogliamo spendere risorse, talenti, e fare tutto il possibile per aiutarli. Senza però dimenticare l’Europa, che ha perso l’anima religiosa perché ha tagliato le sue radici. Portiamo avanti anche il dialogo con la cultura post moderna, con questa notte che sembra avvolgere la vita degli uomini di oggi. Di Nicola Gori, su Osservatore Romano 18 marzo 2015. Leggi l’intervista integrale (altro…)
Quando Papa Francesco li ha incontrati, nel settembre scorso, ha ricordato Chiara Lubich come «straordinaria testimone» dell’unità che «ha portato il profumo di Gesù in tante realtà umane e in tante parti del mondo». E oggi, a sette anni dalla morte della fondatrice, il Movimento dei Focolari riconferma la sua vocazione a essere scuola di comunione e fucina di unità per tutta la Chiesa, come ribadisce la presidente Maria Voce in questa intervista al nostro giornale. Crede che il carisma dell’unità di Chiara sia destinato a realizzarsi? Lei pensa che se non lo credessi avrei dato la vita al Movimento? Crediamo si realizzerà perché coincide con la preghiera che Gesù ha rivolto al Padre: che tutti siano una cosa sola. E non possiamo pensare che una preghiera del Figlio di Dio non si debba realizzare. Certo, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma diamo la vita perché si realizzi. Vogliamo che si realizzi e facciamo quei piccoli passi che oggi possiamo compiere per affrettare il momento del suo compimento totale. Cosa significa «essere famiglia» secondo il testamento lasciato da Chiara? In occasione della mia prima elezione ho detto che il mio desiderio era che il Focolare privilegiasse i rapporti umani. Credo che questo è in fondo quello che abbiamo cercato di fare, anche se si è sempre tentati dall’individualismo. Costruire rapporti con le persone all’interno del Movimento significa veramente interessarsi degli altri e avere quell’amore capace di comprendere, di perdonare, di accogliere, di aiutare quando c’è bisogno: tutto quello che si fa all’interno della famiglia. Una vita di famiglia, quindi, ma integra, perché fatta di rapporti veri, autentici. […] Quale ruolo hanno oggi nella Chiesa i movimenti? Il ruolo è duplice: da un lato i movimenti sono portatori di carismi, doni dello Spirito Santo per la Chiesa e l’umanità. Hanno quindi un’influenza su tutta la Chiesa, perché vengono messi a disposizione di tutti per la costruzione del corpo ecclesiale. Oltre a questa grazia, proprio perché depositari di un carisma, i membri di un Movimento sono capaci di comprendere i carismi degli altri. Quindi capaci di rendersi conto che la Chiesa è ricca di carismi che possono essere messi in comune. Nell’ambito dei singoli movimenti poi c’è questa spinta a una vita evangelica più radicale. C’è il desiderio di un maggior impegno, di un’apertura al mondo che ci circonda. Sono caratteristiche che i movimenti cercano di vivere, ma che dovrebbero vivere tutti i cristiani. I membri dei movimenti sentono di avere una grazia, che è anche una responsabilità, e sentono di poter vivere queste cose in comunione tra di loro, per aiutarsi reciprocamente. Nelle associazioni, nei movimenti ci si può aiutare: si può scoprire il valore di essere l’uno accanto all’altra, per darsi una mano, incoraggiarsi, sostenersi e anche rialzarsi qualora si cada. […] Nell’ultima assemblea Papa Francesco vi ha affidato tre verbi: contemplare, uscire, fare scuola. Come li state realizzando? Papa Francesco ha citato una frase di Chiara Lubich: questa è la grande attrattiva del tempo moderno, cioè penetrare nella più alta contemplazione e rimanere in mezzo agli uomini, uomo accanto all’uomo. Chiara ci ha sempre insegnato che bisogna diventare Gesù. E quindi contemplare significa essere Gesù, diventare Gesù, vivendo il Vangelo integralmente, riuscendo a scoprire quello che Gesù sta operando nella storia, quello che vuole dirci attraverso ogni uomo che incontriamo. Vuol dire, quindi, essere in continuo contatto con Gesù. Ricordo una volta che a Chiara venne chiesto come si fa a vivere l’invito del Vangelo a pregare sempre. Lei rispose che occorre essere sempre Gesù, occorre amare sempre. È perfino semplice questa contemplazione che si svolge nelle attività quotidiane, anche presi da mille cose. In quella quotidianità possiamo vedere Dio che ci viene incontro con la sua volontà e con la richiesta di amore del fratello che ci passa accanto. Questa è la contemplazione che vogliamo vivere e che cerchiamo insieme di realizzare. Riguardo all’uscire, è una delle nostre priorità. L’abbiamo sentita particolarmente nostra quando Papa Francesco l’ha sottolineata e abbiamo sentito la gioia di essere in sintonia con quello che il Papa ci chiede oggi. Il fare scuola ci sembra sia soprattutto essere attenti a rivisitare continuamente il nostro carisma: non per trasformarlo, ma per vedere come risponde oggi ai segni dei tempi, cogliendo i linguaggi, gli stili, le domande nuove che l’umanità impone. Facciamo nostro tutto questo per esprimere il carisma di sempre adeguandolo all’oggi. Come presidente quali priorità indica per il futuro del Movimento? Non scelgo io le priorità. Devo cogliere quelle che vengono espresse dal Movimento in tutto il mondo. L’esigenza emersa nell’ultima assemblea è quella di essere molto aperti e in uscita verso le periferie, che non sono solo quelle geografiche, ma dovunque manchi l’amore e le divisioni impediscano di realizzare lo spirito di unità del carisma che Chiara ci ha lasciato. Significa per noi avere una grande apertura a tutti i dialoghi, che è uno stile di vita del Movimento: essere aperti verso tutti, accogliere chiunque, senza distinzione etnica, religiosa, culturale, sociale, anagrafica. Questo porta come conseguenza un’attenzione particolare verso i luoghi dove più si manifestano queste divisioni. Pensiamo a quei Paesi dove c’è un’enorme differenza tra le classi sociali, oppure dove le differenze religiose diventano motivo di lotte, di guerra, di terrorismo. Guardando a questi Paesi, in particolare, vogliamo spendere risorse, talenti, e fare tutto il possibile per aiutarli. Senza però dimenticare l’Europa, che ha perso l’anima religiosa perché ha tagliato le sue radici. Portiamo avanti anche il dialogo con la cultura post moderna, con questa notte che sembra avvolgere la vita degli uomini di oggi. Di Nicola Gori, su Osservatore Romano 18 marzo 2015. Leggi l’intervista integrale (altro…)

Il Brasile ricorda Chiara Lubich
 Sabato 14 marzo. Il “Salão dos Atos” immerso nel verde del Parque Barigui di Curitiba, era affollato da deputati federali, statali, sindaci, assessori, funzionari pubblici, giovani e accademici giunti dall’Amazzonia, dal Nordest, Brasilia e da altre città del Brasile. In quella sala sono risuonate parole insolite: la politica presentata come «“l’amore degli amori”che conferisce agli amministratori pubblici di fare progetti capaci di rispondere alle esigenze della comunità e ai cittadini di realizzare le proprie aspirazioni». È stato ricordato che «il potere conferisce la forza, ma è l’amore che dà autorità». Molte volte è stata ripetuta la parola “fraternità”, non solo quale principio etico della politica, ma come “la sua sostanza”. Sono questi i punti centrali del pensiero di Chiara Lubich, che Maria Voce, presidente dei Focolari, ha citato nel suo messaggio e che sono stati approfonditi nei vari interventi. Questa visione della politica che Chiara stessa aveva proposto, anni fa, nei parlamenti di vari Paesi, oggi è apparsa come una luce nel tunnel della crisi che attraversa il Brasile. Ha risvegliato nuova speranza, perché molti sono stati i testimoni che ne hanno mostrato l’attuazione, non solo in Brasile, ma anche in altri Paesi. Un panorama innovativo, presentato nel video-documentario all’inizio dell’evento promosso dal Movimento Politico per l’Unità (MPPU) espressione dei Focolari, nel 7° anniversario della sua morte. L’incontro ha avuto luogo in concomitanza di due manifestazioni popolari di segno opposto e molti degli interventi hanno evidenziato la crisi politica, economica ed etica, sottolineando la crescente mancanza di fiducia nelle istituzioni. «Noi siamo qui come mediatori, chiamati a cambiare questa situazione attraverso il dialogo e la fraternità», ha detto Sergio Previdi, presidente nazionale del MPPU.
Sabato 14 marzo. Il “Salão dos Atos” immerso nel verde del Parque Barigui di Curitiba, era affollato da deputati federali, statali, sindaci, assessori, funzionari pubblici, giovani e accademici giunti dall’Amazzonia, dal Nordest, Brasilia e da altre città del Brasile. In quella sala sono risuonate parole insolite: la politica presentata come «“l’amore degli amori”che conferisce agli amministratori pubblici di fare progetti capaci di rispondere alle esigenze della comunità e ai cittadini di realizzare le proprie aspirazioni». È stato ricordato che «il potere conferisce la forza, ma è l’amore che dà autorità». Molte volte è stata ripetuta la parola “fraternità”, non solo quale principio etico della politica, ma come “la sua sostanza”. Sono questi i punti centrali del pensiero di Chiara Lubich, che Maria Voce, presidente dei Focolari, ha citato nel suo messaggio e che sono stati approfonditi nei vari interventi. Questa visione della politica che Chiara stessa aveva proposto, anni fa, nei parlamenti di vari Paesi, oggi è apparsa come una luce nel tunnel della crisi che attraversa il Brasile. Ha risvegliato nuova speranza, perché molti sono stati i testimoni che ne hanno mostrato l’attuazione, non solo in Brasile, ma anche in altri Paesi. Un panorama innovativo, presentato nel video-documentario all’inizio dell’evento promosso dal Movimento Politico per l’Unità (MPPU) espressione dei Focolari, nel 7° anniversario della sua morte. L’incontro ha avuto luogo in concomitanza di due manifestazioni popolari di segno opposto e molti degli interventi hanno evidenziato la crisi politica, economica ed etica, sottolineando la crescente mancanza di fiducia nelle istituzioni. «Noi siamo qui come mediatori, chiamati a cambiare questa situazione attraverso il dialogo e la fraternità», ha detto Sergio Previdi, presidente nazionale del MPPU.  «Questa è una grande sfida. La democrazia non è solo un fatto tecnico, ha bisogno di un’anima. Dobbiamo ripensare la politica per poterla riumanizzare», ha affermato Gustavo Fruet, sindaco di Curitiba. Ed ha citato l’innovativa cultura politica espressa da Chiara, dalla quale trae ispirazione il programma 2010-2030 per far di Curitiba “una città innovatrice globale”, già riconosciuta quale modello di pianificazione sostentabile e come “città della fraternità». Molti gli interventi di deputati e assessori di diversi partiti che cercano, non senza fatica, di attuare una politica contro-corrente che hanno testimoniato come attingono dal MPPU “nuova forza e nuovo impegno”. «Fraternità significa attuare una strategia di unità, cercare il dialogo tra maggioranza e opposizione, tra istituzioni e società, nella comune ricerca del bene comune», ha affermato il sindaco di Sorocaba, Antonio Carlo Pannunzio. Julio Carneiro del MPPU Brasile, ha citato le cittadelle fondate da Chiara Lubich (oggi più di 20) quali bozzetti-modello di città, per testimoniare l’incidenza della fraternità nella convivenza civile. «Una nuova cultura politica richiede uomini nuovi», ha affermato il prof. Marconi Aurélio Silva, evidenziando l’urgenza della formazione dei giovani alla cittadinanza attiva, basata sulla fraternità: «essendo noi per natura esseri relazionali e non individui isolati». Ed ha parlato dei molti frutti della Scuola Civitas in molti stati del Brasile e del mondo. Para saperne di più: www.mppu.org.br – www.focolares.org.br (altro…)
«Questa è una grande sfida. La democrazia non è solo un fatto tecnico, ha bisogno di un’anima. Dobbiamo ripensare la politica per poterla riumanizzare», ha affermato Gustavo Fruet, sindaco di Curitiba. Ed ha citato l’innovativa cultura politica espressa da Chiara, dalla quale trae ispirazione il programma 2010-2030 per far di Curitiba “una città innovatrice globale”, già riconosciuta quale modello di pianificazione sostentabile e come “città della fraternità». Molti gli interventi di deputati e assessori di diversi partiti che cercano, non senza fatica, di attuare una politica contro-corrente che hanno testimoniato come attingono dal MPPU “nuova forza e nuovo impegno”. «Fraternità significa attuare una strategia di unità, cercare il dialogo tra maggioranza e opposizione, tra istituzioni e società, nella comune ricerca del bene comune», ha affermato il sindaco di Sorocaba, Antonio Carlo Pannunzio. Julio Carneiro del MPPU Brasile, ha citato le cittadelle fondate da Chiara Lubich (oggi più di 20) quali bozzetti-modello di città, per testimoniare l’incidenza della fraternità nella convivenza civile. «Una nuova cultura politica richiede uomini nuovi», ha affermato il prof. Marconi Aurélio Silva, evidenziando l’urgenza della formazione dei giovani alla cittadinanza attiva, basata sulla fraternità: «essendo noi per natura esseri relazionali e non individui isolati». Ed ha parlato dei molti frutti della Scuola Civitas in molti stati del Brasile e del mondo. Para saperne di più: www.mppu.org.br – www.focolares.org.br (altro…)
Ungheria: accoglienza di profughi in viaggio da mesi
https://vimeo.com/121042026 (altro…)

